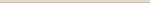
Opera omnia
LIBRI
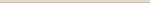
Porto d'Adda
Consuetudini... Valtravaglia
Robbiano Brianza
Misura... di Vimercate
Cornate d'Adda
Appunti storici
Il congresso di Pontida...
Barzanò
Agliate e la sua basilica
Pagine di storia briantina
|
 |
PAGINE DI STORIA BRIANTINA
Como 1972
PREMESSA
Cesare Cantù scrisse che la Brianza è denominazione della quale " non si conosce né l'origine, né il significato, né i limiti " (*). L'asserzione, così recisamente negativa dell'illustre storico, un brianzolo di Brivio, m'invogliò ad indagare se proprio nulla si potesse conoscere.
Le mie ricerche, oltre alle opere a stampa, si rivolsero agli archivi e in modo particolare a quello di Stato in Milano. Non ho la pretesa di aver potuto consultare tutto. I documenti sono raccolti sotto tante voci diverse che possono facilmente sfuggire. Chi riprenderà questa mia fatica con ulteriori indagini, potrà ancor meglio chiarire e precisare.
Questa breve monografia è la ristampa, ampliata e qua e là riveduta, di quanto ebbi già a pubblicare altrove.
Ho diviso il lavoro in due parti: nella prima tratto del luogo di Brianza, nella seconda del territorio briantino.
Brianzolo di nascita, mi valga l'amore alla Brianza.
* C. CANTU', Grande Illustrazione del Lombardo-Veneto, Milano 1857, vol. 3, p. 903; Idem, La Brianza in Opere Minori, Torino 1864, vol. 1, p. 435.
LA BRIANZA NELLE SUE ORIGINI
E NEI SUOI LIMITI
I
IL LUOGO DI BRIANZA
1. Brianza. - 2. Suo significato. - 3. Sue origini. - 4. Leggende e loro valore. - 5 Ritrovamenti di antichità. - 6. Il sepolcro di Merebaudo. - 7. Le decime. - 8. Indizi di un castello. - 9. La parrocchia. - 10. Perché Brianza legò il suo nome al territorio circostante.
1. - Brianza, piccola frazione della parrocchia di Nava e del comune di Colle di Brianza, sorge sul colle dello stesso nome, il quale si distacca dal vicino monte di S. Genesio. Chi ascende dal sottostante Pecastello incontra innanzitutto il luogo tradizionalmente chiamato Porta Vedra, posto tra l'estremo limite di una selva castanile e di campi lavorati nei quali si scoprirono delle antichità come si dirà più avanti. Più nulla oggi rimane a segnare quel luogo se non una croce di legno piantatavi dal parroco D. Domenico Manzoni (1).
Di un cascinaggio di Porta Vedra, del quale fanno parola il Bombognini, il Redaelli e l'Ignazio Cantù, oggi non solo non c'è più nulla, ma della sua esistenza niente mi è risultato da vecchie e recenti carte dell'archivio parrocchiale di Nava e da altre
fonti (2).
Salendo per il viottolo alquanto più in alto, incontriamo la chiesa di S. Vittore con le annesse due case coloniche, delle quali una fu anticamente residenza dei parroci di Brianza, e finalmente sula cima del colle la torre con campana, iperbolicamente detta campanone, la quale prospetta la valle di Rovagnate, e poco lungi si scorgono gli avanzi di una antica chiesetta dedicata a S. Stefano.
2. - Che significa Brianza? Brianza significa altura, poiché la sua base etimologica non può essere altra che la celtica brig - (altura, collina, monte); quella base etimologica da cui derivarono Briançon e tanti altri nomi (3). È l'etimologia che, finora, ha trovato maggior credito fra i più autorevoli studiosi. Il nome dev'essere stato dato per probabili abitazioni sull'altipiano di quel cole o monte, o fors'anche per l'antico villaggio di Brianzola, o Brianzora come dicevasi anticamente, che si incontra sulla costa del monte alquanto sopra Dolzago.
Con questo verrebbero a cadere le interpretazioni - talune bizzarre - nelle quali gareggiarono vecchi e moderni studiosi della Brianza, non esclusa quella che vorrebbe far derivare Brianza da Barrianza, come a dire paese di Barra, innnanzi a Barra (4), perché pur ammettendo che Bar - in lingua gallo celtica, possa indicare altura (5), non può corrispondere tuttavia a verità a mio avviso, il far derivare da Barra, attraverso la modificazione Barrianza, il nome di Brianza.
Ed infatti, mentre da una parte nulla sappiamo della città di Barra, all'infuori del breve cenno lasciatoci da Plinio (6), né dove edificata, né quando distrutta, tanto che qualcuno la volle situata a Bergamo o nel suo territorio o altrove invece che sul Montebarro (7); dall'altra il nome di Barrianza, per Brianza, non risulta in nessuna carta, e negli scritori appare soltanto verso la metà del secolo XVIII col Sormani e coll'Allegranza (8).
Comunque sia, il documento più antico, ch'io conosca, nel quale per la prima volta si accenni a Brianza è del 16 agosto 1107, col quale la vedova del milanese Azzone Grassi dona, per la fondazione del monastero cluniacense di S. Nicola in Figina di Villa Vergano, i suoi possedimenti che aveva a Brianza fino al luogo detto in Figina: " omnes res territorie iuris mei quas habere visa sum in loco et fundo seu monte qui dicitur Brianza ad locum ubi dicitur Infigina "... " in quo scilicet loco de suprascripto loco Brianza ad jam dictum locum qui dicitur Infigina " (9).
Altra carta è il diploma di Federico Barbarossa del 27 aprile 1162, col quale quell'imperatore, favorendo Algiso abate del monastero di Civate suo fedelissimo partigiano, prendeva sotto la sua protezione il monastero con tutte le sue possessioni: castelli, ville e luoghi, e cioè ben 36 località, senza tener calcolo di altre il cui nome è illeggibile per macchie e rotture nella pergamena: " possessiones universas, castella videlicet, villas et loca, scilicet Clavadem (Civate), Barnium (Barni), Suellum (Suello), Sezanam (Sesana), Canzum (Canzo), Madaxanum (Maisano frazione di Valbrona), Belaxium (Bellagio), Sala (Sala al Barro), Galbiatem (Galbiate), Mezanam (Mozzana), Bartexagum (Bartesate), Verganum (Vergano), Consonnum (Consonno), Tozi (probabilmente Toscio di Villa Vergano che Dozio di Valgreghentino), Ellum (Ello), Imbadum (Imberido frazione di Oggiono), Navam (Nava), Brianzam (Brianza), Callam (Cella), Beveratem (Beverate frazione di Brivio), Polianum (?) (non risulta, ch'io sappia, nella Martesana una località antica con questo nome: che si tratti forse di Polgina vicino a Villa Vergano? Ad ogni modo è da escludersi, a mio credere, Pogliano in pieve di Nerviano, poiché come dal contesto si tratta di terre martesane), Annonem (Annone), Uglonum (Oggiono), Pescelagum (Peslago in comune di Oggiono), Montexellum (Monticello presso Casatenovo o Monticello in parrocchia di S. Zeno pieve di Brivio?), Trescanum (Trescano frazione di Oggiono), Cadonum (Cavonio in territorio di Dolzago), Viganorem (Viganò presso Missaglia o Vianò (Viganore) di Renate Brianza?), Suzanorem (Sizanò di Oriano Brianza), Retenadem (Renate Brianza, detto in carte dei secoli XII-XIII Retenate, oppure Retenate in comune di Vignate? Benché sul finire del secolo IX o nei primi anni del X il monastero di Civate possedesse beni in Vignate, tuttavia, dall'insieme del documento, non si può escludere che possa essere Renate Brianza), Tremoladem (Tremolada frazione di Veduggio), Menzonigum (Menzonico frazione di Villaraverio), Marexum (Maresso), Cusanum (Cusano in pieve di Desio), Belluscum (Bellusco in pieve di Vimercate), Albinganum (Albingano, vicino a Cassano d'Adda, in pieve di Corneliano estremo limite a sud-est della bassa martesana) (10).
I nomi furono in parte alterati, non essendo pratici dei luoghi, o dallo stesso cancelliere tedesco che stese l'atto originario oppure da chi trascrisse la copia rimastaci del diploma imperiale. Fatto del resto che si verifica, anche più tardi, in atti redatti da milanesi, come ad esempio per chi trascrisse nei Registri Ducali la concessione dei privilegi di Francesco Sforza al Monte di Brianza nel 1451.
Che Briantia o Brianza sia stata la forma d'uso per lo meno fin dal secolo XII lo si ha, oltre che dall'atto del 1107, dagli scrittori più antichi, come ad esempio dal Liber Notitiae Sanctorum Mediolani compilato sul finire del secolo XIII, o nei primi anni del seguente, su di un lavoro di Goffredo da Bussero (ora smarrito), scritto verso la metà del secolo XIII, e dalle Cronache del Fiamma (secolo XIV).
Brigantia, per Brianza, entra in campo con gli umanisti del secolo XV, e dedotta, a quanto sembra, da leggende delle quali si dirà più avanti. Ma non prese consistenza nell'uso, e finì per scomparire. Nondimeno, ammessa la radice gallo-celtica brig -, potrebbe fors'anche darsi sia stata una forma precedente del nome di Brianza, ma ci mancano prove per confermarlo. Non si conoscono finora reperti archeologici o pergamene prima del mille, o intorno a quel tempo, con accenni al nome del luogo o del colle.
3. - Chi furono i primi abitatori del luogo di Brianza? Dall'etimologia del nome come si è detto, sembrerebbero i Gallo-Celti. Tombe galliche e gallo-romane non mancano infatti nel territorio brianteo. Inoltre non pochi nomi della regione si vorrebbero di origine gallo-celtica.
I Celti provenienti, come ritiensi comunemente dalle rive del Baltico o dalle sponde del Danubio, verso la metà del VI secolo avanti Cristo, arrivarono sul Reno; più tardi, e cioè verso l'anno 450, il grosso della nazione si stabiliva nel nord-est della Gallia, in Svizzera, e nel sud della Germania. Nell'alta Italia i Galli (Celti) giunsero circa l'anno 400 avanti Cristo. Sembra tuttavia che già in antecedenza elementi celtici si spingessero fino ai nostri laghi (11). I Galli stanziatisi su le nostre terre si chiamarono Insubri, ed ebbero Milano per capitale.
Delle popolazioni preistoriche, le quali abitarono la Brianza prima dell'invasione gallo-celtica, (si parla di Orobii, di Liguri, ecc.), rimangono tuttora avvolte in grave oscurità (12).
I Galli stanziatisi su le nostre terre si chiamarono Insubri, ed ebbero Milano per capitale.
4. - Intorno al luogo di Brianza fiorirono non poche leggende. Si suol dire da taluni che ogni leggenda contiene sempre qualche cosa di storicamente vero. Ciò non è in tutto esatto, perché se da una parte non mancano leggende le quali constano di fatti storici ma deformati da elementi estranei o favolosi, dall'altra ve ne sono pure molte le quali altro non sono che pura fantasia benché applicate ad un oggetto storico o reale. Si noti ancora che produttore di leggende non è sempre e solo il volgo, ma altresì eruditi fantasiosi o creduloni, e da questi talora scendono e si divulgano nel popolo. Il volgo e questa sorte di eruditi, facilmente poi le alterano a gara facendole passare di bocca in bocca o da uno scritto in un altro, rielaborandole secondo il proprio genio. Non è sempre però facil cosa il sapere distinguere ciò che è parto genuino dell'anima popolare da quello che in origine è opera d'uno scrittore.
In ordine di tempi, la leggenda più antica è quella presentataci dal Fiamma (1283 † 1344) nelle sue Cronache, e cioè che un Troiano, chiamato Briono, fondasse su quel colle la città di Brianza (13), e che molti secoli dopo i milanesi la riducessero in loro potere per avere aderito a Federico Barbarossa (14).
Con gli umanisti, entrano in campo altre leggende. Alcuni vollero che il territorio briantino fosse chiamato Brianza dal greco briào che significa altura, cioè elevato di colline, ovvero, sempre derivando dal greco, perché gli abitatori erano gente forte e robusta. Altri dissero che questa regione fu nominata Brigantia dai soldati di Federico Barbarossa, per averla trovata piena di ameni colli che producevano buoni vini a somiglianza dei colli che sorgevano intorno al lago di Brigantio (oggi detto di Costanza) (15).
Né va dimenticato Ortensio Landi, il quale scrisse che la città di Brianza fu edificata dagli Spartani, e detta Urianza da urio, voce greca che vale scaturisco, perché vi era ogni ben di Dio utile alla vita umana (16).
Nella prima metà del secolo seguente il Ripamonti (1373 † 1641), brianzolo nativo di Tegnone, frazione di Nava, trattando del Monte di Brianza, non fa che ripetere, nel complesso, quanto scrissero il Fiamma, il Merula, e Tristano Calco nella sua Historia Patria, libro IX (17).
Col passare degli anni, al posto di elementi ripudiati o tramontati, ve ne subentrarono altri nuovi non meno leggendari.
Mentre il Torri presentava la strana opinione che i brianzoli si chiamassero tali
" per essere forse stati proprietà di quel Briante che seppe formare la superba Pirra ad Artemisia, conservatrice dell'ossa di Mausolo " (18), il Bombognini, il quale attinse ai manoscritti di Paolo Antonio Sirtori (19), ci fa sapere che il luogo di Brianza " fu secondo alcuni un'antica Città che serviva di diporto alla regina Teodolinda, il cui Palazzo vogliono fosse situato dove è ora l'antica Torre, da cui pende il rinomato Campanone che serviva per i Comizi. Una delle Porte vuolsi fosse situata in quel Cascinaggio, che ora Porta Vedra si appella, cioè Porta Vetere, ossia antica. Ai piedi del colle dicesi stagnasse un lago dal sito ora detto le Cascinette fino a Peslago. Probabilmente fu questa Città distrutta dai milanesi rimpatriati, perché fautrice del Barbarossa " (20).
Seguirono il Bombognini, più o meno nei particolari, il Breislak, il Rampoldi, l'Ignazio Cantù, il Longoni, l'Amati, ecc. Il Longoni suppose inoltre, come dipinti del tempo di Teodolinda le tracce di alcuni affreschi, rappresentanti scene di caccia, esistenti in una forte dimora presso Brianzola, le quali sono invece del secolo XIV o dei primi anni del seguente (21). L'Amati aggiunse che a Brianza vuolsi si ritirasse S. Ambrogio a meditare sulla religione cattolica nel 387, e che la città la quale esisteva su quel colle potesse corrispondere a quella che Tolomeo chiamò Bretina e Plinio Brintum. (22)
Ritengo, e il lettore ne sarà facilmente persuaso, che non valga la pena di discutere simili leggende. Non consta infatti da nessun scritto veritiero o da ruderi che lassù sorgesse un tempo, più o meno antico, una città od un borgo; ché anzi la situazione del luogo sembra escluderlo.
Neppure corrisponde a verità il dire che le truppe del Barbarossa diedero per i primi il nome alla regione briantina, chiamandola Brigantia. Quei soldati furono certamente più volte nella Brianza in campo contro i milanesi, tuttavia il nome di Brianza esisteva già prima di quel tempo, e l'estensione del nome alla plaga circostante ebbe tutt'altra origine. Similmente pura fantasia è che la città di Brianza servisse di diporto alla regina Teodolinda e che vi avesse un palazzo, e che una delle porte della città fosse situata nel luogo di Porta Vedra. Nessuna prova o serio indizio ci autorizza ad ammetterlo.
Il Redaelli, scrivendo di Brianza sotto il dominio longobardo, esce a dire che
" nullameno è probabile che sino da quei tempi, ed anche precedentemente vi fosse un considerevole aggregato di abitazioni, e che vi fosse un forte castello almeno, come luogo opportunissimo alla difesa, e da ciò può esser derivata alcuna delle tradizioni che dovevamo esporre "; e aggiunge più avanti che forse " caduta Barra, ebbe il luogo ora detto Brianza sino in lontani tempi a divenire ragguardevole, ed essere un forte castello favorito dall'ubicazione, divenuto all'epoca dei Longobardi il capoluogo direbbesi della Brianza, in allora d'assai più ristretti confini " (23). In realtà finora nulla sappiamo, e perciò nulla si può asserire di certo dell'esistenza di un castello nell'epoca longobarda.
Che dire della gran torre e del relativo campanone di cui alcuni, attenendosi alla leggenda popolare e scritta, dissero che funzionava fin dal tempo di Teodolinda per la convocazione dei brianzoli ai comizi, ed altri invece, fantasticando di una repubblica briantea, all'epoca dei Comuni? (24). Tutto è leggenda, e relativamente recente.
Chi poi, come il Rampoldi e il Breislak, racconta che a Brianza si vedevano i vetusti avanzi della gran torre che sosteneva la grossa campana (25), affermò cosa non vera, e perciò negata, dopo sopraluoghi, dal Redaelli e dal Dozio. Altrettanto erronea è l'asserzione del parroco Ponzone di Nava che il coro o abside della chiesa di S. Vittore sia stata aperta in una torre antichissima, forse tratto in inganno dallo spessore del muro (26). A convincersi che si tratta di una fandonia basta osservare la la costruzione di quell'abside.
L'erezione della torre con campana è da ritenersi del secolo XVII inoltrato e non prima.
Il Redaelli osservò che la torre campanaria sarebbe stata restaurata nei primi anni del secolo XVI, perché vi lesse sul lato occidentale della torre: " Lì 10 agosto 1511 restaurazione ", e pertanto la sua esistenza sarebbe anteriore al 1511 (27). Ma non è verosimile che quella iscrizione si possa riferire alla torre campanaria, poiché sappiamo di certo che al tempo del padre Leonetto Clavono, di S. Carlo, e di Federico Borromeo non vi esisteva alcuna torre con campana. Inoltre quell'iscrizione è così indeterminata che poteva ben riferirsi a qualche cosa d'altro, e il sasso essere usato come semplice materiale per la costruzione del campanile.
Infatti negli Atti di visita del Leonetto del 1567 si ha che la chiesa di S. Vittore non aveva che una piccola campana appesa al solito pilastrello arcuato sopra la porta maggiore, come per lo più si usava allora dappertutto, e la cui fune pendeva da un foro. Oltre a questo negli Atti di visita molto accurati di Federico Borromeo del 1611 vi si dice espressamente che mancava la torre o campanile, e che la campana, detta sonora e grande, stava appesa ad un albero poco distante dalla chiesa. Si vede che nello spazio di tempo intercorso fra il 1567 e il 1611 si era probabilmente pensato dai parrocchiani di Brianza a provvedersi di una campana più grossa, ma non ancora ad erigervi il campanile dove collocarla. Tuttavia se quella campana stava appesa ad un albero non potevasi dire grande, se non in senso molto relativo. Di una torre qualsiasi precedente, con o senza campana, o tracce di essa presso la chiesa o sul colle, non vi è cenno in quegli atti e nemmeno nel Ripamonti (28).
Nel 1747 venne posta ua nuova campana più grossa della precedente, e del peso di 33 rubli di bronzo (29). Nel 1839 guastatasi per una fenditura, fu rifusa e aumentata di peso, finché nel 1878 un Luca Monti, villeggiante a Rovagnate, la volle di maggiori dimensioni, offrendo allo scopo duemila lire. Ma nello stesso anno la torre, che per l'occasione era stata sopraelevata di due metri, si sfasciò, e solo nel 1888 si pensò a ricostruirla come è attualmente, e a riporvi il campanone che per fortuna era uscito incolume dal disastro.
5. - Sgombrato ciò che è puramente leggendario, vediamo ora di fermare la nostra attenzione su altre notizie, le quali, benché ravvolte nell'oscurità di elementi leggendari, ci possono indirettamente fornire qualche lume intorno all'antichità e celebrità del luogo di Brianza.
Innanzitutto dobbiamo premettere che parecchi scrittori ci parlano di tombe e di ruderi lassù scoperti. Il Sirtori nei suoi manoscritti più volte fece cenno " de' rotami che di quando in quando sotterra con i lavoreri si discoprono ". Il Redaelli aggiunge che " nel 1822, secondo le notizie più esatte che potemmo raccogliere, si rinvennero pure molti ruderi nel lato orientale di quei piani, ed anche si scoprì un sepolcro, in cui conservasi ancora per intiero il cadavere ed eranvi alcune lettere in una delle pietre che formavano quel tumulo ", e che tutto andò disperso senza che alcuno avesse cura di esaminarle; e più avanti osserva che " il ritrovarsi di frequente delle ossa umane qua e là, dobbiamo soltanto ragionevolmente credere, che v'abbia avuto luogo qualche fatto d'armi, onde siansi fatte delle tumulazioni dove pur si poté " (30).
Veramente, riguardo a ritrovamenti qua e là di ossa umane, si potrebbe osservare che nel medioevo la chiesa di S. Vittore con quella annessa di S. Giovanni Battista, e le altre due di S. Stefano e di S. Nazaro oggi scomparse, avranno avuto presso di sé delle sepolture come usavasi in quei tempi. Un coperchio di serizzo d'un sarcofago lo si vede tuttora in un campicello presso le case coloniche, e un altro simile fu trasportato a Nava per servire al lavatoio, come mi affermò il parroco Manzoni.
Ma c'è dell'altro. Verso il 1864, così mi ebbe ad asserire in iscritto ed a voce lo stesso parroco, in occasione di scavi per cavare sabbia da fabbrica, si scoprì presso Porta Vedra, e cioè in quel terreno a coltivo che giace a sinistra dell'ultimo svolto che fa la strada, che da Pecastello conduce a Brianza, terreno che è quasi a livello della detta strada, che poi quasi subito va declinando ad est per incontrare il piano del Poncione, una tomba alla profondità di quattro o cinque metri. Lo scheletro, che portava l'elmo, era di statura gigantesca, e giaceva entro muri, come in una specie di stanza, con molti ornamenti d'oro. Dove siano andati a finire quegli oggetti, i qual furono in gran parte consegnati al parroco di allora, Agostino Acquistapace, non si conosce. Durante quegli scavi fu trovato una moneta di Enrico IV ed un'altra di Federico Barbarossa (31).
Queste scoperte sarebbero riuscite di non poca importanza per la storia del luogo, se si fosse potuto fare uno studio intorno alle medesime, prima che andassero disperse. Ad ogni modo il lettore si avvede subito che da tutte queste notizie - così come sono narrate -nulla si può conoscere dei relativi avvenimenti.
6. - Lo storico Giuseppe Ripamonti, nativo del luogo e perciò in grado di potere conoscere gli avvenimenti locali, scrisse, fra l'altro, che il colle di Brianza " fu sede un tempo di re e valida fortezza, il che attestano pietre con scettri scolpiti e tavole di marmo non ha guari scoperte, e mole di sassi quadrati, e parimenti i nomi delle porte, e i paesi che vi stanno alle falde cioè Colonia e Piecastello. E di più i nostri maggiori videro il sepolcro dell'ultimo re quando sulla cima di questo colle si scavarono le fondamenta della chiesa " (32). Il Ripamonti, attraverso queste espressioni, che hanno del vago e del fantastico, ci afferma nondimeno una cosa realmente avvenuta sul colle, e confermata dall'Alciati.
Al padre Leonetto Clavono, venuto il 21 ottobre 1567 a visitare la parrocchia di Brianza delegato da S. Carlo, venne narrato quanto segue.
Al tempo del marchese del Vasto, allora governatore dello Stato di Milano, giunse a Brianza un mago il quale parlò al curato di un tesoro nascosto, e che glielo avrebbe fatto conoscere a patto gliene fosse data la metà. Il mago voleva però che il curato gli desse prima l'ostia consacrata nella scatola. Il curato a questo non volle acconsentire. Allora il mago gli disse: benché non mi vuoi dare l'ostia tuttavia ti faccio sapere che il tesoro è sotto l'altare della chiesa di san Vittore; cerca con diligenza e troverai quattro colonnette marmoree con due vasi di marmo bianco e certe monete di piombo: quando tutto questo avrai trovato sappi che lì vicino ci sarà il tesoro. Il mago stette per una notte in casa del curato, parlottando tra sé durante la notte una lingua incomprensibile, e quindi partì indispettito perché gli era stata rifiutata l'ostia. Il curato, con l'aiuto di altre persone, prese una notte a demolire l'altare, ma scatenatosi all'improvviso un furioso temporale con acqua, grandine e fulmini se ne fuggì dalla chiesa: e questo fu la notte seguente alla festa di S. Antonio nel mese di gennaio.
La notte seguente si riprese a scavare, e sotto l'altare si rinvenne una lapide di marmo bianco sostenuta da quattro colonnette nel mezzo delle quali vi erano due vasi marmorei, uno sopra l'altro, ma nei quali non c'era nulla. Quei due vasi erano a loro volta sostenuti da un' altra lapide sotto la quale vi erano circa 79 monete incastrate in calce durissima, le quali erano " valde ponderose rotunde latitudinis palmi et crassitudinis digitorum quatuor ". Il curato si recò allora a Milano, portando al marchese del Vasto le monete che, secondo l'opinione del mago, si ritenevano di piombo. Si continuò poi con somma diligenza nello scavo alla presenza di alcuni incaricati mandati dal governatore, ma non si trovò " nisi sepulchrum pulchrum in quo erat cadaver sepultum honorifice vestitum cum verbis in lapide sculptis superiori, videlicet: Hic requiescit Merabaudus Dux qui vixit in seculo de anno millesimo trigesimo secundo ". Ed essendosi perseverato a scavare per otto giorni e nient'altro essendosi trovato, i messi del governatore se ne ritornarono a Milano: la buca fu ricolmata di terra e tutto si accomodò come prima. A giudizio del narratore quelle monete dovevano essere d'oro invece che di piombo, nonostante le parole del mago (33).
Chi sia colui che abbia narrato tutto questo al padre visitatore non è detto. Tuttavia questo racconto, benché infarcito di elementi fantastici ed inverosimili, ci offre alcuni dati interessanti. Anzitutto conosciamo il luogo del ritrovamento del sepolcro e dell'epigrafe, cioè a Brianza presso la chiesa di s. Vittore. Che poi tale scoperta sia avvenuta al tempo del marchese del Vasto, governatore di Milano dal 1538 al 1546, lo possiamo ritenere per certo, in quanto Andrea Alciati (1493 † 1550), che fu contemporaneo al marchese del Vasto, ne fece cenno nella sua Storia di Milano (34). Certamente sarebbe stata miglior cosa se il Ripamonti e l'Alciati ci avessero lasciato dati più precisi e dettagliati di quei ritrovamenti.
Riguardo al tesoro esso probabilmente non può essere che una favola popolare per spiegare la scoperta della tomba, per quanto non si possa escludere che siansi rinvenute delle monete, non certamente però delle dimensioni fantastiche attribuitele dal narratore.
Interessante è l'epigrafe. Verosimilmente, a quanto pare, essa fu letta male o per ignoranza o per corrosione di lettere. Un duca o ducato nella Martesana o in Brianza, ch'io sappia, non è mai esistito, e nemmeno un conte o signore rurale col nome di Merabaudo (35). Chi lesse così non deve forse aver capito VC = vir clarissimus, né PM = plus minus: delle due prime lettere fece un Dux e delle altre Anno Millesimo.
L'epigrafe si potrebbe ricomporre così:
HIC REQUIESCIT
MERABAUDUS
V.C. QUI VIXIT IN
SECULO ANN. P. M.
XXXII...
Verrebbe perciò a corrispondere, con tutta probabilità, a quella dell'Alciati e riportata dal Muratori e dal Mommsen (36).
HIC REQUIESCIT
MERABAUDUS
V.C. QUI...
........
........
L'epigrafe è cristiana, e, così come vien descritta, non dovrebbe essere posteriore alla prima metà del VI secolo, né anteriore agli ultimi anni del IV (37). La chiesa stessa di S. Vittore, in quanto dedicata a questo santo, potrebbe essere di origini prelongobarde.
Ora chi può essere mai stato questo Merabaudo? Parecchi personaggi di questo nome risultano celebri nel IV e V sec. Nel 375 un Merabaudo o Merobaudo e un Sebastiano conte, generali delle milizie, vennero mandati dall'imperatore Valentiniano in Germania contro i Quadi; e a Merabaudo, personaggio influente, si dovette in particolar modo l'elezione ad imperatore di Flavio Valentiniano Iuniore. Fu console nel 377 e 383, e dall'imperatore Graziano insignito del titolo onorifico di Flavio. In questo stesso anno (383) nelle Gallie, presso Parigi, venne a battaglia contro l'usurpatore Massimo ma con esito sfavorevole. Graziano fu ucciso da Massimo; ma della morte di Merabaudo nulla si conosce: si ignora se ucciso con Graziano oppure tempo dopo fra gli Insubri (38). Il Muratori osserva che se si potesse provare che Merabaudo sia stato ucciso da Massimo fra gli Insubri si potrebbe congetturare che il sepolcro e l'epigrafe siano di questo Merabaudo (39).
La storia ci ricorda ancora un Merabaudo duca di Egitto nel 384, forse, al dir del Muratori, figlio del predetto console (40). Un altro illustre Merabaudo emerge nella prima metà del V secolo. Fu persona nobile, distinta nell'eloquenza e nell'arte poetica. Fu altresì abile generale, e nel 443 mandato dall'imperatore Valentiniano III nella Spagna contro i ribelli Bacaudi, ma per invidia dei cortigiani ben presto richiamato in Italia dallo stesso imperatore (41).
L'appartenenza fin da tempi antichissimi di quel colle alla pieve di Missaglia, benché più vicino ed in più facili comunicazioni con Oggiono, ci fa ritenere che negli ultimi tempi della dominazione romana facesse parte del pago o latifondo di Missaglia, pago che con la diffusione del cristianesimo divenne nel secolo V pieve dedicata a S. Vittore, e probabilmente la più antica della Brianza.
Che poi su quell'altura e vicinanze ci fosse della popolazione ce lo insinuerebbero anche i vicini paeselli di Giovenzana e di Cagliano, i di cui nomi deriverebbero, a quanto pare, dai gentilizi romani di Juventius e Callius.
Missaglia, o Massalia, come si scriveva anticamente deriva da Massa, ossia latifondo vastissimo con località abitate, del quale faceva parte Brianza, di cui era forse signore un Merabaudo.
È pertanto assai probabile, a mio avviso, che a Brianza, presso la chiesuola pur essa dedicata a S. Vittore come la plebana, sia stato sepolto o sul declinare del IV secolo ovvero nella prima metà del seguente un Merabaudo o Merobaudo, personaggio illustre, sia esso uno dei soprannominati od altro della medesima stirpe.
Come ben vede il lettore, si intravedono avvenimenti lontanissimi intorno al colle o monte di Brianza che lasciarono celebrità al luogo, ma che non possiamo precisare data l'oscurità in cui giunsero ravvolti sino a noi.
7. - Un altro fatto attira la nostra attenzione. Il Corio nella sua Storia di Milano accenna ad un documento dal quale risulterebbe che papa Gelasio I nel 493 avrebbe concesso a Teodoro, vescovo di Milano, il diritto di decima in molti luoghi e fra questi i monti di Brianza (42). Il documento, come ebbe ad osservare Cesare Cantù, non ha apparenza di autenticità, e probabilmente fu finto più tardi, " quando all'empia ragione del brando cercavasi opporre la debil salvaguardia di vetuste concessioni " (43).
Che in realtà gli arcivescovi di Milano abbiano riscosso decime in Brianza non ho trovato in nessuna carta o memoria antica. Sta invece che il beneficio parrocchiale di Brianza doveva ogni anno, per antica consuetudine, alla mensa arcivescovile lire due imperiali, onere che nel 1896 il parroco Manzoni affrancò conseguando alla mensa il capitale corrispondente: antica consuetudine della quale, egli mi disse, non si conosceva l'origine. Tuttavia, senza bisogno di riportarsi al privilegio di papa Gelasio I, quell'onere poteva fors'anche essere originato dalla posteriore concessione arcivescovile dell'erezione della parrocchia o da lasciti di privati al beneficio: esempi consimili non sono infrequenti nella nostra diocesi.
Comunque sia del privilegio di Gelasio I, è certo che la chiesa di San Vittore in Brianza riscuoteva da tempo immemorabile le decime dai paeselli e cascinali circostanti in largo giro di territorio (Nava, Piecastello, Brianzola, Hoe, Tremonte, Fumagallo, Porcarezia, Tegnone, Campsirago, Mondonico, Monticello, Giovenzana, Cagliano, Sala, Crescenzago, Perego, Rovagnate, Bevera, Caraverio, Boffalora, Prestabio, Nilone, Siraga, Molino Valsorda), come si rileva da una carta del 30 agosto 1571 e dalle ordinazioni lasciate da S. Carlo nella sua visita pastorale, decime in gran parte cadute in disuso, e di cui il santo aveva imposto l'adempimento in forza della consuetudine e di quei pochi istrumenti e confessi sfuggiti alla dispersione (44).
I più antichi istrumenti di cui vi è cenno sono del 1329. Quelle vecchie carte non si poterono più ritrovare, per quanto anche nelle visite successive si intimasse ai parroci di rintracciarle. E fu vera sfortuna, perché, nella penuria di documenti antichi riguardanti la Brianza, si sarebbe potuto ricavare, sia pure indirettamente, qualche dato interessante.
Quel luogo impervio e disabitato, poiché non vi dimorava che il sacerdote beneficiato e un colono, era divenuto centro parrocchiale, a differenza della vicina Nava o di altri villaggi più popolati o più comodi, appunto perché quei paesi dipendevano in precedenza dalla chiesa di Brianza. Ed infatti dalla sopra citata nota dei luoghi tenuti a pagare la decima, si rileva che si esigeva da tempo antichissimo, perché gli atti del 1329 parlano non di istituzione ma di ricognizione. È quindi evidente che assai antica era la preminenza che la chiesa di s. Vittore esercitava sui villaggi circostanti.
Quale l'origine di quelle decime? Erano sacramentali o dominicali? Non saprei dire in mancanza di documenti.
Forse erano sacramentali, cioè offerte a cui si obbligavano i fedeli verso i ministri del culto per compensarli dei loro servizi spirituali. La parrocchia o cura di Brianza, al dir del Dozio, sarebbe stata canonicamente eretta nel 1429 (45), ma le decime erano percepite anteriormente, e questo perché la chiesa di Brianza, se non di diritto, doveva già da tempo esercitare effettivamente una tal quale cura d'anime, data la lontananza e le non facili comunicazioni con la plebana di s. Vittore in Missaglia.
In una vertenza del 1468 tra il rettòre di Brianza e gli uomini di Prestabio e di Hòe per questione di decime, si ha che quegli uomini cercavano di sottrarsi col sostenere che essi le pagavano al rettòre di Brianza non in quanto tale, ma perché celebrava o faceva celebrare nella chiesa di Hòe la messa festiva e due feriali nella settimana, le quali decime non erano estimate, ma semplicemente offerte volontarie. Quei di Prestabio e di Hòe probabilmente coltivavano la velleità di rendersi indipendenti, avendo in luogo per il servizio religioso i Padri Serviti ai quali, con istrumento del 12 aprile 1456, avevano donata la chiesa di Hòe (46), e tanto più che Rovagnate e Perego costituivano già un'unica rettoria della quale era investito il prete Matteo de Dozio.
Il rettòre di Brianza, Antonio D'Adda, intentò causa perché fosse riconfermato l'obbligo di tali decime spettanti al beneficio o rettòre di Brianza.
Furono chiamati a deporre parecchi testimoni. Orbene, tra gli altri, due vecchi affermarono con giuramento di aver conosciuti i preti investiti del beneficio di
s. Vittore e s. Giovanni Battista in Brianza, e cioè un Pietro Flore e i suoi successori Gabriele Mauri, Antonio d'Adda, passato prevosto a Missaglia, ed il presente Antonio d'Adda, canonico di Missaglia e nipote del precedente, al quale lo zio aveva rinunciato la rettoria di S. Vittore di Brianza, i quali esercitavano la cura d'anime (qui exercebant curam animarum) e vi percepivano le decime. Ma non specificarono gli anni di durata di ciascuno di quei sacerdoti. Più precisa fu la deposizione del prevosto di Missaglia, il quale dichiarò che il suo immediato predecessore fu rettore per 28 anni e più, e che egli lo fu per circa 44 anni, avendo poi solennemente ninunciata tale rettoria da tre anni circa a suo nipote, e che sempre riscossero tali decime in quanto rettòri, rimaste sospese solamente per un certo lasso di tempo in causa del terribile saccheggio compiuto nel 1447 dai veneziani nel Monte di Brianza. Ora, partendo dal 1468 e in senso inverso calcolando gli anni di rettoria di Gabriele Mauri e dei due D'Adda, si arriva, anche senza tener calcolo degli anni imprecisati di Pietro Flore, oltre i primordi del secolo XV. Data la vastità della cura di Brianza, i rettòri tenevano in aiuto, per la cura d'anime, dei cappellani coadiutori (47). Il rettòre, in origine, fu qualche cosa di mezzo tra il cappellano beneficiato e il parroco propriamente detto quale fu costituito con il Concilio di Trento.
Ma perché fu scelta la chiesa sul colle e non un'altra in località più comoda?
Se si potesse provare che il luogo di Brianza sia stato nel medioevo centro di una corte signorile, si potrebbe anche pensare che le decime fossero di origine dominicale. È noto come i signori obbligavano talora i loro dipendenti a portare alla cappella del castello quelle decime che, secondo i cànoni, spettavano alla chiesa plebana da cui dipendevano ecclesiasticamente, dando nella propria cappella il comodo servizio religioso per il quale invece sarebbero stati tenuti a recarsi con maggior frequenza alla lontana plebana (48). Decime che poterono continuare ad essere riscosse dalla chiesa di Brianza anche dopo le riforme che cercarono di togliere questo ed altri abusi.
8. - Alcuni scrittori hanno infatti insinuato che lassù, presso Porta Vedra, sorgesse in lontani tempi imprecisati, se non una città, per lo meno un castello.
È un'opinione che potrebbe trovare appoggio in alcuni indizi.
Di questi uno si potrebbe ravvisarlo nel nome di Pecastello, vale a dire ai piedi del castello, nome che porta un gruppo di vecchie case situate alle falde del colle. Un secondo lo si può vedere nella descrizione dei fondi di proprietà della chiesa di Brianza, compilata in occasione della visita pastorale di Federico Borromeo, del 14 luglio 1611, dove è descritto il ronco di S. Stefano di 42 pertiche e 8 tavole che confinava coll'orto vecchio detto " al castellazzo " (49). Un altro indizio potrebbero essere quegli avanzi di muri che si vedono affiorare dal terreno presso Porta Vedra e in qualche altro punto nei campi del Poncione, ed anche là dove sembrano cingere questi campi dalla sottoposta selva, campi nei quali, come si è detto, scavando sabbia nel 1864 venne scoperto un sepolcro con le sue spoglie. Altro elemento sarebbe il nome di Porta Vedra, benché nessuno di coloro che ne scrissero videro mai avanzi di questa porta, e nessun cenno della medesima ho rintracciato né in carte né in scrittori anteriori al Ripamonti: costui, per il primo, accennò ai " nomina portarum " senza specificarne alcuna. Le due monete di Enrico IV e di Federico Barbarossa, che diconsi lassù rinvenute, per sé non ci dicono nulla.
Supposta pertanto come verosimile l'esistenza di un castello o di una forte dimora qualsiasi, quando sorse? chi l'abitò? quando fu distrutta?... Tutto è muto.
Il Redaelli, come abbiamo già detto, non fu alieno dal congetturare che non solo nell'epoca longobarda, ma altresi in precedenza vi fosse un castello (50).
Il Dozio si accostò a questa opinione. " Poniamo dunque - scrive - tra i sogni e le anili fole quel troiano Brianto e quel lungo soggiorno di Re sul colle di Brianza.
Quei fondamenti poi di stanze regie e di torri io non dubito di pigliarli per gli avanzi di un vecchio castello che sorgeva un dì sul vertice del colle, forse edificato fin dai tempi assai remoti, poi, com'è verosimile, ai tempi dei Longobardi posseduto da qualche signore di questa nazione; ché ad opera longobarda io vorrei attribuire la dedicazione della chiesa di Brianza in onore di s. Giovanni Battista, scelto, com'è noto, a speciale protettore di quella nazione " (51).
Se non che, come ognun vede, siamo dinnanzi a nient'altro che a delle supposizioni. Di certo nulla si può dire non solo per l'epoca prelongobarda e longobarda, ma nemmeno per i secoli seguenti. Che anzi le espressioni " in loco et fundo seu monte qui dicitur Brianza " dell'atto del 1107 sembrerebbero escludere la presenza di un castello (castrum).
" Pare - continua il Dozio - che all'epoca del Barbarossa sul colle di Brianza non sorgesse altro che il castello con l'oratorio e i casolari: su questi in tutto o in parte vi aveva dominio e giurisdizione il monastero di Civate: perocché Brianza è accennato insieme ad altri casali e villaggi nel diploma di Federico: uno di quei castelli di che quasi ad ogni miglio erano sparse le nostre colline nel medioevo ".
E soggiunge che il castello doveva sorgere nei campi del Poncione presso Porta Vedra " nei quali sono reliquie ancora sparse qua e là di antichi edifici, e qui io credo fermissimamente sorgesse l'antico castello, al quale appartenne, siccome è verosimile, quella porta (ad portam veterem), e quei campicelli sono detti del Poncione, perché fatti dissodare a spese di un Ponzone, parroco di Nava ". Il Redaelli vorrebbe invece che " il forte doveva essere sull'estremità occidentale dei piani, che sono sulla vetta del monte, cioè ove trovasi il campanile e la chiesa di s. Vittore, poiché quivi è stato rinvenuto un maggior numero di ruderi " (52).
Senonché riguardo alle ruine che esageratamente si dicevano essere dovunque sparse sul colle, il Dozio stesso che ai suoi giorni vi fu più volte ad indagare, ebbe ad osservare che " sono un'esagerazione o piuttosto son massi e congerie di pietre naturalmente adunate, come può di leggieri avvedersi chiunque studi con diligente lume la natura del terreno del colle e dei colli vicini ". E accennando al terreno declive e piantato a castani che intercorre tra Porta Vedra e il casolare di Brianza, lasciò scritto che " a chi ben lo considera con attento occhio e senza presunzione, si presenta d'una natura, a così dire, primigenia e verginale, sparso di trovanti e di ceppo non mai franto dalla mano dell'uomo, non già di antiche e presenti rovine, come alcuni hanno creduto e scritto " (53).
Mentre da una parte ci consta di un castello a Brianzola, e di una torre a Bestetto, dove le case che formano la punta a sud si chiamano tuttora la torre, fortilizi che dominavano la strada di accesso dal piano che da Dolzago per Brianzola, Bestetto, Pecastello metteva alla cima del colle, dall'altro nessun dato esplicito abbiamo dell'esistenza a Brianza di un castello, all'infuori di alcuni indizi, e nemmeno che fosse poi conquistato o distrutto dai milanesi vittoriosi contro il Barbarossa come asserì il Famma, cronista di scarso credito.
I fatti avvenuti dalla prima calata del Barbarossa in Lombardia fino alla pace di Costanza furono descritti da cronisti diligenti e testimoni di veduta. E questi non fanno mai parola del luogo di Brianza, mentre accennano ad altri villaggi che ebbero parte in quelle fazioni.
Tuttavia il Raul, cronista milanese contemporaneo, ci narra come nel 1160 i milanesi venuti nella Martesana presero Erba, Paravicino, Cesana, " et alia loca "; assediarono il castello di Carcano, e, aiutati dagli abitanti di Erba e di Orsenigo, sconfissero le truppe imperiali a Tassera. Orbene, nell'espressione generica " et alia loca "vi era forse anche la presa e distruzione del castello di Brianza, allora possesso del monastero di Civate il cui abate Algisio era gran fautore del Barbarossa, e che il fatto sia stato per sé stesso di poca importanza da essere passato sotto silenzio?... In caso affermativo l'asserzione del Fiamma potrebbe avere un fondo di verità.
Comunque sia, quello che si potrebbe forse asserire si è che sul colle di Brianza sorgesse in tempi, che non si possono precisare, un forte edifizio, del quale nulla finora ci è dato di conoscere.
9.- Il Redaelli non fu alieno dal pensare che la chiesa di s. Vittore possa essere stata eretta sino dai primi secoli del cristianesimo, per la ragione che s. Vittore fu martirizzato in Milano l'anno 290, e che, essendo tenuto dai milanesi in grande venerazione, gli sarebbero ben presto state erette chiese in città ed in campagna (54). Altrettanto il Bognetti (op. cit.) vorrebbe le nostre antiche chiese dedicate a s. Vittore appartenenti al santoriale prelongobardo. È un'opinione che va presa tuttavia non in senso assoluto ma relativo.
Il cenno più antico ch'io abbia rintracciato rimane quello che si ha nel Liber Notitiae Sanctorum Mediolani della fine del secolo XIII. Sull'ineguale ripiano sorgevano allora quattro piccole chiese dedicate rispettivamente a s. Vittore, s. Giovanni Battista, s. Nazaro, e s. Stefano (55). Segno evidente di una certa qual importanza del luogo in tempi precedenti.
Il Bombognini scrisse che la nobile famiglia Nava fece edificare nel 1340 la chiesa di s. Vittore: trattasi evidentemente di un notevole rifacimento o restauro.
Dall'elenco del Notitia cleri mediolanensis de anno 1398 (56), riguardante le chiese soggette alla plebana di Missaglia, non risulta quella di s. Vittore di Brianza. Probabilmente perché sino d'allora non solo vi si esercitava praticamente una certa qual cura d'anime, ma altresì perché forse godeva di particolari esenzioni. Non saprei dire la ragione per la quale in quel tempo soltanto la cappella di Hòe continuasse a dipendere dalla lontana plebana di Missaglia. Tra i monasteri non vi è inoltre ricordato quello di Cremella perché soggetto alla chiesa Monzese. Si noti che si tratta di una compilazione fiscale, e il fisco, sempre esatto in tutti i tempi, tenne calcolo del fatto che l'unica parrocchiale per tutte le pievi rimaneva di diritto pur sempre la plebana, e che al suo scopo nulla importava che ci fosse già in qualche villaggio più o meno la cura d'anime. Nel 1466 invece dovevano essere già sorte nella pieve diverse parrocchie o meglio rettoríe, benché non siano precisati i paesi, come si ricava dallo
" Status Ecclesiae Mediolanensis anni MCCCCLXVI ", nel quale per la pieve di Missaglia è detto: " Ecclesiae parochiales, Capelle, et Clericatus XXVI " (57).
La cura di Brianza, al dire del Dozio, sarebbe stata eretta canonicamente nel 1429 dalla curia arcivescovile, dietro supplica di quelle popolazioni per la troppa lontananza dalla plebana di Missaglia. Nondimeno una certa qual cura d'anime doveva esercitarsi molto tempo prima di detta erezione, come lascerebbe supporre l'espressione " capellanus et beneficialis " colla quale si designavano nel secolo precedente gli investiti della chiesa di Brianza, espressione che, a mio avviso, se significa qualche cosa di meno del rettòre (beneficialis et retor), significa pure qualche cosa di più del semplice cappellano. E l'avere infatti compreso allora un vasto territorio con villaggi più importanti che non fosse Brianza, ci dice appunto come tra quei paesi e la chiesa di s. Vittore corressero in precedenza dei legami come si può arguire dalla riscossione delle decime.
Al tempo di s. Carlo la chiesa era quanto mai decaduta. Dalla citata visita del padre Leonetto del 1567 - molto importante perché ci fa conoscere la situazione prima delle riforme ordinate personalmente da s. Carlo e da Federico Borromeo - si ha che la chiesa di s. Nazzaro più non esisteva; quella di s. Stefano, con cripta sotterranea, era tutta diroccata, senza tetto, senza altare, e non aveva annesso alcun reddito fisso. La chiesa di s. Vittore è detta antica, coperta di sole tegole, lunga 19 braccia e larga 9. Esternamente l'abside era tutta coperta di edera. Troppo piccola e scomoda per la popolazione della parrocchia, era mal tenuta, con paramenti vecchi che a stento si potevano usare, con un altare piccolo e senza icona, colla bredella rotta, e senza sagrestia: pavimento in disordine, i muri cadenti. Dalla parte sinistra, entrando, si comunicava mediante apertura nel muro coll'annessa chiesina di s. Giovanni Battista, la quale aveva un piccolo altare dedicato al santo: sotto il pavimento si apriva un grande e profondo sepolcro, nel quale si dice che vi seppellivano dei cadaveri. Era anch'essa coperta di sole tegole (58). Il Leonetto ricorda inoltre una scala di pietra, tuttora esistente, ch'egli chiama grande (magna), ma è tutt'altro che grande. È a sinistra della chiesa di s. Giovanni, e serviva per ascendere alla piccola campana situata sopra le porta della chiesa di s. Vittore, o comunque sul tetto delle due chiese. La chiesa di s. Giovanni Battista, probabilmente antico battistero della chiesa di S. Vittore, dopo essere stata usata come sagrestia, come aveva imposto S. Carlo nel 1571, finì ridotta ad uso colonico sotto il parroco Gedeone Ponzone, debitamente autorizzato da Federico Borromeo, con decreto del 17 dicembre 1621 datato da Viganò (Brianza).
Il cimitero, che si stendeva intorno alla chiesa di s. Vittore, era aperto ossia non cintato.
La casa parrocchiale, attigua alla chiesa, aveva corte, portico, stalla, e quattro locali a pian terreno e tre superiori, ma tutti così vecchi e affumicati che necessitavano riparazioni onde un sacerdote vi potesse degnamente abitare: " omnia antiquissima fumo obnigrata et reparatione digna ut honeste a sacerdote habitari possint ". Annessa alla casa del curato vi era quella del colono che lavorava le terre del beneficio, terre che comprendevano tutta la cima del colle.
Non c'erano altre abitazioni.
Parroco era allora D. Cristoforo Brioschi dell'età di circa 71 anni, e soffriva di podagra così che non poteva camminare se non andando a cavallo. Celebrava due volte la settimana sedendo su di una poltrona presso l'altare, e al momento dell'elevazione si alzava sollevandosi sulle grucce. Perciò, benché la parrocchiale fosse quella di s. Vittore, i Sacramenti si amministravano da un cappellano coadiutore nella sottostante chiesa di s. Michele in Nava, di recente costruzione, con tre altari, con campanile e due campane, con cimitero recinto, e in complesso ben tenuta e provvista di paramenti (59).
S. Carlo arrivò quassù per la prima volta nell'agosto del 1571. Era allora parroco Don Francesco Civilini: nel frattempo il Brioschi, per la malattia e perché non godeva troppo buona fama, aveva dovuto rinunciare alla parrocchia, ritirandosi nella casa avita di Pecastello (60).
Il santo ordinò, tra l'altro, che non solo il centro della parrocchia fosse anche di diritto trasferito a Nava e là vi abitasse il parroco nella casa, che gli abitanti vi dovevano al più presto costruire, ma volle ancora che il vasto distretto parrocchiale fosse smembrato in più parrocchie, ciò che infatti avvenne in seguito col card. Federico Borromeo man mano che le popolazioni ebbero i mezzi di adattare chiese capaci e dotarle di congrua prebenda per l'abitazione e il sostentamento del parroco.
10. - In fin dei conti, domanderà il lettore, che cosa si può ritenere per certo del fin qui detto? Questo: che sul colle di Brianza non vi fu mai città o borgo, ma forse, per alcuni indizi, vi sarebbe sorta una forte dimora o castello che dir si voglia. Quando poi sia stato eretta, da chi abitata, e quando distrutta, almeno finora, non si conosce. Dico finora perché non è detto che col tempo non si possano rinvenire documenti od oggetti i quali ci diano maggior luce.
Quello che si può affermare si è che fino da tempi remoti per alcuni fatti realmente accaduti, a noi rimasti oscuri, il colle Brianza divenne un luogo di una certa notorietà e distinzione, e punto di riferimento per i luoghi circostanti. La memoria precisa di quei fatti svanì attraverso le turbinose vicende dei secoli, rimanendo un alone di celebrità vaga, indeterminata, di cui nessuno seppe trovare la consistenza. Da ciò l'avvio alle più strane leggende intorno a quel luogo a preferenza d'altri più popolati e importanti dei dintorni (Nava, Rovagnate, ecc.), e il perché, attraverso i privilegi dei Visconti e degli Sforza, di avere legato offlcialmente il suo nome alla regione circostante, che assunse fiscalmente una individualità distinta nel Contado della Martesana col titolo di Università del Monte di Brianza.
Questo colle sacro alle memorie della Brianza venne ultimamente sciupato dall'edilizia moderna.
* * *
II
IL TERRITORIO BRIANTINO
1. I primi accenni di villaggi riferiti al Monte di Brianza. - 2. Il territorio briantino negli atti officiali. - 3. Immunità ed esenzioni di Bernabò Visconti e successori, e specialmente di Filippo Maria. 4. Francesco I Sforza li conferma ampliandoli. - 5. Il Vicariato brianteo e l'Università del Monte di Brianza. - 6. L'estimo dell'Università brianzola di Francesco I Sforza. - 7. Vicende dell'Università dalla caduta di Lodovico il Moro sino allo stabilirsi del dominio spagnolo. - 8. Carlo V conferma ai brianzoli i loro privilegi. - 9. Soppressione del Vicariato. - 10. Il Monte di Brianza e le riforme di Maria Teresa e di Giuseppe II. - 11. Il contado della Martesana e l'Università del Monte di Brianza soppressi dalla dominazione francese. - 12. I confini della Brianza negli atti officiali del passato nel raffronto con quelli odierni nel'uso dotto e popolare.
1. - Il Dozio, affermando che la parrocchia di Brianza sia stata eretta nel 1429, distaccandola dalla lontana plebana di S. Vittore in Missaglia, ne deduce che a poco a poco si introducesse l'uso di chiamare la regione circostante col nome di Monte di Brianza (61). Ma ciò non regge, perché troviamo già in antecedenza introdotto tale uso; se mai avrà concorso a rafforzarlo.
Nel Liber notitiae sanctorum Mediolani, ossia verso la fine del secolo XIII, mentre la chiesa di S. Vittore e le altre sul colle propriamente detto, si dicono semplicemente " in brianza ", quella di S. Genesio vi è così specificata: " in plebe massalia in monte brianzie ecclesia sancti Genexii ". Questa chiesuola sorgeva sul monte S. Genesio, alquanto discosto e più alto del colle sul quale si adagia il luogo di Brianza. Orbene, lo scrittore col dire " in monte brianzie " intendeva forse designare un luogo che strettamente parlando non era il proprio, ma noto fin d'allora nell'uso volgare col nome di Monte di Brianza? ...
Si noti che in un atto del maggio 960, trascritto dal Dozio nel Cartolario annesso alle sue Notizie di Brivio e sua pieve, è dichiarata " capella sancti genexii in monte suma ".
Più chiaramente il Fiamma nella cronaca Manipulus Florum, compilata verso il 1340, parlando della città di Barra, presso Civate pieve di Oggiono, la pone nel Monte di Brianza, come a dire nelle parti del Monte di Brianza, perché l'Università o comunità briantina, officialmente distinta con tal nome nella Martesana superiore, non esisteva ancora (62).
Nel 1411, il duca Gian Maria Visconti probabilmente per suggerimento di Facino Cane conte di Biandrate, che allora signoreggiava il Monte di Brianza in nome del duca, confermò il 4 agosto le immunità ed esenzioni concesse dal padre suo ai ghibellini della Martesana superiore: la conferma venne fatta sotto il titolo di
" Montis brianzie partium nostrarum Martexane superioris " (63).
L'anno seguente, il 10 luglio 1412, prestarono giuramento di fedeltà, per mezzo di procuratori, al nuovo duca Filippo Maria molti comuni sparsi nell'ambito delle pievi di Oggiono, di Garlate, di Brivio e di Missaglia, e nell'atto dichiarate del Monte di Brianza nel contado della Martesana: " omnia communia Montisbriantie contrate Martescane ". Le località erano le seguenti: Olginate, Garlate, Ospitale, Villa, Capiate, Barzanò, Greghentino, Melianico, Aizurro, Veglio, Biglio (Bulli), Dozio, Consonno, Beverate, Arlate, Imbersago, Robbiate, Paderno, Verdenio superiore, Verderio inferiore, Sartirana, La Cassina, Calco, Olgiate, Olchielera, Monticello (di Mondonico), Mondonico, Casirago (Campsirago), Fumagallo, Cagliano, Giovenzana, Nava, Sarizza, Tegnone (ora Ravellino), Bestetto, Piecastello, Marconaga, Figina, Vergano, Villa Vergano, Ello, Imberido, Oggiono, Castello de Perachi (frazione sopra Oggiono chiamato tuttora castello) (64), Annone, Civate, Dolzago, Cogoredo, Brianzola, Cologna, Beverino, Prestabio, Zerbina, Hòe, Rovagnate, Tremonte, Bosco, Cascinago, Sala (frazione di Rovagnate), Crescenzago, Cereda, Galbussera (Valle bissera), Crippa, Viganò, Monticello (comune presso Casatenovo), Casirago (frazione di Monticello), Casate vecchio, Missaiola, Contra, Tignoso, Missaglia, Cassina Barriani, Cassina d'Albareda (da non confondersi con Albareda di Rovagnate), Cernusco Lombardone, Cremella (65).
Questi documenti ci fanno conoscere come ancor prima del 1429 si dicessero volgarmente del Monte di Brianza, sia pure in modo generico e per riferimento, i villaggi situati per largo giro intorno al colle di Brianza, per cui anche gli altri paesi non nominati delle sopradette pievi si possono ritenere nel Monte di Brianza.
2. - L'uso popolare era senza alcun dubbio anteriore a quello usato nei documenti officiali, perché, come si è già osservato, proveniva da una certa quale celebrità rimasta al luogo di Brianza per antichissimi avvenimenti a noi rimasti sconosciuti.
Tuttavia è da ricordare che negli atti della seconda metà del secolo XIV il territorio briantino non viene specificato che col nome di Martesana o Martesana superiore, e i paesi classificati sotto le rispettive pievi senza alcun riferimento al Monte di Brianza (66). Ed anche nella prima metà del secolo seguente si può affermare che, fino al dominio degli Sforza, i termine ancora prevalente negli atti è quello tradizionale di Martesana o Martesana superiore (67).
|
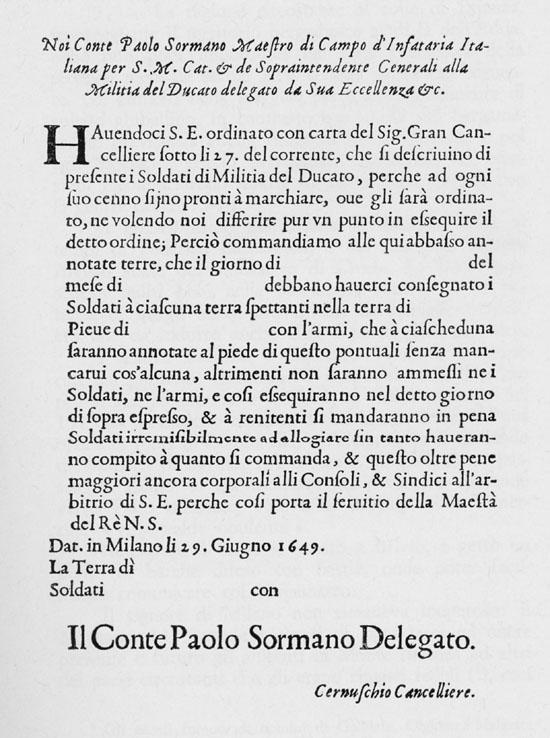
|
|
|
Il conte Paolo Sormani nel 1635 raccolti 4.000 brianzoli fermò presso Lecco
l'avanzata del duca Enrico di Rohan, maresciallo di Francia.
(Collezione privata, Mariano Comense)
|
|
|
|
|
L'uso ofllciale, ripeto, ebbe origine più tardi e per motivi diversi, e cioè dalle immunità ed esenzioni concesse via via a dati paesi, famiglie e persone da Bernabò Visconti e successori, per ultimare ai più ampi privilegi accordati da Franesco I Sforza alle pievi di Oggiono, Missaglia, Brivio con Ronco, Garlate, Agliate oltre il Lambro, alle squadre dei Mauri e di Nibionno (pieve d'Incino oltre il Lambro), e ad altre famiglie o persone residenti o aventi beni in Vimercate e in alcuni villaggi delle pievi di Pontirolo e di Vimercate. Questi privilegi diedero origine all'Università del Monte di Brianza (Universitas Montis Briantie), ossia ad un territorio distinto nel contado della Martesana per ragioni fiscali. L'uso volgare venne in tal modo assorbito e precisato in quello officiale.
3. - La ragione circostante al colle di Brianza, fronteggiante il territorio bergamasco al di là dell'Adda, ebbe non poca importanza nei fatti guerreschi della seconda metà de secolo XIV e nella prima del seguente. Gli abitanti nella maggior parte tradizionalmente di spirito ghibellino, in contrasto con quelli del bergamasco in prevalenza guelfi, rimasero ligi ai Visconti e poi agli Sforza, e perciò privilegiati. Immunità ed esenzioni incominciarono infatti ad essere loro elargite con la guerra del 1373-74.
Il ghibellinismo nel Monte di Brianza risale ai tempi di Federico Barbarossa, e del suo gran fautore Algisio abate del monastero di Civate. La Badia possedeva molti beni nella Martesana superiore. La potenza di quegli abati, provenienti da famiglie feudali, era tale da indurre anche altri a parteggiare per loro.
I fratelli Bernabò e Galeazzo Visconti, scomunicati dal pontefice Gregorio XI e specialmente il primo per le sue prepotenze e crudeltà, si videro attaccati nel 1373 da un esercito crociato diviso in due armate; l'una operante fuori di Lombardia, e l'altra, sotto il comando di Amedeo di Savoia, nel febbraio di quell'anno, passato il Ticino, si era inoltrata nel pavese, e risalendo verso l'alto milanese, veniva ad accamparsi a Vimercate " villa valde opulenta ".
Nell'aprile il conte si spostò a Brivio, e gettò un ponte di barche difeso con bastie, onde poter facilmente comunicare col bergamasco.
Il signore di Milano non rimaneva inoperoso: il 31 marzo 1373 rendeva esenti da ogni tassa ed onere presente e futuro gli abitanti di Monte Brianza ed altri dei paesi circostanti che gli erano rimasti fedeli (68), così che con le sue milizie e con l'aiuto di queste genti ghibelline stava alle coste del nemico, e, senza venire a battaglia, lo tormentava colla guerriglia, rendendogli difficile il rifornimento dei viveri e dei foraggi, e tentando continuamente di distruggere il ponte di Brivio.
Per queste difficoltà, e più ancora per la peste scoppiata nell'esercito, che desolò in quell'anno e nel seguente anche il milanese, e per la mancanza di denaro col quale pagare il soldo alle truppe, il conte di Savoia ai primi di giugno abbandonava definitivamente il milanese.
Bernabò pensò tosto a punire quei della Martesana che si erano, più o meno, apertamente dichiarati per l'invasore, o che dalle circostanze erano stati costretti, sia pure loro malgrado, a favorire in qualunque modo il nemico.
Tutti costoro mise al bando con la confisca dei loro beni. I più compromessi, ben sapendo che col signore di Milano non c'era da scherzare, per aver salva la vita, si erano per tempo allontanati. Quei disgraziati esuli nella maggior parte trovarono rifugio presso Galeazzo, fratello di Bernabò, che mosso a compassione li accolse nel suo dominio (69).
Volle inoltre far vendetta della morte del figlio Ambrogio caduto in uno scontro coi guelfi presso Caprino nell'agosto del 1373. Alla testa delle sue milizie da Brivio penetrò nella Valle San Martino, mettendola a ferro e a fuoco, così che il 23 settembre poteva annunciare a Ludovico Gonzaga la presa di Mapello e del monastero di Pontida e che le sue truppe stavano distruggendo coloro che parteggiavano per i Benaglia.
A Galeazzo signore di Pavia, morto nel 1378, era successo il figlio maggiore Gian Galeazzo, conte di Virtù, uomo scaltro e ambizioso. Ambiva, tra l'altro, di diventare unico signore dello Stato Visconteo.
Con lo stratagemma di un pellegrinaggio alla Madonna del Monte di Varese, riuscì nel maggio del 1385 a fare prigioniero lo zio coi due figli Rodolfo e Ludovico, facendoli dapprima rinchiudere nel castello di Porta Giovia e di poi in quello di Trezzo, da dove non poterono mai più uscire. Bernabò vi moriva avvelenato il 19 dicembre di quell'anno stesso.
Il nuovo signore, agli inizi del suo dominio, per guadagnarsi la simpatia dei sudditi e far dimenticare il modo col quale aveva trattato lo zio, riconfermò, tra l'altro, non solo le esenzioni concesse da Bernabò il 31 marzo 1373 e in seguito ad altre particolari persone, ma il 1 giugno 1385 accordava esenzioni ad un numero ben maggiore di ghibellini della Martesana superiore (70).
Con altro decreto del 7 giugno perdonò ai guelfi martesani banditi dallo zio, concedendo di ritornare ai loro paesi e riammettendoli al possesso dei loro beni e diritti come prima (71).
Gli esuli, quasi tutti del Monte di Brianza, avevano supplicato il nuovo signore di usare loro clemenza, protestandosi innocenti dell'accusa di aver favorito il conte Amedeo di Savoia.
Dal confronto dei due documenti si constata nel Monte di Brianza la prevalenza delle famiglie ghibelline.
Con questi tratti di accorta generosità politica Gian Galeazzo cercava di accaparrarsi la fedeltà anche di coloro che si erano, più o meno, dimostrati nemici o indifferenti verso i Visconti.
Se per la genesi della formazione territoriale del Monte di Brianza, le concessioni di Bernabò del 31 marzo 1373 sono il punto di partenza, non meno importante è quello del 1 giugno 1385 di Gian Galeazzo in quanto esso sarà riconfermato dai successori. Il territorio abitato da quegli esenti costituirà officialmente e definitivamente con Francesco I Sforza nel 1451 l'Università del Monte di Brianza, ossia una comunità differenziata nel contado della Martesana.
Il 3 settembre 1402 moriva Gian Galeazzo all'apogeo, si può dire, della sua gloria e della sua potenza, poiché si era formato con attività e astuzia un vasto dominio ed aveva acquistato nel 1395 il titolo di duca da Venceslao re dei Romani e di Boemia. Lo Stato Visconteo fu diviso, tra i figli, in base alle ultime disposizioni testamentarie. Il primogenito Giovanni Maria ebbe la corona ducale, con una parte dello Stato, Filippo Maria il titolo di conte di Pavia con la restante parte, salvo le città di Crema e di Pisa che furono assegnate ad un figlio illegittimo.
La Martesana, col Monte di Brianza, rimase sotto il governo di Gian Maria. L'11 gennaio 1403 concedeva al borgo di Merate di riaprire il mercato, che si teneva al lunedì, rimasto sospeso per l'invasione e saccheggio delle truppe del conte Amedeo di Savoia (72). Il 9 gennaio 1406 rinnovava ad alcune persone dei De Capitani di Vimercate e Lavello le esenzioni concesse dal padre (73), ed altrettanto in quell'anno ad altre persone di Imbersago, Robbiate e Vimercate (74). Il 4 agosto 1411, confermava le esenzioni accordate dal padre ai ghibellini della Martesana superiore.
Il duca, scioperato e crudele, cadeva pugnalato da congiurati milanesi il 6 maggio 1412.
Filippo Maria, divenuto unico signore dello Stato, trovò il dominio paterno in completo sfacelo, dilaniato dalle lotte fra guelfi e ghibellini che in particolar modo infuriarono nel milanese sotto il malgoverno di Gian Maria.
La Martesana non andò esente da scontri sanguinosi, omicidi, incendi, e saccheggi, nonostante che il 27 settembre 1403 si facesse pubblicare in Milano la pace fatta con le genti martesane (75).
Memoranda la battaglia di Rovagnate, avvenuta il 7 aprile (giorno di Pasqua) del 1409 tra l'armata guelfa condotta da Pandolfo Malatesta, che passata l'Adda a Brivio, si era inoltrata nel Monte di Brianza, e quella ghibellina al comando di Facino Cane. Non ci furono né vinti né vincitori, così che il giorno seguente i due condottieri riuscirono ad accordarsi e a marciare uniti su Milano col proposito di impedire che la città potesse cadere in potere dei Francesi (76).
Filippo Maria si mise con faticoso e tenace lavoro a ricostruire lo Stato. Ma dopo che ebbe a guastarsi col Carmagnola (1424), il quale passò allo stipendio dei Veneziani, incominciò nel 1426 quella guerra contro Venezia che, interrotta da qualche effimera pace, non fu mai estinta, e l'accompagnò per tutta la vita.
Prese perciò a largheggiare favori ai ghibellini della Martesana superiore per averli sempre fedeli sostenitori di fronte al nemico confinante.
Già prima di conchiudere la pace coi Veneziani nel 1428, per la quale l'Adda rimaneva da questa parte il confine tra il Ducato e lo Stato Veneto, rinnovò il 20 febbraio 1428 ai ghibellini martesani le immunità ed esenzioni concesse dal padre e dal fratello per la loro antica devozione e fedeltà (77), e nel maggio del 1440 le rese ancor più ampie per il numero degli esenti (78). In quest'ultimo decreto, nel quale si vede nominata per la prima volta l'Università del Monte di Brianza come comunità distinta fra le terre del Ducato, le pievi, i comuni, e gli uomini in esso contemplati venivano in perpetuo resi immuni ed esenti da qualsiasi onere, tranne " onere salis pro tempore tunc futuro, et exceptis datiis ordinariis transitus seu transversi et conductionibus mercantiarum et rerum ad civitatem Mediolani, et exactionibus extra territorium Mediolani, datiis mercantie (et) ferraritie Mediolani, panis, vini et carnium, ac doane quibus subiacerent alii ". In cambio di queste concessioni gli esenti dovevano corrispondere una data somma in denaro specificata in un istrumento a parte.
Il duca si riprometteva, e giustamente, dai brianzoli efficaci aiuti, e perciò il 19 giugno 1440 eccitava le fedeli comunità della Martesana e del Monte di Brianza a somministrare il maggior numero possibile di armati ad Emanuele de Sicchis per difendere lo Stato nelle parti della Geradadda (79). E uomini di provata fedeltà dovevano essere poiché ancora il duca nell'ottobre vi manda il familiare Ermanno Zono ad ingaggiare almeno quaranta di quegli uomini fedelissimi per la guardia di Dosso Corteno (80).
Il 1440 fu un anno sfortunato per le armi viscontee (81). Donde la necessità di tenersi più che mai stretti gli uomini del Monte di Brianza, perché l'esercito veneziano condotto da Francesco Sforza, vincitore nel bresciano e nel bergamasco, poteva da un momento all'altro puntare sul milanese.
Perciò nel giugno, dopo aver fatto ispezionare i luoghi fortificati lungo l'Adda da Lecco in giù e messi in pieno assetto di difesa, ordinò al capitano della Martesana ed agli officiali di stare agli ordini di Iacopo Monferrato in tutto ciò che avrebbe disposto per la difesa dell'Adda qualora i nemici tentassero di passare il fiume, e quindi impose di prestare obbedienza al suo camerario Oldrado Lampugnano mandato alla difesa della pieve d'Incino e del Monte di Brianza (82).
Il Monte di Brianza per la laboriosità degli abitanti e per le esenzioni via via concesse dai Visconti godeva di tale prosperità che allorquando il 19 giugno 1447 l'esercito veneziano, sotto il comando dell'Attendolo penetrò da Brivio e vi sconfisse le truppe ducali forti di ottomila uomini, i vincitori ricavarono un ingente bottino dal territorio messo a sacco (83). Ruberie, e personali vendette commisero del pari i furosciti che seguivano l'esercito veneziano. Non pochi abitanti, ridotti in miseria, si rifugiarono in Milano.
Alla morte di Filippo Maria, avvenuta il 13 agosto 1447, i milanesi più influenti sollevarono il popolo e proclamarono la Repubblica.
Quelli del Monte di Brianza e della pieve d'Incino, che, dopo il saccheggio dell'esercito veneziano, erano emigrati in città in cerca di miglior condizioni di vita, non erano benevisi dai nuovi governanti perché turbolenti e ingombranti, e fors'anche perché sospettati per la loro fedeltà al defunto duca. Fatto sta che il 18 agosto 1448 furono obbligati a ritornare ai loro paesi entro due giorni sotto pena di essere dichiarati ribelli.
I brianzoli, sia per l'affronto ricevuto, sia per l'affezione a Bianca Maria, figlia di Filippo Maria, dal quale erano stati molto beneficati, e moglie di Francesco Sforza, conte di Pavia, che ambiva alla successione del Ducato, si dichiararono apertamente per lo Sforza e contro la Repubblica Ambrosiana (84).
4. - Il Monte di Brianza fu campo di decisivi cimenti per il conte, e gli abitanti gli si dimostrarono fedeli a tutta prova. E questo Bianca Maria lo ricorderà un giorno al figlio Galeazzo, riluttante a confermare i privilegi loro elargiti dal padre (85).
Nel dicembre del 1449 e nel gennaio dell'anno seguente, con ardimento e abilità Francesco Sforza giocò in Brianza l'ultima carta per la conquista del Ducato. Non sarebbe forse riuscito nel suo intento, se da una parte non fosse stato efficacemente coadiuvato in tutti i modi dai brianzoli, e dall'altra avesse avuto a che fare con forze nemiche ben organizzate e operanti in stretto collegamento.
La situazione dello Sforza, che teneva il suo quartiere generale a Calco, si era fatta molta pericolosa trovandosi quasi chiuso come in una sacca: ad est i Veneziani, i quali, passata l'Adda a Brivio o ad Olginate come scrive il Cagnola, si erano assestati sul monte S. Genesio; a sud l'esercito milanese raccolto in Monza al comando di Giacomo Piccinino; a nord-ovest Bartolomeo Colleoni che attraversato il lago di Lecco, scendeva nella Vallassina per invadere la Brianza.
Il conte aveva nondimeno il vantaggio di poter manovrare le sue forze disponibili per linee interne, e lo seppe abilmente sfruttare col battere separatamente i suoi nemici. Sconfisse dapprima il Piccinino presso Casate Vecchio che si avanzava verso il centro del Monte di Brianza respingendolo verso Monza; in seguito, presa la rocca di Airuno presidiata dai Veneziani, sbarazzò il S. Genesio delle forze nemiche; e finalmente riuscì a tamponare l'invasione del Colleoni. In tal modo rendeva impossibile ogni vettovagliamento per Milano che si trovava in critiche condizioni alimentari.
Fattasi la situazione militarmente più rassicurante, lo Sforza, assicuratosi i confini occidentali del ducato con trattative di pace col duca di Savoia e sistemata una linea di difesa nell'alta Brianza, incominciando da Cantù (poiché Como era rimasta fedele alla repubblica milanese), il 6 febbraio trasferì il quartiere generale a Vimercate da dove poteva vigilare i movimenti dei nemici e specialmente dei Veneziani sulla sponda sinistra dell'Adda. Occupata Monza, e già signore del basso milanese, attese così a stringere sempre più da vicino il blocco di Milano, poiché era nel suo scopo di prenderla per fame.
Correvano momenti difficili nel milanese in fatto di viveri. Le continue guerre, le scorrerie, i saccheggi avevano lasciato esausto e impoverito il territorio. Si era per di più nella stagione invernale, e perciò lontani i nuovi raccolti. Anche nella Brianza non c'era da scialare. I soldati stessi del conte si nutrivano per lo più di rape e di castagne, e a stento si trovava il foraggio per i cavalli. Ma se in campagna si poteva alla bell'e meglio arrangiarsi, la cosa diventava seria per la città, dove la mancanza di vettovaglie si era fatta talmente tragica da giungere persino a mangiare gatti e topi, erba e radici senza alcun condimento. Talora dei poveri cadevano morti di fame per le strade. Quel poco che, in un modo o nell'altro, riusciva a penetrare in Milano serviva ai maggiorenti e a chi aveva mezzi per acquistarlo.
Il popolo e i meno abbienti stanchi per le sofferenze, aizzati dai fautori del conte, presero a tumultuare, donde la resa. Lo Sforza corrispose col mandare subito viveri.
Nel pomeriggio del 26 febbraio 1430 entrava in Milano e ne prendeva
possesso (86).
A premiare la fedeltà dei brianzoli, e per tenerseli sempre più affezionati, lo Sforza con lettere patenti del 22 dicembre 1451, - premesso un significativo elogio al loro valore di combattenti ed allo spirito di sacrificio col quale seppero sopportare gravissimi danni, incendi, pericoli, prigionie, " aliasque infinitas iacturas " -, confermò loro, aumentandole, le immunità ed esenzioni concesse da Filippo Maria nel 1440, nonostante le sue impellenti necessità di denaro.
Nel lungo elenco degli esenti risultano distinti, per singolari meriti, Giovanni e Antonio Molgora, Giovanni Calco, e il paese di Imbersago, i quali furono dispensati dal versare la loro quota parte dell'annuo tributo convenzionato.
Per questi favori l'Università briantea doveva nondimeno consegnare alla camera o erario ducale due mila fiorini per il 1450, e negli anni seguenti 2400, computato il forino a 32 soldi imperiali, in due rate, una alla festa di S. Martino e l'altra a Natale.
5. - Mentre i Visconti non concessero che esenzioni fiscali, lo Sforza per dimostrare sempre meglio la sua benevolenza li favorì di un particolare giusdicente:
" Insuper ad tollendas seu minuendas impensas ed ad evitanda discrimina iterum concedimus dictis plebibus et locis exemptis ut supra, scilicet plebi Garlate, plebi Ugloni, plebi Brippi et plebi Missalie cum Roncho, quod expensis eorum tamen tenere possint officialem unum qui iura ministret in civili in partibus Montisbriancie usque ad quantitatem dumtaxat librarum viginti tertiolorum, et cum eo habeant iudicialem banchum in partibus illis tantum et quod Capitaneus Martexane (87), nec alius officialis intromittere se possit, nec intromittat de dicto officiali tenendo nec de eius iurisdictione absque nostra speciali delegatione vel commissione sub pena indignationis nostre ".
Il Dozio scrisse di aver letto in una carta del secolo decimo quarto che Barzanò era residenza del capitano generale del Monte di Brianza, e che poi lo fu del suo vicario (88). Probabilmente la carta a cui si riferisce e la ducale di Filippo Maria del 5 aprile 1415 diretta al capitano della Martesana residente in Barzanò (89).
Così pure da altra carta del 1413 sappiamo che Opezino de Alzate era
" capitaneus generalis tocius Martexane ", e che il suo vicario Nicolao de Fondra rendeva giustizia " supra eius solito bancho sito in loco Barzanore plebis Massalie ducatus Mediolani ubi per eum iura redentur more solito hora debita causarum " (90).
Ma non si tratta, come vorrebbe il Dozio, ed altri che lo seguirono, del capitano generale del Monte di Brianza, ma bensì della Martesana. Il Monte di Brianza non ebbe mai capitano proprio, ma soltanto nel 1451 con Francesco Sforza fu eretto in particolare vicariato, pur continuando a far parte del contado della Martesana e a dipendere dal suo capitano nelle cause criminali, ed anche in quelle civili oltre le 20 lire terzole.
Altrettanto inesatto è il Pagani quando afferma che dopo il 1344 " vediamo costituita una giurisdizione speciale col nome di Monte di Brianza, che abbracciava il territorio briantino propriamente detto, col centro a Barzanò, al cui castello dovette perciò far capo anche la pieve di Agliate, e quindi anche Carate " (91).
Il Redaelli asserì invece che Merate per il corso di più secoli fu sede del vicario del Monte di Brianza, ma senza esporre una data od una fonte che specificasse (92). La cosa, fatta la debita tara all'espressione " di più secoli " ed escluso il periodo sforzesco, forse non è inverosimile, sia perché il vicario briantino non ebbe sempre stabile residenza in un dato luogo, sia perché Merate, oltre che centro dei vasti possedimenti dell'abbazia di S. Dionigi di Milano, nel secolo XVII al dir del Tadini era il paese del Monte di Brianza con maggior popolazione (93). Comunque sia, non mi fu dato conoscere documenti che comprovino il dire del Redaelli. Nemmeno vi accenna il sac. Alessandro Andrea Sala nella sua storia di Merate (94).
Da parte mia posso solamente affermare che il vicario briantino risiedeva a Oggiono nel 1466, nel 1481, nel 1506, e probabilmene anche nel 1513; a Barzanò forse nel 1479 e certamente nel 1628.
Infatti l'8 marzo 1466 Paolo Vimercati, vicario del Monte di Brianza, informava con lettera datata da Oggiono che il castellano di Montebarro non attendeva, come d'obbligo, a fare buona guardia alla rocca. Il Vimercati fu vicario per molti anni, e le sue lettere alla duchessa e a Francesco Sforza erano datate da Oggiono. Inoltre il 10 marzo dello stesso anno il commissario Francesco Selvatico notificava pure da Oggiono alla duchessa che gli uomini del Monte di Brianza, radunatisi colà in assemblea, si erano dichiarati pronti a sostenerla in qualsiasi evento. Erano momenti nei quali, per la grave malattia di Francesco Sforza, si temevano complicazioni per il Ducato. In quell'occasione tutte le fortezze lungo l'Adda (il castello di Lecco, la rocca di Montebarro, il castello di Brivio, la torre di Porto d'Adda, la rocchetta di S. Maria, il castello di Trezzo), vennero messe in maggiore efficienza (95).
Il 26 maggio 1479 Pietro Parpaglione, vicario del Monte di Brianza, faceva notificare alla comunità di Cremella l'ordine ducale per la consegna, in legale distinta, dei beni di ragione del Monastero di S. Pietro, esistenti in quel territorio, per mezzo del servitore del Comune di Milano, Gabriele Pozzi, abitante in Barzanò. Il bando fu rogato da Gasparino de Rippa in Barzanò " de mandato dicti domini ut supra " (96).
Nel 1481 il 3 di marzo veniva eletto Lorenzo Mozanica " in vicanium et officialem vicaniatus predicti ogioni " (97).
Il Mozanica subentrava a Strenuo Sforza d'Ancona, famiglia d'armi del duca. I brianzoli in una supplica, senza data al duca dicono che ad esercitare il suo officio lo Strenuo aveva mandato uomini inetti e poveri, i quali commisero ingiustizie e robarie. Come si vede era una carica che si poteva affittare ad altri, i quali poi si rifacevano sui loro amministrati.
Silmilmente nel 1506 al 23 di gennaio i brianzoli posero nell'ufficio di vicario Iacobo Rusconi per due anni. L'atto di immissione fu steso " ad banchum prefati D. Vicarii situm in loco Ugloni capitis plebis ducatus Mediolani in domo habitationis Gasparini de Rippa notanii dicti banci " (98).
|
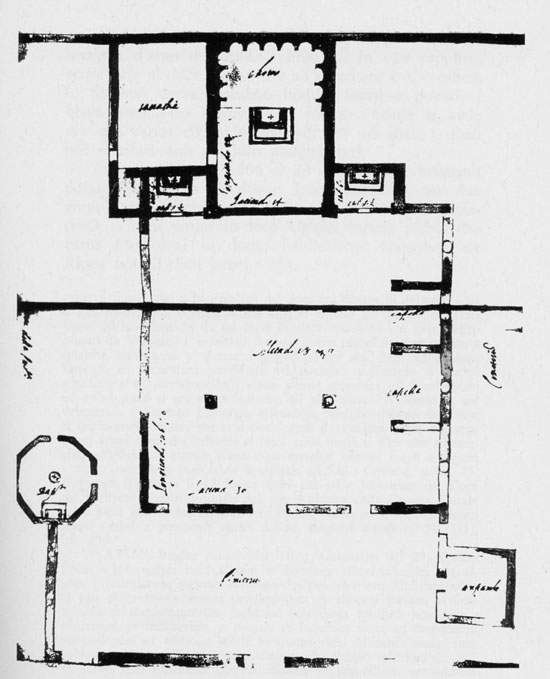
|
|
|
Pianta della plebana di S. Stefano e del battistero di S. Giovanni Battista di Mariano Comense
(Archivio Spirituale Curia Arcivescovile di Milano. Visite pastorali, Pieve di Mariano, vol. 16°,
quad. 1: disegno della seconda metà del Cinquecento)
|
|
|
|
|
Il 3 luglio 1513 il tesoriero " di lo offitio del vicariato sive prefetture de ogiono in Monte Brianza ", officio già tenuto nei passati anni da Lorenzo Mozanica, domanda che sia a lui concesso detto vicariato.
Il titolare veniva confermato e talora eletto dal duca, ma pagato dai brianzoli. Il vicario, come già notammo, aveva autorità nelle sole cause civili fino a 20 lire terzole: per cifre superiori si doveva dipendere dal capitano della Martesana o dal suo vicario. Tuttavia, e non mancano esempi, il duca per motivi speciali affidava talvolta al vicario briantino la definizione di vertenze per somme superiori, oppure ad altro iusdicente delegava cause che per sé sarebbero spettate al detto vicario.
Annesso al vicariato stava l'" officium notarie civilium Montis-briantie ".
Gli investiti, come si è osservato, potevano demandare ossia affittare il disimpegno dell'officio (99).
Le squadre dei Mauri e di Nibionno avevano un lor proprio potestà con relativo notaio, indipendentemente da quello di Incino (100), e vi eleggevano i titolari delle poste del sale, alla pari delle pievi briantine in base ai privilegi (101).
6. - Nonostante che lo Sforza entrasse vincitore in Milano nel 1450, la guerra coi Veneziani durò ancora quattro anni, per cui nel 1452 diede ordine al capitano della Martesana di ridurre a fortezza il Montebarro, il cui forte fu poi fatto demolire dai francesi nel 1507 (102).
Conclusa la pace nel 1454, e divenuta l'Adda confine definitivo tra i due Stati in queste nostre parti, lo Sforza si diede a promuovere il benessere del suo dominio.
Nel 1456, per togliere ingiuste ineguaglianze, fece eseguire un nuovo estimo della Comunità briantea, incaricandone Giovanni Francesco Mangano (103).
Senonché, forse per tenaci contestazioni da parte di interessati o fors'anche per le strettezze causate dalle precedenti guerre e dalla disastrosa peste del 1451 per cui non tutti fossero in grado di pagare l'annuo contributo (104), fatto si è che nel 1459 il duca diede incarico a Paolo Vimercati, vicario del Monte di Brianza, di procedere, armata mano, contro i renitenti alla riscossione forzosa del dovuto all'erario ducale, facendo inoltre balenare la minaccia di annullare i privilegi concessi.
Gli anziani delle pievi, di comune consiglio, per non inimicarsi il duca, decisero di aumentare l'annua somma convenuta di 2400 fiorini a 4 mila. Il duca accettò l'offerta, e in data 15 settembre 1460 riconfermò quanto aveva loro accordato nel 1451. Per l'onere del sale stabilì che se ne levasse la stessa quantità del tempo di Filippo Maria, ma che il prezzo fosse mantenuto su quello corrente nel Ducato; e che in ciascuna pieve gli stessi interessati eleggessero uno o due postari responsabili, in modo da garantire il tesoro ducale come nel passato.
Riguardo ai pesi ed alle misure dovevano attenersi a quelle in uso nello Stato e debitamente controllate. Assolve infine comunità e persone che fossero incorse in multe o condanne.
I privilegi di Francesco Sforza segnano il punto massimo delle benevolenze viscontee-sforzesche ai briantei. In seguito non si avranno che delle riconferme, ma nulla più, dai successori della stessa casa ducale e dalle susseguenti dominazioni straniere. Per la comunità briantina essi rimasero come la " magna Cartha " fino all'invasione francese del 1796.
Scomparirà il vicariato durante il dominio spagnolo, ma rimarranno le
esenzioni (105), le quali furono il vincolo che tenne sempre uniti i brianzoli nella difesa dei loro comuni interessi. Il punto debole di questi privilegi, a parer mio, si è che furono elargiti per benemerenza e non per un titolo strettamente oneroso, per cui rimase in arbitrio dei successivi governanti il confermarli in tutto o in parte, od anche rifiutarne la riconferma.
7. - Con Galeazzo, successo al padre l'8 maggio 1466, incominciarono i guai. Egli non intendeva riconoscere i privilegi. A lui premeva di incassare la maggior quantità possibile di denaro per mantenersi una corte splendida, e che perciò i brianzoli pagassero i tributi come tutti gli altri. Del vicario non gliene importava gran che, essendo pagato dagli stessi interessati (106).
L'università del Monte di Brianza ricorse a Bianca Maria, presentandole una supplica nella quale si dimostrava quanto pagava al tempo di Filippo Maria, e la prosperità di allora in confronto della presente miseria (107).
La duchessa, saggia e virile donna, la quale anche di recente aveva potuto apprezzare la fedeltà dei briantei, quando cioè temendosi, per la mortale malattia del marito, gravi complicazioni specialmente per le non chiare intenzioni dei Veneziani, si erano dichiarati pronti per lei, che nel frattempo aveva assunto la reggenza per il figlio lontano, ad " esponere oltre le loro persone ogne sue facultate " e di prendere le armi al minimo cenno, ne prese a cuore la causa (108).
Il 24 ottobre 1467 scrisse al figlio osservandogli: " Tu te dey ricordare che dicti homini come habiamo dicto ne sono servitori et fidelissimi schiavi, e per Nuy non hanno guardato ad mettere e la roba e la vita et li fiolli quando è bisognato per mantenirne in stato, e se non fussero stati loro male haveressimo facti li facti nostri e forse non saressemo ove che siamo, te li ricomandiamo ", ecc.; e per dimostrare quanto le premesse la cosa sottoscrisse la lettera di suo propria mano, il che non era sua usanza, com'ella afferma (109).
Galeazzo Maria fece il sordo. I brianzoli, oltre non vedersi riconoscere i privilegi, venivano angariati con soprusi da parte dei funzionari ducali. Ai loro reclami il duca non si dava per inteso.
Le cose giunsero a tal punto, col passare degli anni, che Ambrosino de Longagnana, capitano generale dei fanti e dei provvisionati ducali con lettera del 4 febbraio 1476, datata dal castello di Porta Giovia, si credette in dovere, con franchezza militare, di fare intendere al duca la gravità della situazione. " Se la V. ex.tia non gli provede - scrive il Longagnana - sarà forza che la mitade de quello paexe fugia, et questo è per le extreme superghie spexe se gli dano ", e soggiunge che " gli è una frota de mangiatori che mangiariano questo mondo et l'altro, et el magiore mangiatore de quisti mangiatori si è Fatio Galarano ". (110).
Il duca si decise finalmente il 29 marzo a confermare i privilegi (111), ma il 26 dicembre di quell'anno, a 32 anni, finiva ucciso all'ingresso della chiesa di S. Stefano in Milano da un gruppo di congiurati.
Fu un principe di belle prerogative, ma offuscate dai vizi. " Di questi il primo fu una sfrenata lussuria unita ad una grande crudeltà; si dell'una che dell'altra il Corio ne reca dei terribili esempi. Ma ciò che più gli aveva acquistato l'odio del pubblico erano gli smoderati carichi coi quali aggravava i suoi sudditi per l'ambizione di fare eccedenti spese, e di mantenere una corte sì splendida da superare ogni altra dell'universo " (112).
La duchessa Bona di Savoia, che sorretta nel governo da Cicco Simonetta, aveva assunto la reggenza in nome dei piccolo duca Giovanni Galeazzo, riconobbe il 4 marzo 1478 al Monte di Brianza i suoi privilegi (113).
Con astuti intrighi Lodovico, detto il Moro, fratellò dei defunto duca, riuscì nel 1480 ad acciuffare la reggenza, sbarazzandosi quindi del Simonetta col mandarlo a morte, e relegando la duchessa ad Abbiategrasso: dal duca debole e malaticcio nulla aveva a temere.
Del potere così male acquistato, i brianzoli per quello che li riguardava non ebbero noie; anzi il Moro rendeva loro giustizia quando officiali ducali ledevano i loro interessi (114). Anche a lui premeva tenerseli affezionati contro i Veneziani confinanti, pur facendo vigilare onde fosse impedito il contrabbando dei grani e del sale (115). Nel 1483 i briantei mossero in armi contro i Veneziani armeggianti sulla riva dell'Adda (116).
Nel 1494 moriva Gian Galeazzo, e il Moro divenuto duca anche di nome, si diede ad una politica che portò al travolgimento dello Stato, e lui stesso a morire prigioniero in Francia nel castello di Loches.
Dal 1500, fin alla morte dell'ultimo duca sforzesco (1535), corre uno dei periodi più agitati della storia milanese.
Il Ducato, ricco per le attività industriali e commerciali e per il prosperare dell'agricoltura, fu dapprima agognato e preteso dai Francesi, e successivamente dagli Spagnoli. Con alterne vicende passarono su le nostre terre eserciti francesi, svizzeri, spagnoli e lanzichenecchi. Loro compagna di tanto in tanto la carestia, la fame, la peste (117).
I sudditi si videro non solo aggravati da alloggiamenti militari e da frequenti richieste di denaro, ma altresì da violenze, rapine, saccheggi per dove passavano gli eserciti invasori.
Massimiliano Sforza - figlio del Moro, uno sventato e corrotto ventenne, che sostenuto dagli svizzeri poté essere duca di Milano per circa un biennio (1513-1515) per finire come suo padre prigioniero in Francia dopo la battaglia di Melegnano (14 settembre 1515); e Francesco II Sforza - altro figlio del Moro, ma avveduto e saggio, che gli succedette nel ducato, e che fra turbinosi avvenimenti, essendo subentrata la preponderanza spagnola dopo la battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525, niuscì a mantenersi in carica fino alla sua morte (1535), - non furono, si può dire, che l'ombra del loro potere negli atti politici più importanti, poiché di fatto dipendevano dagli stranieri ai quali dovevano il seggio ducale.
Lo Stato di Milano, con la morte di Francesco II Sforza senza eredi, fu annesso da Carlo V al dominio della Spagna, e vi rimase sfortunatamente per quasi due secoli come regione, più che altro, di sfruttamento.
Nello svolgersi di tutti quelli avvenimenti prese a farsi vivo, sia per tradizioni di famiglia, sia per particolari interessi o contrasti, il mai seme delle discordie medioevali: di sentimenti guelfi erano coloro che parteggiavano per i Francesi, ghibellini gli aderenti agli Sforza.
Il Monte di Brianza, fortunatamente lontano dalle vie che tenevano gli invasori, non fu campo di battaglie.
Il 2 Settembre 1499 il Moro all'appressarsi dell'esercito francese era fuggito presso Massimiliano imperatore di Germania. La grande maggioranza delle famiglie notabili briantee coi loro dipendenti rimasero a lui fedeli, e decisero di venire in soccorso di Lecco, ancora tenuta dai ducali, con un contingente di fanti a loro spese, e di tenere a questo scopo " un consilio universale in detto Monte di Brianza " (118). E fedeltà dimostrarono ancora nel 1514 al duca Massimiliano Sforza, primogenito del Moro, prendendo le armi contro i Veneziani alleati dei Francesi (119).
Il Moro riuscì a rientrare in Milano il 4 febbraio 1500 coll'aiuto dell'imperatore, ma, sessanta giorni dopo, il 4 aprile fu accerchiato e fatto progioniero a Novara, e condotto a morire in Francia.
Ben presto i briantei assaggiarono le carezze dei Francesi.
Nel mese di maggio truppe francesi vennero ad accamparsi a Barzanò e dintorni, dove commisero atti brutali e violenti. Gli abitanti avevano divisato d'insorgere, quando ad evitare maggiori guai furono a tempo trattenuti da alcuni nobili paesani influenti. Gian Giacomo Trivulzio stesso rese poi loro giustizia col punire i soldati facinorosi (120).
Nuovi disordini scoppiarono nel 1507 per le soperchierie dei Guasconi alloggiati presso le popolazioni briantine.
Rioccupato nel 1515 il Ducato dalle forze francesi, il duca di Borbone alcuni giorni dopo mandò i suoi seimila soldati in alloggiamento nel Monte di Brianza, con qual piacere dei brianzoli è facile immaginare.
Anni dopo (1521) è il Lautrec, che da Como passa nel bergamasco con tutta la cavalleria attraverso l'alta Brianza, segnando il passaggio con violenze e rapine.
Né va dimenticato il prepotente dominio di Gian Giacomo de' Medici, detto il Medeghino, castellano di Musso sopra gran parte del Monte di Brianza dal 1527 al 1531.
Per tutto questo periodo non ho trovato alcuna esplicita conferma ai briantei dei loro privilegi. Nondimeno risulta che, durante la prima dominazione francese, pagavano ancora in base ai loro capitoli.
Nel 1509 era sorta infatti una grave controversia tra i cittadini e i foresi del Monte di Brianza circa il pagamento della convenzione alla Camera ducale (121), e nel 1516 ricorre un'elezione per il Sindacato del Monte di Brianza, nella quale intervengono le principali persone briantine di allora (122).
La prima dominazione francese con Luigi XII fu, nell'insieme, abbastanza ordinata. Il re, per guadagnarsi l'animo dei suoi nuovi sudditi, cercò di instaurare nell'amministrazione la regolarità e l'equità dei tributi.
Copia autentica dei loro privilegi presentarono i brianzoli nel 1520 e nel 1525, in difesa dei loro diritti. Ciò nonostante non poterono sottrarsi ai frequenti contributi di guerra che alternativamente si imponevano dagli stranieri invasori; contributi ai quali del resto devettero pur ricorrere Massimiliano e Francesco II Sforza negli anni del loro breve dominio, per gli assillanti bisogni dell'erario ducale.
Quando con proclama del 13 febbraio 1516 si impose dai Francesi alle terre del ducato la contribuzione di centomila ducati d'oro per pagare i soldati, il Monte di Brianza vi dovette concorrere per lire 18.305; somma divisa tra le pievi al computo del 2 per cento: " ad computum de libr. XX pro quolibet miliario libr. seu ad computum de libr. XX pro quolibet miliario libr. seu ad computum de libr. duabus pro centenario ":
La pieve di Oggiono fu estimata per lire 175.040 e tassata per lire 3.508
La pieve di Missaglia fu estimata per lire 265.180 e tassata per lire 5.336
La pieve di Garlate fu estimata per lire 175.390 e tassata per lire 3.578.
La pieve di Brivio fu estimata per lire 210.150 e tassata per lire 4.023
La pieve di Agliate fu estimata per lire 93.000 e tassata per lire 1.860 (123)
La taglia, per le gravi lamentele suscitate, fu il 2 gennaio dell'anno seguente ridotta per tutti i contribuenti da Francesco I re di Francia.
Nel 1526 erano invece gli Spagnoli, subentrati ai Francesi definitivamente sconfitti nella battaglia di Pavia (1525), che " facevano pagare ali poveri villani taje de sorte, che assai de loro abandonorno le loro caxe et terreni, perché fudevano assassinati et robati " (124).
A rincarare la dose, l'anno dopo vennero in Brianza le truppe del Belgioioso, composte di mercenari italiani, per ritogliere al Medici il castello di Monguzzo (125), diportandosi peggio degli Spagnoli, poiché al dir del Burigozzo " l'era vero che spagnoli avevano fatto mal assai, ma questi Taliani hanno avanzato assai assai là dove sono stati suxo per lo paese et in la robba, in la persona e in l'onore delle donne, tanto che se Turchi venessero in queste bande, non fariano el male che hanno fatto costoro, secondo el suo deportamento qua a Milano " (126).
Nel 1528 si sviluppò per di più la peste, la quale, come già dicemmo, desolò Milano e la campagna.
Francesco II Sforza, nei pochi anni che poté tenere il Ducato, dimostrò qualità di saggio principe. Di lui non ho trovato una esplicita conferma dei privilegi. Tuttavia la revisione dell'estimo briantino ordinata con ducale del 7 febbraio 1523 (127), della quale era stato incaricato Gerolamo Brebbia, ci fa ritenere che fossero in vigore. Gli interessati dovevano presentare le loro notificazioni con esattezza, sotto minaccia di gravi pene, al cancelliere deputato, il quale doveva risiedere in S. Maria Hoe (presso Rovagnate) dal 13 aprile sino alla fine del mese (128).
Si noti che il decreto venne pubblicato nei capoluoghi delle singole pievi e squadre, formanti l'Università del Monte di Brianza, e cioè in Agliate, Oggiono, Garlate, Brivio, Missaglia, Bosisio per la squadra dei Mauri, e Tabiago per quella di Nibionno. Non vi è cenno per quei luoghi, pochi in verità, nelle pievi di Vimercate e di Pontirolo in cui vi erano degli esenti in forza dei privilegi. Probabilmente erano convenzionati con le confinanti pievi di Brivio o di Missaglia. Ignoro l'esito di questa revisione. Le ricerche fatte per rintracciare le carte rimasero senza risultato.
Il 31 maggio 1515 veniva concesso dal duca Massimiliano Sforza al senatore Francesco Visconti di Somma il feudo di Rivolta d'Adda col reddito annuo di mille scudi su la metà delle entrate camerali di Monza, col patto che, qualora la detta metà non avesse a raggiungere i mille scudi, vi si supplisse a compimento col reddito camerale della convenzione del Monte di Brianza (129).
Il 23 dicembre 1529 Francesco Sforza ebbe da Carlo V l'investitura del Ducato, ma con l'obbligo di sborsargli una grossa somma. Per fronteggiare questo ed altri urgenti impegni, esausto l'erario, dovette ricorrere a nuove tasse, e tra l'altre a quella straordinaria sui terreni. Dopo avere ottenuto dal pontefice Clemente VII, con bolla del 17 gennaio 1530, di stabilire una imposta anche sui beni ecclesiastici, con decreto del 7 agosto 1531, revocando ogni esenzione o privilegio che chiunque potesse vantare, ordinò che si avesse a pagare per ogni pertica soldi 1 e denari 10 per i prati, le vigne, le risaie, i campi; e denari 9 per i boschi e i pascoli, da soddisfarsi in due rate entro dieci giorni dalla scadenza. Concedeva che, effettuandosi puntualmente il versamento delle somme stabilite, sarebbe stato accordato ai solventi lo sconto di denari 10 sulle quattro prime sopradette categorie, e denari 3 sulle altre.
Venne premesso un censimento generale di tutte le terre colte ed incolte, sia che pagassero o nò i carichi rurali, coll'obbligo di notificare se sopra di esse gravassero livelli e a chi spettassero (130).
Di questo censimento abbiamo delle notizie riguardanti le pievi di Missaglia, Oggiono, Garlate, Agliate oltre il Lambro, Brivio, Vimercate (131).
Le speranze dei sudditi di vedere il Ducato ritornare all'anteriore prosperità, come lasciavano presagire le serie doti di Francesco II Sforza nonostante la precaria salute, rimasero ben presto deluse. Il 1 novembre 1535 moriva improvvisamente a quarant'anni senza discendenti diretti. Il Ducato di Milano passava senz'altro alla Spagna.
8. - Il nuovo governo, dando compimento a quanto avevano divisato di fare Lodovico il Moro e l'ultimo degli Sforza, promulgò il 27 agosto 1541 le Nuove Costituzioni, ossia la raccolta, giuridicamente elaborata, in un codice, delle leggi emanate dai signori e duchi di Milano. Andarono in vigore il 1 gennaio dell'anno seguente, e durarono fino alla conquista francese del 1796, tranne un breve intervallo sotto Giuseppe II.
L'Università briantea non stette inoperosa, ma implorò ed ottenne dall'imperatore Carlo V, il 9 settembre 1541, la conferma " de verbo ad verbum " dei suoi privilegi (132), benché l'imperatore alcuni anni prima avesse infeudato a diversi il Monte di Brianza.
Il 16 settembre, infatti, del 1538 le pievi di Oggiono e di Garlate furono acquistate da Giovanni Agostino d'Adda con annessi molti redditi feudali, con mero e misto imperio e podestà di spada con sede in Oggiono del podestà; e il 28 ottobre di quell'anno stesso le pievi di Brivio, di Missaglia, e di Agliate oltre il Lambro furono concesse in feudo con eguali diritti a Gerolamo Brebbia consigliere ducale e tesoriere dello Stato (133).
Al Senatore Francesco Sfrondati il 23 ottobre 1537 erano state riconosciute feudalmente in signoria le squadre dei Mauri e di Nibionno (134). Quasi tutta la pieve di Vimercate si trovava già da tempo infeudata ai Secco-Borella coi dazi dell'imbottato, del pane, del vino, e della carne.
Quali effetti producessero queste ed altre infeudazioni sui privilegi del Monte di Brianza non saprei dire.
A quanto pare devono essere stati, per lo meno, non poco fastidiosi, e non di rado fonte di ingiustizie e prepotenze, se la maggior parte delle Comunità delle pievi di Oggiono e di Garlate, appunto perché " infastidite et assediate dali Podestà e Vicari foresi ", domandarono ed ottennero con decreto 17 giugno 1654 di Filippo re di Spagna, sborsando lire 30 per ogni fuoco, di non essere più infeudate e di essere direttamente soggette ai giudici di Milano tanto nelle cause civili quanto in quelle criminali.
9. - Scrive il Santamaria che " In quanto al Magistrato ducale servirà notare che nel 1544 fu abolito il Vicario del Monte di Brianza (istituito nel 1451), incorporandolo cioè di nuovo alla Martesana, cui fu dato per giudice il regio Vicario della Martesana con mero e misto imperio, con autorità (pare) anche sopra i sudditi dei feudatari, fungendo anche da Maggior Magistrato in quel territorio " (135).
Mi fu dato tuttavia di trovare memoria di un Francesco Mornula o Molgola e di un Achille Tettamanzi, il primo vicario briantino nel 1579 e l'altro nel 1608, benché non si accenni al luogo di residenza (136). Di più, nel 1628 in una vertenza tra le monache del monastero di Bernaga sopra Perego e non pochi loro debitori, il procuratore delle monache, Benedetto Viganò, ricorse al vicario del Monte di Brianza, Alessandro Sirtori, perché fossero citati e obbligati al pagamento. La causa fu discussa in Barzanò dove il vicario teneva il suo ufficio legale. I debitori erano una quarantina circa sparsi nei luoghi di Torrevilla, Sirtori, Rovagnate, Crescenzago, Sala (di Rovagnate), Missaglia, Tremonte, Hoe, Viganò, Perego, Cereda, Galbussera, Busarengo, i quali dovevano al monastero per somministrazione di medicinali e seme-bachi (137).
Da quest'anno in poi non mi fu possibile rintracciare altri vicari del Monte di Brianza. Nel Ruolo de' Regi Impiegati nello Stato di Milano circa l'anno 1650, coll'ammontare del soldo, e degli emolumenti assegnati a ciascun impiego (138), non vi è cenno, fra quelli del contado della Martesana, del vicario briantino. Nemmeno si fa parola nella controversia tra il vicario della Martesana in difesa dei suoi diritti e le pretese delle pievi di Oggiono e di Garlate (1652-54) (139). Si può pertanto supporre che nel frattempo sia stato soppresso.
Della dominazione spagnola, malauguratamente durata così a lungo, si è detto e scritto ogni male con evidente esagerazione (140).
Tuttavia, pur tenendo calcolo della mentalità politica, sociale ed economica allora dominante, non si può negare che la Spagna, tra l'altro, non si diede premura di affiancare e rinvigorire con feconde iniziative, utili a sé e ai sudditi, in una cornice di sana e operante amministrazione, quelle fonti da cui ricavava i larghi tributi necessari specialmente per mantenere in efficienza le forze militari, le fortificazioni, e la difesa dello Stato.
Dalla fine del dominio sforzesco fino al secondo decennio del secolo seguente il Ducato, e con esso il Monte di Brianza, continuò a godere di una relativa prosperità, ma che poggiava su fragile fondamento: nel suo insieme si manteneva per forza d'inerzia, sfruttando le ultime riserve di quelle energie che nel passato resero relativamente fiorenti Milano e la Lombardia.
Perciò lenta, e poco avvertita, nonostante certi periodi di momentanea ripresa, fu la decadenza fin verso il 1630. Dopo la famosa peste di quell'anno, preceduta da annate di scarsi raccolti e dalla crisi in atto nelle industrie e nei commerci, lo sgretolamento si svolse più rapido. All'incombente miseria e disoccupazione il governo spagnolo, sempre bisognoso di denaro, non trovò di meglio che aumentare le voci delle imposte, e moltiplicare la vendita di feudi camerali con annesso titoli nobiliari di conte o di marchese, generando una classe di altezzosi signorotti viventi di rendita, poiché qualsiasi lavoro, secondo il mal costume spagnolo, era ritenuto incompatibile col loro onore. Circondati dai loro bravi si ritenevano pressoché esenti dalle leggi. Mal esempio che influiva sulle classi inferiori.
Non che la parte elevata, colta e ben pensante milanese assistesse indifferente a tale situazione, che anzi attraverso le civiche istituzioni si sforzò di resistere alle egoistiche sopraffazioni dei governatori.
Le campagne, fatte le debite proporzioni, erano più gravate che le città per il diverso trattamento fiscale della proprietà dei cittadini rispetto a quello dei rurali o foresi, e per di più infestate da malviventi e banditi che osavano assalire non solo singole persone, ma talvolta riuniti in bande armate i villaggi stessi. Si dovette concedere di porre sui campanili sentinelle le quali avvertissero in tempo gli abitanti del loro avvicinarsi. Si viveva poi non di rado sotto la minaccia di carestie, di requisizioni forzose, di violenze militari e non militari.
Non pochi preferivano sconfinare all'estero in cerca di miglior benessere, benché fosse proibito uscire dallo Stato senza licenza.
Il Monte di Brianza, pur continuando a godere di esenzioni come ci assicura lo stesso Ripamonti, risentiva del grave peso, e particolarmente i terreni non coperti da privilegi civili o ecclesiastici. Il comasco Gio. Maria Tridi in una sua Informazione avvertiva che il Monte di Brianza, la pieve d'Incino, e la Vallassina andavano spopolandosi (141).
Di questo vi è cenno in una grida del 9 maggio 1671 nella quale si dice che non si risentivano ancora gli effetti di undici anni di pace, e la popolazione continuava a scarseggiare.
Il decomporsi e lo sfasciarsi della monarchia spagnola non tralasciava di far sentire nello Stato di Milano i suoi deleteri riflessi.
In un ricorso del 14 gennaio 1690, inoltrato al governo di Madrid dal marchese Airoldi in nome del Consiglio Segreto, vi si affermava - con alquanta esagerazione come di solito avviene nelle lamentele - che i poveri sudditi non avevano altro che il fiato esente dai carichi, e che il Milanese era giunto alla totale distruzione.
In realtà, nonostante i primi sintomi di nuove esigenze sociali ed industriali, e tra queste, in contrasto con le decrepite corporazioni, il diffondersi della lavorazione della seta (molini ossia filatoi) nelle nostre campagne per il minor costo della mano d'opera ed altri vantaggi, il disagio economico rimaneva tale che città e comuni rurali si dibattevano per la maggior parte in tali strettezze, che il 20 novembre 1702 si dovette rimettere i loro debiti contratti coll'erario.
In sostanza, ritengo che non abbiano tutti i torti coloro i quali scrissero che la Spagna non vide nel Milanese che un territorio di sfruttamento per le sue mire egemoniche in Italia.
Piace qui ricordare come, in quegli anni di grave depressione sociale ed economica, i brianzoli non smentirono il loro antico spirito battagliero.
Nel maggio del 1636 truppe francesi condotte dal duca di Rohan attraverso la Valsassina giunsero presso Lecco coll'intenzione di attraversare l'Adda, e penetrare nel Milanese. Circa quattromila brianzoli, adunatisi col tradizionale segno delle fumate sulle alture, presero le armi e furono pronti a schierarsi, sotto i rispettivi comandanti, sulla sponda opposta del fiume onde impedire il passaggio al nemico.
Il Rohan di fronte a quello spiegamento di forze si affrettò a ritornare in Valtellina nel suo quartiere di Montello (142).
Dodici anni dopo, 22 luglio 1648, venne emanato un ordine ai sindaci di usare diligenza nel recuperare le armi che erano state consegnate a soldati e comunità del Monte di Brianza in occasione della discesa del duca di Rohan (143).
Costituiva il Monte di Brianza uno dei distretti annonari, nei quali era allora diviso lo Stato, col relativo commissario che vigilava onde non avvenisse il contrabbando dei grani. Nel 1594 eravi commissario sopra " le sfrose di grani " Vespasiano Isacco, il quale aveva domandato alla competente autorità di poter
" elligere tri soldati per haver magior diligenza per esser la provincia granda, et perché d.o Commissario non ha alchuno salario et bisogna mantenere detti soldati, supp.a anch.a che nelle Inventioni et Compositioni che se faranno, che pagando il quarto netto alla Camera, li tri quarti siano del d.o Comisario per pagare detti
soldati " (144).
Dal citato Ruolo degli impiegati dello Stato di Milano, redatto nel 1650, si ha che il capitano della Martesana aveva cura del criminale in quella provincia con l'obbligo di tenere quattro soldati a cavallo, con un salario di lire 1.000 e lire 808,13 per emolumenti: pagava lire 379,15. Il vicario non percepiva alcun salario, ma per le notificazioni fatte, valeva ogni anno lire 2400. Il fiscale non fruiva salario ma teneva emolumenti che rendevano annualmente lire 1.000, e pagava lire 200. Il cotrascrittore aveva lire 300 all'anno, e pagava lire 60. Tutti costoro risiedevano a Vimercate. Il Commissario del Monte di Brianza ricavava ogni anno lire 170 e pagava lire 34.
Commissari propri avevano Cantù, Incino, ecc, appunto perché non appartenevano alla Comunità briantea (145).
Quando le terre briantine erano flagellate dalla grandine ed il danno risultava di una data entità, ciò che allora accadeva con una certa qual frequenza, dai danneggiati si ricorreva al competente Magistrato, e si otteneva una proporzionale riduzione dei carichi (146).
Nel Monte di Brianza rimaneva sempre prevalente la piccola e media proprietà. Tuttavia, pur escluso il latifondo in vigore nella bassa milanese, non mancavano grosse proprietà di enti religiosi, di nobili e di ricchi i quali, approfittando della generale depressione economica, andavano ampliando con acquisti i loro beni terrieri.
L'entrata principale dei fondi era il vino, e il prodotto nei contratti colonici per lo più si divideva a metà.
Relativamente scarsa la resa del frumento e della segala (detta granaglia grossa), data la montuosità del territorio, e quasi tutto di spettanza padronale. La povera gente si nutriva di pane miscellato con paníco e miglio, nel quale ben poco o nessuna parte aveva la farina di frumento.
Si incominciò ad introdurre qua e là la coltivazione del formentone o granoturco, importato in Italia per primo in Sicilia, dicesi, da un marinaio spagnolo nel 1560, il quale finirà poi col passare degli anni ad entrare col riso nell'ordinario uso alimentare dei nostri contadini (pane giallo e polenta), soppiantando minestra e pane di miglio (pan de mei). S. Carlo favorì fra di noi la coltivazione del granoturco.
Oltre la vite, erano molte diffuse le piante da frutto (noci, meli, peri, ciliegi, ecc), e specialmente il castagno. " Il raccolto dei grani minuti et castagne, (erano il) sostegno dei poveri " attestarono gli uomini della pieve di Missaglia il 12 agosto 1621. E così, press'a poco, in tutto il Monte di Brianza, benché i terreni della parte meno collinosa rendessero di più in granaglie.
Una vita misera e stentata, ma nel complesso non gran che diversa di quella dei secoli passati. Bonvesin della Riva nel De magnalibus urbis Mediolani ci ricorda che nel secolo XIII le castagne si usavano per pane dai meno abbienti della stessa città di Milano.
Le affittanze, secondo la tradizionale consuetudine, si contrattavano in natura: un tanto di vino, di granaglie, di legumi, di frutta a seconda dei generi coltivati e delle esigenze del locatore, con l'aggiunta dei così detti appendizi in capponi, pollastri, uova, careggi, prestazioni personali, ecc. Contratti onerosi per lo più, nei quali il locatore si faceva la parte del leone: quello che rimaneva al coltivatore era appena sufficiente ai bisogni familiari. Raro era l'affitto a denaro (147).
Bastava una grandinata o un'annata metereologicamente sfavorevole perché i coloni si trovassero non solo nell'impossibilità di corrispondere l'affitto, ma di che sfamarsi.
L'impedire perciò il contrabbando dei grani, come del resto anche sotto i governi precedenti, era una delle preoccupazioni dei governanti di allora, per mantenere nello Stato, in base ai criteri economici correnti, l'abbondanza dei generi di prima necessità. Molto sorvegliate perciò le zone di confine, e per le nostre terre briantine in modo particolare quella lungo l'Adda (148).
Ma nonostante le molte grida in materia di sfrosi e alle volte con la minaccia della confisca e della forca, i contrabbandieri, come in tutti i tempi, non cessavano dal loro interessato lavoro, complici talvolta gli stessi officiali preposti alla repressione, il che richiama le bustarelle del giorno d'oggi...
10. - Coi trattati di Utrecht e di Rastatt (1713-1714) veniva segnata la fine del governo di Spagna su di noi.
Che sia avvenuto dei privilegi del Monte di Brianza coll'affermarsi della dominazione austriaca, e specialmente durante il periodo delle riforme amministrative, tributarie, giudiziarie, e territoriali di Maria Teresa e di Giuseppe II, non mi fu dato di rintracciare. Se non in tutto, almeno in parte, rimasero in efficienza, arguendo dal fatto che nel 1744 il Monte di Brianza, riguardo alla dogana, costituiva ancòra una ragione particolare: un Cesare Villa era allora conduttore dell'" Impresa della dogana per la Provincia del Monte di Brianza ". Inoltre, anni dopo, Giuseppe II, con dispaccio da Vienna del 29 giugno 1784 riconosceva ai brianzoli la esenzione dei dazi vecchi (149).
Ad ogni modo gli antichi privilegi erano ormai divenuti un intralcio per l'amministrazione statale che tendeva all'accentramento.
Il 22 maggio 1784 veniva richiamato al Regio Demanio l'annuo reddito fisso di lire 4808,5 che la casata del conte Stampa esigeva sopra la convenzione dell'imbottato delle cinque pievi briantine: allo Stampa fu corrisposto un congruo indennizzo. Per quel reddito la pieve di Oggiono sborsava ogni anno lire 1.099, quella di Garlate lire 973,5, di Agliate oltre il Lambro lire 48,18, di Brivio lire 1202,12, di Missaglia lire 1484,10.
Per meglio regolare l'amministrazione della Lombardia nel 1785 si ordinò la divisione del territorio in distretti, dando a ciascuno di essi un cancelliere censuale. Il distretto di Brivio ebbe in aggiunta i villaggi della valle di Rovagnate appartenenti alla pieve di Missaglia; a quello di Oggiono fu annessa la squadra dei Mauri; a quello di Agliate la squadra di Nibionno; ecc. (150).
11. - Sul declinare del secolo scoppiava in Francia la Rivoluzione. Nel 1796 Napoleone scendeva in Italia e, dopo un sèguito di vittorie, il 15 maggio entrava vittorioso in Milano.
Tutto fu riorganizzato alla francese. Col contado della Martesana sparve altresì l'antica comunità del Monte di Brianza, della quale non rimase che il ricordo.
Con la Repubblica Cisalpina la maggior parte del territorio brianteo fu inclusa nel Dipartimento della Montagna del quale era capoluogo Lecco (1797). Con la Repubblica Italiana (1802) e col Regno l'Italia (1805), fu assegnata al Dipartimento del Lario, il cui centro era Como, città con la quale il Monte di Brianza non ebbe mai nel passato a che fare.
Il 12 giugno 1814 si ritornò sudditi dell'Austria, la quale nell'anno seguente stabilì il Regno Lombardo-Veneto, con capitale Milano e che territorialmente fu poi riordinato in provincie, distretti, e comuni. La provincia di Como, come già il Dipartimento del Lario, assorbì quasi tutto il territorio dell'antica Università del Monte di Brianza (pievi di Oggiono, Olginate (Garlate), Brivio, Missaglia, Squadre dei Mauri e di Nibionno), rimanendo la restante piccola parte alla provincia di Milano.
Tale circoscrizione provinciale non venne modificata col compiersi dell'Unità Nazionale, e dura tuttora.
12. - Mi sono dilungato a narrare le vicende dei privilegi elargiti dai Visconti e da Francesco I Sforza, perché stanno alla base della formazione del Vicariato e dell'Università briantina. E poiché le esenzioni durarono, sia pure più o meno efficacemente, sino alla fine del secolo XVIII, esse servirono a tenere uniti e solidali i brianzoli nel loro comune interesse, e ad imprimere al loro territorio una particolare distinzione per ragioni fiscali.
Il Vicariato, ossia il Monte di Brianza propriamente detto, risulterebbe soltanto delle pievi di Garlate, Oggiono, Missaglia, Brivio con Ronco, e Agliate oltre il Lambro, e cioè di quella piaga collinosa e montuosa che immediatamente si allarga intorno al colle di Brianza. È bene richiamare che la pieve nel passato, fin quasi all'invasione francese (1796), era normalmente una divisione territoriale ecclesiastica e civile ad un tempo, per cui Valmadrera, facente parte della pieve di Garlate, apparteneva senza alcun dubbio al territorio briantino e non a quello di Lecco come vorrebbero alcuni per la ragione che gravitava su Lecco. Essa fu tra le prime terre briantine privilegiate da Bernabò Visconti (151).
Il Ripamonti, che ci ha lasciato una descrizione del Monte di Brianza dei suoi tempi, dopo averci riferito in modo alquanto vago che il territorio briantino confinava ad oriente coi Cenomani, ad ovest con gli Orobii, a sud col territorio di Monza e a nord col lago di Lecco, soggiunge specificando: " Ita quinque regionibus universa Briantaea provincia terminatur ac definitur extra quem limitem nihil est Briantaei sanguinis et iuris; atque contermini quidam pagi, sive propter immunitates et privilegia sive propter caeteram eius nominis gloriam, quoties, ut in id corpus assumerentur, efflegitavere, pubblice sunt confutati " (152).
Le cinque regioni corrisponderebbero, a quanto pare, alle quattro pievi di Galbiate, Oggiono, Missaglia, e Brivio, con in più la parte della pieve di Agliate oltre il Lambro resa perpetuamente immune ed esente con decreto del 12 maggio 1452 di Francesco I Sforza, coll'obbligo di versare ogni anno alla Camera ducale lire 300 che successivamente furono elevate a 360.
Tuttavia esse non comprendevano tutta l'Università del Monte di Brianza, quale si desume dai privilegi e dagli estimi, in quanto vi erano altre persone o famiglie esenti nelle squadre dei Mauri e di Nibionno, ed altre nelle pievi di Vimercate e di Pontirolo.
Il Ripamonti, in altro passo della sua Storia, scrive che Monguzzo segnava il confine tra gli Orobii e i Briantei. Orbene Monguzzo, situato al di qua del Lambro, prospetta appunto la zona delle due squadre che immediatamente si estende al di là del Lambro (153). Dunque era territorio brianteo. E che vi debba essere compreso ce lo assicurano gli estimi sforzeschi i quali venivano pubblicati nei capoluoghi delle cinque pievi e squadre sopradette, e il fatto che gli abitanti, in base ai privilegi, vi eleggevano i titolari per la rivendita del sale, e che tutti insieme erano talora tenuti a soddisfare determinati obblighi (154).
Volendosi inoltre tenere in considerazione il fatto che dai privilegi risultano nella pieve di Vimercate, ed in quella di Pontirolo nella parte al di qua dell'Adda (oggi Vicariato di Trezzo), degli esenti elencati con gli altri del Monte di Brianza, le suddette pievi di potrebbero in certo qual modo, largheggiando, ritenere zona brianzola (155).
Ciò detto non rimarrebbe motivo o cavillo per allargare i limiti storici della Comunità briantina, per lo meno in base ai privilegi ed agli estimi.
Il Riboldi asserì che verso la metà del secolo XV incominciò ad essere considerato fuori della Martesana il paese a ponente del Lambro, e che contemporaneamente nella Martesana superiore prese a diffondersi il nome di Monte di Brianza alle pievi di Incino, Oggiono, Garlate, Missaglia (156).
Per quello che riguarda il Monte di Brianza possiamo al contrario affermare che fin dal 1412 si dicevano del Monte di Brianza i paesi delle pievi di Oggiono, Missaglia, Brivio, Garlate; ed è ragionevole il pensare che ancor prima fosse corrente tale locuzione nella parlata popolare, perché non è ammissibile che siasi introdotta di punto in bianco in quell'anno.
Non risulta da alcun documento ufficiale che verso la metà di quel secolo vi facessero parte le pievi di Asso e di Incino (157); anzi erano in modo chiaro e preciso esclusi tutti i paesi situati a ponente del Lambro, come si ha dalle immunità ed esenzioni viscontee-sforzesche. Quei paesi ed altri diverranno Brianza nell'uso col secolo XIX, come si dirà più avanti.
Certo è invece che dalla metà de secolo XV, in forza dei privilegi, venne a concretarsi, tra l'Adda e il Lambro, un territorio officialmente riconosciuto col nome di Università del Monte di Brianza (158).
Ciò nonostante non mancarono confusioni riguardo alla posizione del territorio briantino.
Lo storico milanese Tristano Calco, descrivendo sul declinare di quel secolo la Martesana dei tempi di Federico Barbarossa, ritrasse quella che tale si diceva al suo tempo: " Marthesanam dicimus planitiem quae Lambrum inter Abduam ac Montes a Briantia olim oppido nuncupatos interiacet, cuius caput est Vicus Mercatus Moguntiae finitimus " (159).
Non si dimentichi peraltro, che tanto la Martesana superiore, di cui faceva parte il Monte di Brianza, quanto l'inferiore formavano allora un unico contado retto da un Capitano residente a Vimercate. Senonché in uno scritto che si vorrebbe del medesimo autore, si legge, contraddicendo a quanto sopra, che ai suoi giorni si diceva comunemente Monte di Brianza la penisola, lunga venti miglia, la quale tra Como e Lecco si prolungava nel lago; o in altre parole si collocava la regione briantina non già tra l'Adda e il Lambro, ma fra i due rami del lago di Como ossia in
Vallassina (160).
È un'asserzione che va chiarita.
Innanzitutto non si può pensare, fatte sempre le debite eccezioni, che i milanesi colti o dirigenti (ecclesiastici e laici), o coloro ch'erano dediti alle industrie ed ai commerci, o che vi possedevano case e fondi (e non erano pochi) non ne conoscessero la sua esatta posizione. Facile invece che tra i forestieri e il basso ceto cittadino, per ignoranza o per mancanza di rapporti col territorio briantino, si usasse, sia pure non da tutti, chiamare confusamente e in modo generico Monte di Brianza la parte montuosa della Martesana ossia la Vallassina. Ma che questo modo di esprimersi venisse a costituire un vero uso volgare o comune, non mi sembra verosimile.
Strano che il Calco, se veramente autore di quello scritto, la cui casata era di origine briantina e dove probabilmente lui stesso o i suoi parenti avranno avuto dei possedimenti, raccolga tale diceria, senza aggiungervi una parola che chiarisca la verità, così da indurre altri in errore.
È noto che la Vallassina si reggeva con propri Statuti (161), e che non ebbe mai attinenza coll'Università del Monte di Brianza.
Parimenti nella prima metà del secolo seguente dai Diarij di Marin Sanudo si ha che informatori veneti ponevano Mariano, Asso nel Monte o Monti di Brianza (162). Era questa maniera di esprimersi il portato di un uso comune, ovvero, cercandosi per quei paesi un noto punto di riferimento, non si trovasse di meglio che appoggiarli al territorio del Monte di Brianza? Io propendo per questa seconda ipotesi, perché gli abitanti di quei paesi sapevano benissimo di non appartenere all'Università briantina.
Tale erronea confusione la si verifica in qualche cartografo del cinquecento.
La Brianza, osserva giustamente la Codazzi, non fu certo una delle regioni meglio trattate dall'inizio della produzione cartograflca fino ai primi anni dell'Ottocento. Sia la più antica carta della regione lombarda giunta fino a noi, il
" Novum Longobardiae opus " impresso a Venezia tra il 1515 e il 1525, come la
" Lombardia" del Lucchini del 1558, non ci danno la benché minima idea della regione briantina.
La carta del Gastaldi " La nova descritione della Lombardia ", da porsi fra il sesto e il settimo decennio del cinquecento, pur facendo rilevare una regione collinosa a sud dei laghetti briantei, non solo non assegna a questa alcun nome, ma applica la denominazione di Monte di Brianza a quella parte che, nel passato fino al presente, fu sempre chiamata Vallassina. E altrettanto, presso a poco, si riscontra in una carta manoscritta conservata nella Biblioteca Ambrosiana (Chorografia Italiae) non posteriore al quarto o quinto decennio del cinquecento. È nelle due tavole
" Ducato ovvero territorio di Milano " e " Parte alpestre dello Stato di Milano con il lago Maggiore, di Lugano e di Como ", disegnate da Gio. Antonio Magini e pubblicate dal di lui figlio nel 1620, che viene segnata tra il Lambro e l'Adda una serie di colline alle quali si dà il nome collettivo di Monte di Brianza (163).
Comunque, sul declinare del cinquecento e su1 principio del seicento si riteneva pur sempre escluso il territorio a ponente del Lambro. Quando nel 1588 il padre cappuccino Dionigi da Milano venne pregato di fondare un convento a Verano, egli accettò perché, tra l'altro, fu preso dalla bella visuale sul Monte di Brianza che gli presentava il luogo offertogli; e negli Atti di visita del card. Federico Borromeo del 1608, parlandosi della chiesa plebana di S. Pietro e Paolo in Agliate, situata al di là del Lambro di fronte a Verano, vi si dice che da quella chiesa incominciava il Monte di Brianza: " et dicitur initium Montis Briantiae " (164).
Non mancava tuttavia una certa qual propensione da parte di paesi contermini di farsi includere nel territorio briantino, ma venivano respinti (165).
Il Monte di Brianza, nonostante le già accennate magagne del governo spagnolo, godeva di una situazione che nessun avvenimento poteva toglierli: l'amenità e la vaghezza dei luoghi.
Andrea Boldoni, parroco di Casatenovo, scriveva nei 1702, sia pure con una certa enfasi secentesca, che " Il Monte di Brianza veramente può dirsi delitioso Teatro delle felicità d'Italia per la salubrità dell'aria, abondanza de frutti, amenità de colli e vaghezza di sito, per la vicinanza delle Terre, tale, che quasi forma una Città, per la magnificenza de Tempii, nobiltà delle Casate, ricchezze d'addobbi, varietà di caccie, e per la meraviglia delle circolari e sterminate vedute ".
Il susseguirsi di guerre con le sue tristi conseguenze nella prima metà di quel secolo rese impossibile un sensibile progresso e la vita durò praticamente difficile, ma i cinquant'anni di pace che seguirono al trattato di Aquisgrana (1748), segnarono per la Lombardia, con la dominazione austriaca, un periodo di riforme, e tra queste il nuovo catasto e le leggi riguardanti le province ed i comuni, rese necessarie dalle deplorevoli condizioni nelle quali era stata lasciata dagli spagnoli. Ormai, come dappertutto, lo Stato milanese aspirava a forme più perfette di vita politica, sociale ed economica, di eguaglianza nei diritti e nei doveri di fronte allo Stato e alle sue leggi.
Ineluttabile quindi che dal potere statale, accentratore, si tendesse a togliere o ridurre al minimo quei legami o particolarismi che ne intralciavano il passo.
L'antico ordinamento fiscale e territoriale del Monte di Brianza non poteva sfuggire a queste generali riforme. Incominciarono perciò ad allentarsi quei vincoli che nel passato tennero gelosamente vigilanti gli appartenenti all'Università di detto Monte in difesa dei loro comuni interessi e del loro territorio.
D'altra parte il rifiorire dell'agricoltura, delle industrie e del commercio, incrementando la ricchezza, suscitarono nuove esigenze nel vivere civile. I ricchi e la nobiltà terriera, non si accontentavano più di avere in campagna una vecchia bicocca o casa da nobile come si legge nei rogiti di possesso, ma presero ad erigere qua e là sontuose ville (sino ai primi decenni ed oltre dell'ottocento), non solo nel Monte di Brianza ma ben anche nei luoghi ameni circostanti, specialmente a ponente del Lambro.
In queste ville, splendide per lieto vivere ed ospitale cortesia, non mancavano di essere ospiti graditi poeti e letterati, i quali celebrando le virtù del munifico signore, non tralasciavano di esaltare la bellezza del paesaggio, come fosse Monte di Brianza.
Anche i semplici benestanti milanesi, quando potevano procurarsi una proprietà qualsiasi o fare qualche scampagnata in quelle parti, dicevano per riferimento possedere o andare in Brianza.
Gli stessi paesi circostanti ambivano di essere considerati del Monte di Brianza.
L'insieme di questi avvenimenti fece sì che a poco a poco si introducesse la tendenza ad allargare in modo generico l'estensione dell'antico territorio briantino; tendenza che prese maggior vigore con l'invasione dei Francesi nel 1796, i quali, distrutto l'ordinamento statale esistente, instaurarono una nuova forma di governo, di amministrazione e di divisioni territoriali.
La stessa locuzione di Monte di Brianza andò in disuso, e sostituita con quella più semplice e comune di Brianza, che rimase sinonimo di territorio ameno.
Il perché poi, col passare degli anni, la zona briantina sia divenuta tanto vasta da comprendere tutto l'antico contado della Martesana con qualche aggiunta in più, lo si deve probabilmente, a mio avviso, più che all'uso volgare (166), agli scrittori dell'ottocento e del novecento che si occuparono della Brianza, senza tenere calcolo dei privilegi.
Per non richiamare che i principali - e trascurando coloro che ignari delle cose nostre dissero Brianza pressoché la metà dell'alto milanese (Baretti), oppure Monza capitale della Brianza (Denina) (167), - il Redaelli, che nel 1825 pubblicò le Notizie istoriche della Brianza, scrisse che la Brianza è " quell'aggregato di colline tra i fiumi Adda e Lambro, che incominciano a elevarsi poche miglia al di sopra di Monza su d'una linea da Cornate presso l'Adda alla Canonica del Lambro, e terminano poco lungi da Lecco, ove sono il Montebarro e le falde dei Monti della Valsassina... Le tortuosità del Lambro e dell'Adda formano la Brianza, che conta quindici miglia in lungo, ove più ove meno estesa in largo: non però giammai maggiore di dodici miglia né minore di nove " (168).
Più avanti torna a dire che la Brianza " comunemente si determina tra l'Adda e il Lambro, e da Usmate a Lecco, alla quale opinione noi ci siamo accostati " (169).
Fin qui niente di nuovo: si tratta, nel complesso, dell'antico territorio brianzolo. Ma soggiunge che al suo tempo comunemente solevasi darle un'estensione ben di molto maggiore, e cioè " altri hanno creduto comprendervi Vimercate, con molti ameni colli dall'altro lato posti lungo la destra del Lambro: ed ora amano alcuni estenderla sin dove nei d'intorni si gode di una singolare amenità e salubrità dell'aria " (170).
Queste due opinioni non potevano essere comuni nello stesso tempo, per la contraddizione che nol consente: doveva essere o l'una o l'altra. A mio credere, la prevalente o comune, al tempo del Redaelli, doveva probabilmente rimanere ancora quella tradizionale alla quale egli si è accostato: le tradizioni sono dure a morire. Lo stesso Cesare Cantù anni dopo non dubitava di asserire che i più conterminavano la Brianza fra il Lambro e l'Adda, i monti della Vallassina e le ultime ondulazioni delle prealpi che morivano ad Usmate (171).
L'altra opinione, che pure andava prendendo voga, non ci porge che un non so che di elastico, di personale, di genericamente discordante, e non di un largo e preciso uso popolare veramente comune.
Nel 1833, l'austriaco Carl Gzoernig, scriveva che " La Brianza non ha confini definiti, il nome indica una piaga ora più ristretta, ora più ampia ". E, a suo parere, l'estensione della Brianza comprendeva allora otto distretti, cioè quelli di Cantù, Erba, Lecco, Oggiono, Brivio, Missaglia, Vimercate e Verano (Carate), dei quali i primi sei appartenevano alla provincia di Como, gli ultimi due a quella di Milano. Questi otto distretti coprivano una superficie di quasi 12 (11.81) miglia quadrate, con una popolazione di 154.673 abitanti, ossia circa 13.080 abitanti per miglio
quadrato (172).
Fra gli scrittori dell'ottocento chi diede forza a questa seconda opinione o pareri diversi furono in particolar modo i due fratelli Cantù, i quali per conferire un maggior respiro ed interesse ai loro scritti su la Brianza ne allargarono di molto i confini. E data la fama di cui erano circondati al loro tempo, il loro modo di pensare e di scrivere fece quasi testo.
Ignazio Cantù affermò infatti che " nell'indicare i confini della Brianza discordano gli scrittori e l'uso volgare, chiudendola quelli fra il Lambro e l'Adda, Usmate, la Canonica e i monti della Vall'Assina, questo invece dandole un'estensione molto maggiore. In tale disparere m'accosto più volentieri al significato popolare perché ai dì nostri ha una forza di prevalenza, e perché dà al mio lavoro più ampiezza e interesse ". E più chiaramente nella Guida della Brianza scrisse: " gli scrittori, dissi anche altrove, non assegnarono alla Brianza precisi confini, né questi sono determinati dall'uso comune, allargandoli o restringendoli quegli e questo a seconda del bisogno e di mille circostanze " (173).
Cesare Cantù asserì che " Brianza è denominazione della quale non si conoscono né l'origine, né il significato, né i limiti, sebbene i più la contermino fra il Lambro, l'Adda, i monti della Vallassina e le ultime ondulazioni delle prealpi che muoiono a Usmate. Più specialmente sarebbe arrogato quel nome alla successione di colline che, presso Agliate staccandosi dal Lambro e variamente serpeggiando a settentrione più rapide ergendosi fino a Sirtori, ove volgono a meriggio, e dopo breve tratto si dividono in tre rami: due camminano paralleli verso il sud, e sul più orientale, che domina la valle di Rovagnate, campeggia quel che già era convento delle benedettine di Bernaga; l'occidentale s'imbosca, finché graziosamente s'incorona della Montevecchia; il terzo ramo curvasi selvoso a ponente, e al lembo di questo sorge Missaglia.
Così vaga di confini, forma però un complesso non solo per la natura del terreno e del clima, ma anche per gli avvenimenti. E ben meriterebbe se ne tessesse una storia, la quale abbandonasse le avventure generali d'Italia o della Lombardia, per rappresentarci il vivere proprio d'una provincia, di cui i signorotti un tempo, dappoi gli abitanti avevano interessi comuni, e in comune li regolarono. La rivoluzione che conculcò e ricordi e simpatie per distribuir popoli e paesi colla bilancia, col trabucco, e coll'abachino, attribuì la maggior parte della Brianza a Como, con cui non ha legame né d'interessi né di memorie, né di simpatie. Ma la Chiesa, costante nelle sue tradizioni, conservò all'arcivescovo di Milano la giurisdizione su tutto quel paese; ed è distribuito ecclesiasticamente fra le pievi di Vimercate, Missaglia, Brivio e Merate, Oggiono, Incino, Cantù, Mariano, Desio, Carate, Agliate, Besana, Casatenovo, colla popolazione di circa 200 mila anime. Suole aggregarvisi anche la Vallassina " (174).
A queste asserzioni di Cesare Cantù si può fare qualche osservazione.
Innanzitutto non è vero che della Brianza proprio nulla si può conoscere riguardo al suo significato, alla sua origine, ed ai suoi limiti. Nemmeno si può dire, a rigore di termini, che l'ampio sopradetto territorio formi un complesso unico per la natura del terreno, del clima, degli avvenimenti. E tanto meno si può asserire che gli abitanti ebbero interessi comuni e insieme li regolarono. Soltanto coloro che appartennero all'Università del Monte di Brianza ebbero in comune particolari interessi e insieme pensarono ai casi loro.
La Vallassina inoltre, come si è detto, si resse con particolari Statuti fino al 1765 in cui venne eguagliata agli altri paesi dello Stato Milanese.
È per lo meno strano che né l'Ignazio Cantù né il fratello Cesare facciano cenno dei privilegi e degli estimi del Monte di Brianza per cui venne a formarsi territorialmente l'entità briantina che durò più secoli.
Non va dimenticato Giovanni Dozio, un brianzolo dottore dell'Ambrosiana, fiorito contemporaneamente ai Cantù, il quale con maggiore esattezza lasciò scritto che la Brianza " ha per suoi confini a nord i monti di Pusiano, Civate e Valmadrera; a levante è lambita dall'Adda da Malgrate fino a Trezzo; a mezzodì ha per confini Trezzo, Vimercate, Arcore, Canonica Lambro; a ponente il Lambro ". E soggiunge
" So bene che altri danno confini più ampi includendovi il Piano d'Erba, ma quel distretto rivale per fertilità e amenità a qualsiasi più venturato angolo della Brianza, sta da sé " (175). Con amore e serietà d'intenti si era proposto di indagare le vicende della Brianza mediante monografie e relativi cartolari, ossia pieve per pieve. Ma non poté darci che le Notizie delle pievi di Vimercate e di Brivio, poiché la morte lo colse prima di condurre a termine il suo lodevole divisamento. Se la storia è fatta di sintesi, poiché questa fornisce la visione ideale e permette un giudizio d'insieme, non meno importanti sono i particolari contributi d'indagini dai quali deve partire quella sintesi per riuscire esatta e non arbitraria.
Fra i molti che, dopo i due Cantù e il Dozio, scrissero della Brianza, meritano di essere ricordati il Nebbia, il Visconti, il Pracchi, il Riva, i quali pubblicarono interessanti monografie, ma più o meno discordi per ragioni diverse nel determinarne i limiti (176).
A questo punto il lettore potrebbe domandare: in definitiva quali sono i confini della Brianza?... Se si prescinde dall'antica Università territoriale del Monte di Brianza, non è possibile dare una risposta soddisfacente in mancanza d'altri documenti chiarificanti: i suoi limiti rimangono e rimarranno sempre oscillanti e discussi da ognuno a seconda del proprio punto di vista (177).
Né vale affidarsi ciecamente al così detto uso popolare che per sé stesso è vago ed incerto, e talora fallace, e del quale non raramente si abusa coll'affibbiargli ciò che interessa di affermare, pur ammettendo che in certi casi, ossia quando non ci sono ragioni in contrario, l'uso comune possa far testo.
Mancando ogni freno, in così fatta incertezza si è giunti a formare una nuova, moderna Brianza, con un vastissimo territorio che ad ovest raggiunge i limiti dell'antico contado de Seprio e dell'antico territorio comasco; a nord dalla Vallassina scende fin quasi alle porte di Milano; e ad oriente l'Adda fino a Cassano d'Adda che la separa dalla provincia di Bergamo e di Cremona: e ciò mentre gli atti ufficiali ci assicurano che il Monte di Brianza, o Brianza come oggi si dice in modo più spiccio, altro non era che una parte della Martesana superiore (178).
Si viene in tal modo ad abbracciare un territorio non omogeneo e di tale estensione, i di cui abitanti in buona parte, e particolarmente quelli dell'estremo nord e dell'estremo sud, non ebbero tra di loro legami di interessi e di tradizioni.
Per l'Associazione " Amici della Brianza " con sede in Erba, la Brianza sarebbe quel lembo di terra ambrosiana che, press'a poco comprende il comprensorio
oro-idrografico del Lambro, dalle origini del fiume presso Civenna in Vallassina fino a Lambrate da nord a sud, e per il largo dall'Adda al torrente Seveso. Un territorio con 163 Comuni, facendone derivare il nome da un fantastico Lambrianza (179).
Senonché la Brianza in quanto entità storica, si è formata e qualificata, come altre regioni, per eventi umani e non per altri motivi. Che poi possa e debba essere illustrata nei suoi rilievi geo-fisici ed economici è un altra cosa.
Essa ebbe origine, e non è male richiamarlo, dalle immunità ed esenzioni concesse a quegli abitanti dai Visconti e da Francesco I Sforza, per cui venne a costituirsi l'Università del Monte di Brianza, ossia con riferimento a quel colle o monte circondato da un nebuloso alone di celebrità per antichissimi fatti locali a noi rimasti oscuri.
Se fossero mancati questi elementi, la Brianza sarebbe rimasta una generica plaga morenica, sia pur bella, come tant'altre, e fors'anche chiamata con altro nome.
Del resto, come dissi già altrove, non è poi raro sentir distinguere tuttora, con una certa quale aderenza storica, la Vallassina, il Pian d'Erba, il Canturino, il Lecchese, il Monzese, riservandosi il termine di Brianza a quella parte tra l'Adda e il Lambro, che fu e dovrebbe essere la vera Brianza.
Ad ogni modo, qualunque siano i confini che si vogliono o si vorranno assegnare alla Brianza, bisognerà pure nel miglior modo possibile appoggiarli su basi positive, su documenti, e non stiracchiarli più o meno in lungo e in largo a proprio talento, sia pure per dare maggiore interesse o importanza all'argomento riguardante la Brianza che si ha alle mani, non dimenticando che quod gratis asseritur gratis negatur (ciò che gratuitamente si asserisce, gratuitamente può essere negato).
Da ultimo ritengo che non valga la pena di discutere l'opportunistica affermazione di coloro i quali dicono e scrivono che, dopo tutto, allargandone i confini, non si danneggia alcuno e si accontentano molti. Purtroppo una sol cosa esce danneggiata: la verità storica delle sue origini, e della sua formazione.
|
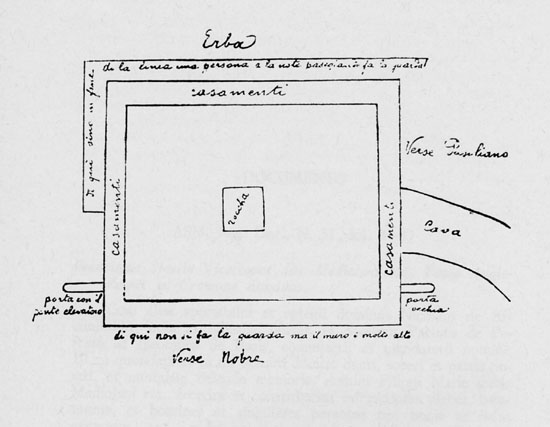
|
|
|
Schizzo del castello di Monguzzo, allegato alla lettera di Coppolato.
(Archivio di Stato di Milano, Carteggio generale, ottobre-dicembre 1530).
|
|
|
|
|
DOCUMENTO
ASM, Reg. Duc., N. 51, fol. 84-87
Franciscus Sfortia Vicecomes dux Mediolani etc., Papie Anglerieque ac Cremone dominus.
Cum alias spectabiles et egregii dominus Nicolaus de Arcimboldis, nunc consiliarius noster, et dominus Pacinus de Perusio ac Iacobinus de Bosis, commisarii et mandatarii nomine Ill.mi quondam et ex.mi domini domini ducis, soceri et patris nostri, et nunquam delende memorie, domini Filippi Marie ducis Mediolani etc., fecerint et constituerint infrascriptas plebes, communia, et homines et singulares personas pro bonis ut infra exemptos etc., videlicet totam plebem Galarate (Garlate), totam plebem Ugloni, totam plebem Brippii cum Roncho, et totam plebem Massalie. Item squadram de Maueris cum Bosisio et Gambagnate Rupto, et hoc pro bonis que tunc habebant in dictis plebibus, squadra ac locis et territoriis tantum. Item infrascriptos pro bonis que habebant in squadra de Nibiono plebis Incini tantum, videlicet in locis et territoriis post unumquemque eorum descriptis tantum, et pro bonis que tunc temporibus habebant tantum. Ita tamen quod si aliqui ex eis laborarent aliqua bona aliena non exempta pro eis solvere tenerentur. Primo: heredes Guillielmini de Rippa de Galbiate in loco de Petana; Augustinum de Rippa in loco de Calvenzana; Johannem de Isachis in suprascripto loco Calvenzane; heredes Maffini de Isachis pro bonis que habebant in locis Nibioni et Tabiaghi cum mollandino de La cirexa; Paulum de Rippa in Tabiagho et Nibiono; Petrum de Salla in loco Calvenzane et Rozano (Rogeno); heredes quondam Curtini de Geroxa in loco de Calvenzane; Grappellum et fratres de Curte in loco Calvenzane; heredes quondam Conti de Madio in locis de Petana et Rozano; Jacobinum de Isachis in locis Tabiaghi et Nibionni; dominum Johannem de La canalla pro bonis que habebat in Somarino; Johannem et Bosium ac fratres de Maueris pro bonis que habebant in loco Petane; Simoninum, Antonium et Andreinum fratres de Nava, et Bertinum eorum nepotem, in locis Nibioni et Mazulini (Maggiolino); Antonium de Isachis in Berzescho (Bracesco); Girardum et fratres de Rigamonte in Sugarono (Cibrone); dominum Bendinum de La canalla in Mazolino; Girardum de La bonacina pro bonis que habebat in Somarino, Tirighori (Tregolo) et Masnagha; Papam de Amatis de Mozana pro mollandino de Lacrota; heredes quondam Testoni de Uglono pro bonis que habebat in Trigori. Item infrascriptos pro bonis que tunc habebant in plebe Aliate, videlicet in Locis et territoriis post unumquemque eorum descriptis et pro illis bonis que tunc habebant tantum hoc tamen intellecto quod si collerent vel ad fictum tenerent alia bona quam propria pro ipsis solvere tenerentur, hac exemptione non obstante, que tamen respectu propriorum firma remaneret, et etiam non obstante quodam decreto ducali in contrarium disponente; heredes quondam Antonii de Casate de Monte pro bonis que habebat in Monte, Valle, Vedugio et Besana; heredes quondam Cavalerii de Ferrariis de Monte, in Monte et in Valle; heredes Iacomoli de Maffis de Monte, in Monte et Cassalia; heredes quondam Mafioli de Riboldis de Besana, in Besana, Cazano, Balgano et Renate; heredes Gasparis Ayroldi de Besana in suprascriptis proxime locis; heredes Petri de Besana ut supra proxime; heredes Minolli de Riboldis de Besana ut supra proxime; Stefanolum de Giovenzana in Besana superiori et inferiori; heredes Petrazzolli de Labarreta in Besana superiori; Nigrum de Rendatoribus de Perego in Ranchate; Franciscum, Gasparrinum, et Johannem de Perego in Renate; Guilielmum et Johannem fratres de Rendatoribus de Perego pro bonis que habebant in Renate, Viganore (Vianò) et Casareto; Vaninum et Stefanum fratres de Perego filios quondam Lanoye pro bonis que habebant in suprascriptis locis Renate, Viganore et Casareto; Donatum de Perego filium quondam domini Guilielmi, et heredes quondam Gulielmoli, ac Rubeum de Perego filium quondam Compagnoli pro bonis que habebant in suprascriptis proxime locis; heredes domini Finoli de Rippa in Colzano; Bertinum de Nava in Monte; heredes quondam Gasparris de Rippa in Besana; Pedrazinum de Bartezagho pro bonis que habebat in Valle, Zuchorino prope Montem et Besanam. Item infrascriptos pro bonis que habebant in plebe Aliate ultra Lambrum prope Montem et Besanam. Primo: dominum Filippum de Andriotis de Rippa de Galbiate pro bonis que habebat in loco de Zergnieto; Gabrielem de Rippa de Galbiate pro bonis que habebat in Villaravario; heredes quondam Guilielmi dicti Sighezie pro bonis que habebant in Tornagho; dominum Simonem, Johannem et Ambrosium fratres de Rendatoribus de Perego pro bonis que habebant in Viganore et Capriano; Antonium de Nava in Vedugio; Bernardum de Madio pro bonis que habebat in Ruzinigo (Rosnigo). Item Antonium de Abdua et massarios suos pro bonis que habebat in loco de Bernate plebis Vicomercati tantum. Item infrascriptos pro bonis que habebant in plebe Vicomercati, videlicet: dominum Johannem de Molgula pro bonis que habebat in locis et territoriis de Bernadigio et Villanova; Bernardinum de Lavello filium quondam domini Zenardi in burgo et territorio Vicomercati; Filippum de Andriotis de Rippa de Galbiate pro bonis que habebat in Zergnio et Pegorino et eorum territoriis. Item infrascriptos in plebe Pontiroli, videlicet: dominum Vincentium de Cornu de Porchera pro bonis que habebat in locis et territoriis de Colnagho, Busnagho et Portu; heredes quondam domini Tadioli de Vicomercato, ac heredes quondam domini Bassiani de Vicomercato pro bonis que habebant in loco et territorio de Ronzello, et collentes et eos qui per tempora collerent et habitarent de eorum bonis ut supra. Que suprascripte plebes, communia et heredes ac singulares persone ut supra exempte preserventur et preservari debeant et manuteneri pro tempore curso a Calendis Ianuarii anni 1440 proxime preteriti citra, et etiam de cetero in perpetuum immunes, liberi et exempti, ac libera, immunia et exempta ab omnibus et singulis oneribus et decretis quibuscumque, taleis, mutuis, focis, imbotaturis quorumcumque fructuum, inventariis condiciis et subsidiis, guastatoribus, custodiis, impositionibus, officialium salariis, furnimentis, stipendiariis, et graviminibus, et generaliter oneribus quibuscumque cuiuslibet generis et maneriei, et quocumque nomine contingant nuncupari, tam realibus quampersonalibus atque mixtis, at tam ordinariis quam extraordinariis impositis seu quomodolibet per ducalem dominationem, vel officiales suos, vel per Commune Mediolani, vel agentes pro eo, ipsis exemptis sive alicui vel aliquibus eorum et tam in universo quam in singulari, et tam generaliter quam specialiter, excepto tamen, onere salis pro tempore tunc futuro, et exceptis datiis ordinariis transitus seu transversi, et conductionibus merchantiarum et rerum ad civitatem Mediolani, et exactionibus extra territorium Mediolani, datiis mercantie et ferraritie Mediolani, panis, vini et carnium et doane, quibus subiacerent alii. Ita et taliter quod prelibatus quondam dominus nec eius Camera necCommune Mediolani, nec officiales eorum, nec alicuius eorum, nec aliqua alia persona pro eis vel eorum nomine non possent nec valerent quovismodo vel pretextu vel per modum alicuius decreti, proclamationis, vel litterarum aut alicuius impositionis generalis vel spetialis quomodocumque quicumque petere, requirere, consequi nec habere a dictis exemptis nec ab aliquo nec aliquibus eorum in universo nec in singulari, nec super eorum, nec alicuius nec aliquorum eorum bonis ubicumque sitis ut supra. Et quod, occasione predictorum omnium, dicti exempti omnes simul et coniunctim, videlicet quilibet eorum pro rata sui extimi tenerentur et deberent solvere prelibato quondam domino seu eius thesaurario certam, et ibidem expressam, omni anno pecunie quantitatem. Ita etiam, et hoc declarato, quod prefatus quondam dominus dux, nec eius camera, nec agentes pro eo vel pro ea, nec Commune Mediolani aut agentes pro eo, nec officiales eoruna, nec aliquis eorum, nec aliqua alia persona pro eis vel eorum nomine non possent nec valerent, nec eis aliqualiter liceret, nec lìcitum foret aliqua datia, nec aliqua onera realia, nec personalia, nec mixta, ordinaria nec extraordinaria, nec alicuius alterius maneriei quocumque nomine nuncupari contingeret, etiam si talia forent de quibus oporteret mentionem fieri spetialem vel individuo facere, excepta gabella salis et datiis ordinariis transitus, et ut supra, imponere et petere, requirete et exigere, nec habere, nec imponi, requiri, peti, nec exigi facere dictis exemptis nec alicui eorum in universo nec in singulari, nec in nec super eorum bonis, nec eorum massariis, fictabilibus, mezadris, aut factoribus vel collonis, vel super rebus vel fructibus eisdem per tempora pertinentibus etiam si alias solvi vel exigi solita fuerint, nec solvere tenerentur nec cogi possent ad solutionem alicuius cambii thesaurarii exactorii caneparie suprascripte quantitatis pecunie solvende ut sopra, nec etiam pro illis quantitatibus que secundum formam et tenorem instrumenti eiusmodi conventionis et contentorum in eo solvi debuissent ut supra, dummodo suis et contentis terminis satisfarent. Hoc etiam declarato quod omnia bona immobilia tam clericorum quam laycorum que participarent vel participare contigerent beneficio dicte exemptionis seu dictarum exemptionum, non tamen excedendo declarationem supra factam locorum et personarum, tenerentur ad solutionem dicte quantitatis pecunie in dicto instrumento specificate ad ratam pro rata bonorum participantium ut supra, et quod si aliqui ex illis qui gaudere deberent dicta exemptione fuissent negligentes, infra decem dies post factum sibi preceptum per deputatos super receptionem dicte pecunie, in solvendo eorum contingentem portionem in terminis ordinatis canepario qui fuisset deputatus, quod licere aliis in dicta Universitate exemptorum ab ipsis talibus exigere imbotaturas et quelibet alia onera prout facere potuisset camera ducalis, seu Commune Mediolani aut agentes pro eis, si nullam ipsi tales haberent exemptionem. Et hoc pro illo anno quo fuissent negligentes ut supra, etc., et prout constat publico instrumento rogato per Gabrielem de Micheriis notarium Mediolani anno 1440 die dominico, quinto mensis, seu anno, die et mense in eo contentis. - Nunc vero cum ipsis effectibus experti fuerimus integram erga nos et statum nostrum fidem et devotionem dilectissimorum nostrorum hominum Montis Brigantie et Marthesane superioris ac partium circumstantium, nec minus firmissimam, qua adversante olim nobis et sibi fortuna, constantiam et tollerantiam invictissimis animis usi continue fuerunt in sustinendis et reprimendis pro posse invasionibus hostium, supportandisque gravissimis iacturis quas cum ipsis hostibus tum quoque ab exercitu nostro passi diversimode fuere, multa nos invitarent ut ipsos homines liberalitate et gratia, et favoribus nostris presequamur. Primum quidem exempla Ill.rum quondam predecessorum nostrorum, qui cum homines suprascriptos exemptionibus et gratiis suis continue donaverint, nos ad eorum imitationem induxerunt, dehinc continuata semper eorumdem hominum erga prefatos dominos predecessores nostros affectio et promptitudo a qua numquam comperti sunt deviare; accedit etiam consideratio, situs partium ipsarum et denique hominum eorumdem in rebus bellicis probitas et laborum tollerantia qua plurimum comendantur. His autem et multis aliis rationibus non immerito moti, et considerantes ultra que supra memoravimus diversa et gravissima damna, pericula, incendia, captivationes, et bonorum ac fructum spoliationes aliasque infinitas iacturas quibus in proximis bellorum strepitibus affecti sunt, decernimus cum eis ita agere quod intelligant benemerita sua apud nos cognita esse atque gratissima, et maiorem concessis per prefatum nunquam dellende memorie patrem et socerum nostrum honorandissimum, suosque predecessores Illustrissimos dominos Vicecomites liberalitatem et gratiam nostram impartiri atque concedere Ex certa igitur scientia, motuque proprio et de nostre potestatis plenitudine etiam absolute, easdem plebes, communia et homines et singulares personas in dicta concessione de qua supra et superius expressos pro se et bonis ut supra expressis necnon infrascriptas personas de quibus infra et pro bonis infrascriptis, si et quatenus bona ipsa sint ultra Lambrum versus flumen Abdue, et ita et taliter quod pro bonis et personis infrascriptis immediate nobis non suppositis non teneamur ad aliquam remissionem infrascripte annualis pecunie quantitatis nobis ut infra solvende, si hac concessione exemptionis et infrascriptis per nos concessis, ipse infrascripte persone immediate nobis non supposite vel pro nobis immediate nobis non suppositis, ut supra, gaudere aliqualiter prohiberentur, que tamen persone pro nobis ipsis nobis immediate non suppositis, tantum in dicta annuali solutione non graventur. Ita etiam et taliter quod si ex ipsis supra vel infra nominatis, tam in genere quam in specie, reperirentur esse aliqui a nobis vel a predecessoribus nostris in ducatu habentes immunitatem vel exemptionem, quod nihilominus ipsi tales teneantur pro eorum rata quantitatum nobis ut infra solvendarum, dicta tali exemptione vel immunitate non obstante, exceptis tamen Iohanne de Molgula, Antonio de Molgula et Johanne de Calcho, quibus exemptiones et immunitates per nos eis concessas servari volumus et intendimus ad nostrum beneplacitum; pariformiter etiam excepta villa de Imbersago quam ad nostrum beneplacitum exemptam et immunem preservari volumus et iubemus, volentes ac deelarantes et mandantes quod de dicta summa nobis annuatim, ut infra, solvenda quolibet anno, defalcentur et detrahantur ille quantitates que eos de Molgula et de Calcho et villam de Imbersago digne tangere verisimiliter possent ex ipsa quantitate nobis ut premittitur exsolvenda, nec ceteri pro eis se gravari possint et querellari. Primo: heredes Gulielmini de Rippa de Galbiate pro bonis que habent in Mazolino; Gabrielem de Rippa pro bonis que habet in ipso loeo Mazolini; Johannem de Lacanalle pro bonis que habet in Somarino; et Johannem et Bosium ac fratres de Maueris pro bonis que habent in Camasiascha et Breno; Antonium de Isachis pro bonis que habet in Camasiascha, que tenentur per Zanetum fornaxarium; Girardum et fratres de Rigamonte pro bonis que habent in Centemero; Bendium de La canalle pro bonis que habet in Camasiascha; Vaninum et Antonium fratres de Consono pro bonis que habent in Recouro (Recupero); Donatum de Anono pro bonis que habet in Roxanexo; heredes Bendii de Lacanalle pro bonis que habent in Mazolino cum mollandino; Dominicum et Gasparem filios quondam Tognoli de Maueris pro bonis que habent in Centemero; Lafranchum de Bulziagho et Martinum de Cazanigha pro bonis que habent in Colzano; heredes Marcoli et Luchini de Riboldis de Besana pro bonis que habent in Valle, cum presbitero Mafeo pro bonis paternis; Stefanolum de Giovenzana pro bonis que habet in Besana, sive dominum presbiterum Antonium Lafranchum et Magistrum Raynaldum fratres de Abdua pro bonis per ipsos ut dicitur a dicto Stefanolo in ipso loco Besane emptis; heredes quondam Gulielmi dicti Brigheti de Seregnio pro bonis que habent in Bruschò et Colzano; heredes quondam Johannis dicti Tavernini pro mollandinis et aliis bonis que habent in Aliate; heredes quondam Martini de Lacassina pro bonis que habent in Villaravario; Simonem et fratres de Rendatoribus de Perego pro mollandino de Aliate, sive in territorio de Varano, sive in fiumine Lambri; Antonium de Nava pro bonis que habet in Corazana; heredes quondam magistri Raynaldi de Ayroldis de Robiate pro bonis que habent in Cavanagho; Antonium et Dionisium eius nepotem de Ayroldis de Robiate pro bonis que habent in loco de Bernadigio; Johannem de Vicomercato pro bonis que habet in burgo et territorio Vicomercati; Stefanum de Vicomercato filium quondam Marzoli pro bonis que habet in Gradi (Agrate), heredes quondam Rebuchi de Abdua, heredes quondam Guilielmi de Abdua, et heredes quondam Teoldini de Lavacarezia pro bonis que habent in Cornate; Gasparrinum de Brianzia conestabilem pro bonis que habet in Colnagho; heredes quondam Petroli de Lavacarezia pro bonis que habent in Cornate. Tenore presentium exemptos facimus et immunes ab omnibus et singulis oneribus de quibus supra necnon respectu dumtaxat dictarum plebium Galerate (Garlate), Ugloni, Brippii cum Roncho, et Massalie a datiis panis, vini et carnium, necnon pro suprascriptis singularibus personis que sunt plebis Aliate nostri ducatus Mediolani a dictis datiis panis, vini et carnium, cum et quando ceteri de ipsa plebe Aliate exmptionem a nobis obtinuerint pro ipsis datiis panis, vini et carnium. Insuper liberamus, quietamus et absolvimus dictas plebes, communia, et homines, ac singulares personas de quibus supra, ab omnibus et singulis debitis quavis causa et occasione hinc retro factis seu contractis per dictos Communia, et homines, et singulares personas, vel aliquos ex eis tam cum camera prelibati quondam Illustrissimi domini ducis domini Filippi Marie quam predecessorum suorum, quam etiam cum Communitate Mediolani, et etiam ab omnibus condemnationibus tam ad dictam cameram quam ad cameram dicte comunitatis seu Communis Mediolani hinc retro factis, ita ut omnino liberati sint et absoluti prorsus sine aliqua solutione pecunie vel rei et sine ulla mollestia et impensa, remotaque omni exceptione et non obstantibus aliquibus in contrarium, exceptis debitis occasione salis pro quibus teneantur dicta Communia et homines vel aliqui ex eis, tamquam posterii seu gabellatores seu officiales sive tempore vite bonememorie prefati quondam domini ducis domini Filippi Marie, sive inde citra post eius mortem, et excepto iure et sine preiudicio cuiuslibet juris tertii, a quibus non intendimus quietare nec liberare.
Pro qua quidem immunitate et concessione et liberatione antedicta convenerunt nobiscum dicte plebes communia et homines, seu pro eis agentes, dare et solvere nobis, seu camere nostre seu thesaurario nostro generali, florenos duos mille a solidis triginta duobus pro singulo floreno pro anno, silicet 1450 proxime preterito, et ah inde in antea omni anno in perpetuum florenos duos mille quatuorcentum ad dictum computum solvendos pro medietate videlicet in festo sancti Martini, et alia medietate in festo nativitatis domini nostri Jesu Xpi cuiuslibet anni sine alicuius cambii solutione, factis ipsis solutionibus in dictis terminis, omni exceptione remota, eamque concessionem immunitatis et exemptionis ea lege fecimus et facimus, ita tamen quod nobis liceat et licitum sit per magistros intratarum nostrarum ordinariarum seu per deputandos a nobis vel ab eis facere limitationem et limitationes quantitatum vini, bladorum et feni pro quibus serventur et servari debeant exemptiones respectu imbotaturarum suprascriptis domino Johanni de Molgula pro bonis que habet in locis et territoriis de Bernadigio, de Villanova plebis Vicomercati; Bernardo de Capitaneis de Lavello filio quondam domini Zenardi pro bonis que habet in burgo et territorio de Vicomercato; Filippo de Antriotis de Rippa de Galbiate pro bonis que habet in Zergnio et Pegorino et eorum territoriis; domino Vincentio de Cornu de Porchera sive heredibus suis pro bonis que habent in locis et territoriis de Colnago, Busnago et Portu plebis Pontiroli; heredibus quondam Tadioli de Vicomercato, ac heredibus quondam Bassanini de Vicomercato pro bonis que habent in Ronzello et territorio, necnon suprascriptis omnibus aliis singularibus personis superius expressis, que honeste et debite videbuntur ipsis magistris, aut per nos aut per eos deputandis, dictis tamen omnibus et singulis exemptionibus de quibus in presenti concessione, sive in spetie sive in genere fit mentio, per nos concessis, tam respectu aliorum bonorum quam etiam respectu aliorum onerum, firmis et in suo robore permansuris et sine eorum preiudicio. Intelligendo tamen quod prenominati solummodo exempti sint ut supra et ut supra in quattuor plebibus videlicet Galarate (sic), Ugloni, Massalie, et Brippii cum Roncho, ac pro bonis ultra Lambrum versus Abduam ut supra et ut supra pro personis superius expressis in plebidus Vicomercati, Pontirolli et Aliate, ac in squadris de Maueris et Nibiono, videlicet in locis superius nominatis, pro illis dumtaxat bonis que ibidem habent de presenti, non autem pro bonis que de cetero acquirent et acquirere possent, quas limitationes facere possint si et quando eisdem magistris aut deputandis ut supra videbitur et placuerit. Insuper, ad tollendas seu minuendas impensas et ad evitanda discrimina iterum concedimus dictis plebibus et locis exemptis ut supra, silicet plebi Galarate (sic), plebi Ugloni, plebi Brippii, et plebi Massalie cum Roncho, quod eorum expensis tamen tenere possint officialem unum qui iura ministret in civili in partibus Montisbriantie usque ad quantitatem duntaxat librarum viginti tertiolorum, et cum eo habeant iudiciale banchum in partibus illis tantum, quodque Capitaneus Martexane nec alius officialis intromittere se possit nec intromittat de dicto officiali tenendo nec de eius iurisdictione absque nostra spetiali delegatione vel commissione sub pena indignationis nostre. Mandantes regulatori et magistris intratarum nostrarum tam ordinariarum quam extraordinariarum, necnon potestati nostro Mediolani, ac Vicario et duodecim provisionum Communis nostri Mediolani presentibus et futuris ceterisque officialibus et subditis quibuscumque nostris, ad quos spectat aut spectare possit quomodolibet in futurum, quatenus has nostras, concessionis immunitatis, exemptionis et gratie litteras observent et firmiter faciant ac inviolabiter observari, contra eas non intentantes nec intentari aliqualiter facientes aut permittentes pro quanto gratiam nostram caripendunt. In quorum testimonium presentes fieri et registrari iussimus etc.
Datum Laude die XXII decembris 1451. Cichus
LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO
NELLA BRIANZA
INTRODUZIONE
Quando e come penetrò e si diffuse il cristianesimo nella Brianza; quando e come vi si formarono le pievi o primitive parrocchie, sono due punti di storia ecclesiastica quanto mai incerti ed oscuri; oscurità ed incertezza che del resto si stende a tutto il nostro territorio lombardo e oltre. La ragione si è che mancano sicure e precise fonti documentarie e tradizionali per poter giungere a delle conclusioni veramente positive. Si noti, infatti, che le prime memorie cristiane nella Brianza datano dal V secolo, e il primo accenno di una pieve, quella di Missaglia, solamente verso l'anno 835.
Perciò non si può fare altro che prospettare delle ipotesi o congetture approssimative per via di riferimenti, basandosi prevalentemente sopra probabili indizi.
Il campo è diviso in due scuole: la critica e la tradizionalistica. La prima insegna a procedere con grande cautela e riserbatezza, la seconda segue criteri meno sicuri in quanto che, nella penuria di documenti integri e genuini, si appoggia al testimonio delle tradizioni locali o leggende e talora ad interpretazione arbitraria di fonti in contrasto colla sana critica.
In fatto di tradizioni e leggende bisogna procedere ben guardinghi per non dare corpo a delle ombre, perché sono frutto, per lo più, della pietà o del pio desiderio che un dato avvenimento sia in qualunque modo accaduto, e quindi nascondono il capo in racconti tardivi inverosimili ai quali non si può prestare credito.
La tradizione, inoltre, ha valore solo quando emana da fonte sicura, non è interrotta, né stanno contro di lei argomenti indiscutibili.
" Né, scrive il gesuita padre Savio, a sostegno di tradizioni così vacillanti sotto il rispetto storico, si può giustamente invocare l'autorità religiosa. La dottrina cattolica tiene per infallibili e obbligatori per la coscienza dei cristiani, soltanto i giudizi che il Papa pronuncia ex-cathedra, ossia come maestro universale di tutta la Chiesa, e che riguardano la fede ed i costumi (il vero ed il lecito), ossia il deposito della divina rivelazione. Ora tali non sono i fatti contenuti nelle vite dei Santi, né mai i Pontefici hanno presentato tali fatti come oggetto obbligatorio della fede di tutti i credenti. Né si può dire che l'inserzione dei fatti medesimi nei libri liturgici quali il breviario, il martirologio e simili, equivalga ad un giudizio ex-cathedra, nelle verità loro; poiché (lasciando pure l'argomento testé indicato, ch'essi non fanno parte della rivelazione) lo scopo di detta inserzione fu solo il fomentare con pie letture devozione dei fedeli.
Il fatto che i Papi stessi tolsero più d'una volta dal breviario e dal martirologio certi racconti di mano in mano che si provava la loro falsità (per es. la conversione di Costantino per opera di S. Silvestro, l'apostasia di papa Marcello), dimostra evidentemente ch'essi, ordinando l'inserzione di quei racconti nei libri suddetti, non intendevano definire la loro verità storica " (180).
Senza trascurare la scuola tradizionalista, seguirò pertanto di preferenza quella critica (181), ma sempre in linea di massima, perché la propagazione del cristianesimo e la sua organizzazione nei primi secoli è un fatto rimasto ancora tanto complesso e oscuro da farci diffidare delle conclusioni troppo schematiche. Riteniamo in tal modo di accostarci meglio alla verità.
I
LA DIFFUSIONE DEL CRISTIANESIMO
NELLA BRIANZA
I cultori di storia briantina che, per il passato trattarono o semplicemente accennarono al nostro argomento, si possono dividere in tre categorie.
La prima, di coloro che se la cavarono con frasi generiche, le quali per sé stesse non dicono nulla (182); la seconda, di quelli, e sono i più, i quali non furono alieni dall'ammettere la propaganda del Vangelo nella Brianza in tempi anteriori al IV secolo (183); e la terza di coloro che posero l'evangelizzazione delle nostre campagne dopo il noto editto di Costantino del 313 (184). Tralasciando di parlare dei primi, vediamo se è verosimile quanto affermano gli scrittori del secondo gruppo.
Essi si basano, anche se non lo dicono espressamente, sulla Datiana Historia (185) o su autori che ad essa attinsero direttamente o indirettamente, poiché la Daziana fu la fonte precipua di tutto ciò che nel passato si scrisse intorno alla storia ecclesiastica più antica di Milano (186).
Orbene, l'autore di quella cronaca vorrebbe darci ad intendere che S. Mona sarebbe stato vescovo di Milano dal 192 al 250, e il primo propagatore della fede nelle nostre campagne, e colui che vi eresse le pievi o parrocchie rurali (187). Se non che la Daziana non solo non è opera del tempo di S. Dazio (188), ma è inoltre infarcita di leggende e di errori, frutti dell'immaginazione del tardo scrittore che la compilò o di altri scrittori cui attinse. Di S. Mona il Savio afferma che, " escludendo la narrazione arbitraria e favolosa" di quella cronaca, nient'altro si può ritenere come certo ch'egli visse non molto prima del 313 (189).
Neppure dal fatto che, durante l'ultima persecuzione mossa da Diocleziano e Massimiano (190), dei cristiani fuggirono da Milano rifugiandosi nel territorio comasco subendovi alla fine il martirio, si può dedurre che ne sia venuta una propaganda cristiana fra gli abitanti del contado. Si dice infatti che siano stati uccisi dai persecutori, che li inseguivano, S. Gusmeo e S. Matteo a Gravedona, S. Fedele a Samolaco, e S. Carpoforo coi suoi compagni vicino a Como. Ma osserva il Baserga che " tutti costoro sono martiri non del luogo ma avventizi. Sono fedeli ma non di queste piaghe, e vi periscono senza avere operato conversioni.
Tutto tace dopo il loro martirio: sono cristiani ma senza seguito: sono come sprazzi momentanei di luce che, appena veduti, spariscono " (191).
Nessun accenno infatti dell'esistenza di cristiani nelle nostre campagne possiamo trovare durante le persecuzioni, ossia nei primi tre secoli, nessun rudere di edifici od oggetti sacri, mentre invece le molte iscrizioni e tombe pagane rinvenute e che di tanto in tanto si scoprono nella nostra regione, appartenenti a quei secoli, ci dimostrano la vigorosa e lunga permanenza del paganesimo sulle nostre terre.
Tuttavia altri, pur prescindendo dalla Daziana, vorrebbero che la fede siasi presto diffusa nell'Alta Italia, ossia nella Gallia Cisalpina, fin dai primo secolo, benché non d'un tratto e dovunque, ma neanche lentamente; prima nelle città, di poi nei pagi e nei vici ossia nella campagna. Essi dicono che là dove i santi Padri e gli scrittori ecclesiastici parlano della rapida diffusione del cristianesimo nelle provincie dell'Oriente, dell'Africa settentrionale e di alcune città e luoghi dell'Occidente (ad es. Roma e dintorni e l'Italia meridionale), si devono ritenere comprese anche le altre regioni, e quindi anche le nostre, benché non se ne faccia alcun cenno.
Certamente che non si deve mai perdere di vista l'insieme generale di un dato problema storico onde intuirne tutti i vari elementi e loro sviluppi, ma non è difficile accorgersi che se la questione della propagazione della fede nelle nostre regioni, in correlazione alla sua diffusione nel mondo allora conosciuto, la si pone in modo unilaterale, senza appoggiarla ad un solido fondamento, si arrischia di lavorare facilmente di fantasia, adattando i fatti alle nostre idee invece che le nostre idee ai fatti.
Questo modo di concepire la storia antica della Chiesa condusse non pochi scrittori a conclusioni erronee, che cioè il cristianesimo siasi propagato in Occidente colla stessa rapidità e diffusione che in Oriente; e che le Chiese occidentali si siano organizzate nel medesimo modo delle orientali; che i martiri d'Occidente nei primi tre secoli siano stati in Italia, nelle Gallie, nella Spagna e nelle altre provincie d'Occidente, numerosi non meno che nelle regioni orientali; che insomma le cose si siano svolte nell'Occidente nello stesso modo, o quasi, che nell'Oriente (192).
Così, il Ferretto, trattando della prima diffusione del cristianesimo nelle campagne del genovesato, non ha fatto altro che adattare a quei luoghi quelle testimonianze che Padri e scrittori ecclesiastici orientali ci lasciarono per le loro provincie (193). E tra le testimonianze citate dal Ferretto vi è pure quella del comasco Plinio il giovane il quale, essendo governatore della Bitinia, si rivolse all'Imperatore Traiano per domandargli cosa dovesse fare contro i cristiani, particolarmente numerosi nella sua provincia dove le comunità infette dal contagio cristiano erano sparse per vicos et agros, e cioè per i villaggi e per le campagne. Orbene dal suo copioso epistolario, dove parla pure di tante minuzie dei nostri luoghi, mai traspare la presenza di cristiani nell'agro milanese e comasco.
Che il cristianesimo lo si trovi diffuso relativamente presto, oltre che nelle città, anche nelle campagne della maggior parte delle provincie orientali, non vuol dire, per ciò stesso, che altrettanto sia avvenuto in quelle occidentali.
I Padri e gli scrittori ecclesiastici contemporanei non avevano ragione di tacerne, ma tutti i motivi per esaltare un tale fatto se realmente accaduto, e quindi, direttamente o indirettamente non ci sarebbe mancata qualche notizia. Tale silenzio, a mio avviso, è un indizio della tarda e lenta diffusione della fede nelle campagne d'Occidente.
Le ragioni vanno ricercate nelle profonde differenze di razza, di mentalità, di cultura: l'Occidente col suo carattere positivo e pratico si diversifica e talora si oppone allo spirito filosofico e speculativo dell'Oriente.
D'altra parte è noto che nelle stesse grandi città dell'Alta Italia, dove per la loro importanza era naturale che convergessero gli sforzi dei primi propagatori del Vangelo, il cristianesimo penetrò alquanto più tardi e non vi si diffuse che lentamente.
Il Savio giunse a porre il principio della conversione delle province occidentali dell'impero, e tra esse quelle dell'Alta Italia, nel secolo secondo (194).
L'Harnack pure arriva alla conclusione, parlando dell'Italia superiore e della Romagna, che il cristianesimo fin " verso l'anno 325 non aveva fatto in esse che magri progressi. Ciò risulta con certezza non solo da testimonianze negative, ma anche dalla storia della Chiesa in quelle parti nel IV e V secolo. Specialmente verso Occidente le traccie del cristianesimo decrescono rapidamente ". E più avanti soggiunge che nelle città maggiori dell'Alta Italia " le comunità cristiane dovevano avere poca importanza verso l'anno 300 " (195) ossia al principio del quarto secolo.
Anche il Duchesne non dubita di asserire che, al finire del terzo secolo, nell'Italia settentrionale e in altre regioni dell'Occidente " i vecchi culti si conservano in onore e i gruppi cristiani costituivano le eccezioni " (196).
Così pure affermano il Lebreton e lo Zeiller (197).
E un indizio, al dire del Lanzoni, " che prima del IV secolo la diffusione del cristianesimo non fu nell'Italia superiore molto intensa, è il numero relativamente scarso di martiri che vi si riscontra " (198).
|
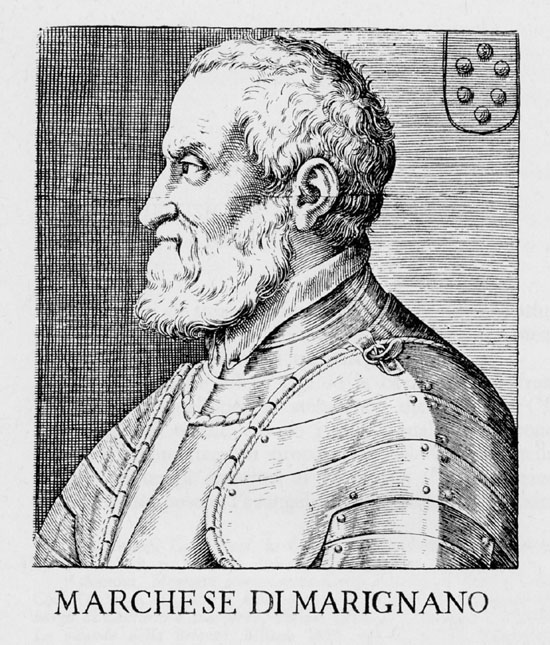
|
|
|
Da: J.P. Tomasinus. Illustrium virorum elogia iconibus exornata, Padova, 1630.
|
|
|
|
|
* * *
A queste conclusioni della scuola critica si oppongono i tradizionalisti col dichiarare che anche nelle provincie occidentali dell'impero, né tardi né lenta fu la diffusione del cristianesimo, e si richiamano alle testimonianze di S. Ireneo, di Tertulliano, e di Sulpicio Severo.
S. Ireneo, vescovo di Lione nella seconda metà del secondo secolo, scrive che la Chiesa era disseminata per tutto l'universo; che il cristianesimo abbracciava diverse lingue; che esistevano Chiese in Germania, fra gli Iberi, i Celti, in Oriente, in Egitto, in Libia, e nel mezzo del mondo (199).
Orbene nulla ci autorizza a ritenere queste generiche espressioni nel senso che il cristianesimo fin d'allora si fosse rapidamente e largamente diffuso in tutte le regioni da lui citate. Egli non dice se queste Chiese fossero dappertutto numerose o meno. D'altra parte è noto che la fede al suo tempo aveva fatto largo progresso nelle provincie dell'Oriente, dell'Africa, in Roma e suoi dintorni, e assai meno in quelle dell'Occidente. S. Ireneo poteva giustamente asserire che la fede era ormai penetrata in tutto l'universo, e cioè in tutto il mondo romano, senza che lo fosse dappertutto in eguale misura, perché era sufficiente che, al momento nel quale scriveva, in Occidente lo fosse in qualche centro principale della Gallia (valle del Rodano), della Spagna, e della Germania lungo il Reno, ecc.; tanto più che a costituire una Chiesa bastava allora anche una comunità di pochi cristiani (200). E che questo modo di intendere le asserzioni di Ireneo sia più conforme a verità, lo prova la storia ecclesiastica dei susseguenti secoli.
Del resto non usiamo pure noi dire che il Vangelo è diffuso in tutto il mondo e fra tutte le genti, benché sappiamo che ancora oggi, a tanti secoli di distanza e di diffusione della fede, non manchino luoghi nei quali la fede non è ancora penetrata?
Non è dunque il caso, a mio avviso, di ricamare fantasie intorno a chi sa quali e quante comunità cristiane preistoriche o barbariche dell'Occidente.
Quello che si dice per Ireneo lo si può applicare, e con maggiori riserve al cartaginese Tertulliano, il quale alcuni anni dopo, con espressioni enfatiche (e l'enfasi è troppo spesso nemica della verità in quanto è esagerazione), scriveva che la fede era ai suoi giorni disseminata fra le diverse nazioni, e fra queste cita la Spagna, la Gran Brettagna, la Gallia, la Germania, la Dacia, la Scozia, la Sarmazia, ecc. (201).
L'altra testimonianza è quella di Sulpicio Severo, il quale lasciò scritto nella sua cronaca che sotto l'Imperatore Marco Aurelio si agitò la quinta persecuzione, e che allora per la prima volta si ebbero martiri nella Gallia, dove la religione cristiana era penetrata più tardi (serius) che non al di là delle Alpi (trans Alpes) (202).
Il trans Alpes in quale senso lo si deve prendere? L'Alessio vuole che si fatta dizione pone un paragone tra la Gallia e l'Italia tutta, ed è, secondo lui, falsificare il testo sulpiciano porre trans Alpes in relazione soltanto con Roma. Senonché l'espressione è così generica ed indeterminata che può benissimo valere per una parte e non per il tutto, tanto per la Gallia quanto per l'Italia.
Sappiamo infatti che nella Gallia il cristianesimo fece la sua prima apparizione nel lionese (203) e non in altri luoghi, diversamente ci sarebbero rimaste notizie di martiri o gruppi di cristiani in quest'altre località (204). E S. Gregorio di Tours, accordandosi con Sulpicio Severo, ammette che a Lione si formasse nella Gallia la prima comunità cristiana, e che il primo vescovo sia stato S. Potino venutovi con S. Ireneo ed altri discepoli di S. Policarpo al tempo di papa Aniceto (140-150).
Altrettanto si dica dell'Italia. È noto che il cristianesimo si diffuse dapprima in Roma e nei dintorni, nella bassa Italia, e più tardi nell'Italia Superiore.
L'Allard afferma che al finire del secondo secolo il cristianesimo si era già molto allargato in Italia perché contava fin d'allora sessanta vescovi (205) e cioè si richiama ai sessanta vescovi che vediamo intervenuti alla metà del secolo seguente al Concilio convocato in Roma da Papa Cornelio. Ma altri autorevoli scrittori osservano che quei vescovi, probabilmente tutti italiani, appartenevano quasi tutti alle regioni del mezzogiorno e delle isole, perché i vescovi dell'Italia settentrionale in quel tempo erano pochissimi (206).
Fino verso la fine del terzo secolo il nord d'Italia non ebbe, a quanto risulta, che tre soli vescovi residenti, e cioè Milano, Ravenna e Aquileia. L'Italia settentrionale, a differenza della centrale e meridionale, era povera di città o municipi: le popolazioni celtiche preferivano le campagne e i boschi.
Milano probabilmente fu la Chiesa più antica delle regioni IX, X, XI, e dell'Emilia, ma le sue origini cristiane sono ravvolte nell'oscurità (207). I tradizionalisti per asserire che fin dal tempo apostolico siasi fatto conoscere il cristianesimo, mettono innanzi, (pure abbandonando la leggenda della venuta di S. Barnaba, ormai rifiutata dai più autorevoli studiosi), S. Gervaso e Protaso, e S. Nazaro e Celso, i quali avrebbero sofferto il martirio a Milano durante l'impero di Nerone. Senonché le Passioni o leggende di questi santi martiri sarebbero atti di pia invenzione privi di fondamento storico (208).
Di S. Gervasio e Protaso nulla si conosce di certo, tranne che perirono in una persecuzione anteriore a quella di Diocleziano. " Quale però essa sia stata ci è impossibile a dire, anche approssimativamente, e sarà sempre finché non venga fuori qualche notizia più sicura sul tempo in cui si introdusse il cristianesimo a
Milano" (209). Il De-Rossi poi spiega la quasi dimenticanza in cui già al tempo di S. Ambrogio (386) erano caduti quei santi, ed il luogo dei loro sepolcri, col fatto della vendita dell'area cimiteriale cristiana sotto Diocleziano (304-305) (210).
Altrettanto dicasi riguardo al tempo nel quale subirono il loro martirio di S. Nazaro e Celso; forse avvenne in una delle ultime persecuzioni che precedettero quella di Massimiano, se forse non al tempo di questa medesima persecuzione. E similmente nulla di positivo si può ricavare dalle Passioni dei martiri Vittore, Naborre e Felice.
L'unico documento, si può dire, sul quale poterci appoggiare onde approssimativamente conoscere le origini della Chiesa milanese, è il catalogo degli antichi vescovi di Milano pervenuto fino a noi genuino ed integro, e derivato senza dubbio dai dittici che si adoperavano nella Chiesa primitiva (211).
Ora, partendo dall'anno 314 nel quale Mirocle sottoscrive al Concilio di Arles, non si hanno prima di quella data che sei vescovi compreso lo stesso Mirocle, e cioè Anatolio, Caio, Castriziano, Calimero, Mona, Mirocle.
Il Savio ritene di poter fissare una media normale di 20 anni per ciascun pontificato, e retrocedendo arrivò verso la fine del secondo secolo, nell'assegnare il tempo di Anatolio primo vescovo di Milano. Questa opinione non andò a genio al Merisi, il quale per sostenere l'origine apostolica della Chiesa milanese, pretese che sette e non sei fossero i vescovi, ponendovi arbitrariamente Materno prima di Mirocle, e vi assegnò una media di 36 anni per pontificato, media, a suo parere, non assurda anche per la ragione che la promozione all'episcopato si faceva di persone giovani (212).
Osserva il Lanzoni, contraddicendo a coloro che credettero di poter concedere agli antichissimi vescovi dell'Alta Italia una longevità straordinaria per l'ambizione di attaccarsi alle origini apostoliche, che " nulla ripugna che alcuni vescovi allora, come oggi, abbiano raggiunta una età invidiabile. Ma nella tesi che qui combattiamo, il caso certo ammissibilissimo, dovrebbe diventare la regola; vale a dire che nella tesi avversaria tutti i vescovi dell'Alta Italia nei primi tre secoli avrebbero goduto di una straordinaria e portentosa longevità... Si trovano, è vero, nelle liste vescovili dal III secolo fino a noi, secoli interi riempiuti da 5 od anche da 4 vescovi soltanto, cioè con una media da 20 a 25 anni; e nella lista di Bologna, ad esempio, sono riuscito a trovare in tre secoli consecutivi (900-1300) 15 vescovi, vale a dire una media di 20 anni. Ma nella storia ecclesiastica dell'Alta Italia dovremmo ammettere qualche cosa di ben più straordinario. E si noti che gli adotti esempi riguardano tempi di pace e di tranquillità nella Chiesa, e cioè i secoli VII e VIII, oppure età in cui venivano eletti prelati molto giovani come nel X e nell'XI secolo; ma la supposta media prodigiosa dei presuli dell'Alta Italia sarebbe caduta in tempi difficili, ed in cui i pastori erano scelti in età matura e spesso avanzata ". E conclude col dire che le più antiche Chiese dell'Alta Italia, cioè Milano e Ravenna, " non potrebbero al massimo toccare che la seconda metà del secolo secondo " (213).
* * *
A questo ordine di considerazioni (del Savio e del Lanzoni) si è ultimamente accostato Aristide Calderini, il quale propende, come migliore ipotesi, a fissare la data di Anatolio, primo vescovo di Milano, fra il 193 e il 243, cioè fra l'avvento di Settimio Severo e la morte di Gordiano III. " In realtà ", soggiunge, " la prima metà del secolo III corrisponde ad un periodo che giustificherebbe pienamente l'istituzione di un vescovado nell'Italia settentrionale a Milano, accanto forse a quello di Aquileia, che poteva essere stato contemporaneo; si accorderebbe anche con le prime epigrafi di cristiani or ora considerate, e anche col fatto che Anatolio, nome prettamente greco, come Ermagora, primo vescovo di Aquileia, lascia scorgere negli uomini se non nell'instituzione, un riflesso orientale sull'incremento della Chiesa nascente che bene si accorda con le età a cui ci riferiamo " (214).
Il Pellegrini ha invece ritenuto, volendosi concedere qualche anno di più alla media normale di episcopato stabilita dal Savio e dal Lanzoni, non inverosimile che a Milano il cristianesimo siasi fatto conoscere fin dalla prima metà del secondo secolo. Dai noti passi di S. Ambrogio e di Paolino nei quali si parla dell'invenzione dei corpi di S. Gervaso e Protaso, parrebbe a suo avviso doversi collocare quei martiri in un epoca molto lontana da S. Ambrogio, così che quei santi potrebbero essere stati martirizzati, se non al tempo di Nerone, per lo meno nella prima metà del secolo secondo, quando non era ancora costituita la sede vescovile, ma la fede poteva essere già penetrata (215).
Milano, benché assorgesse ad importanza solo nel IV secolo allorquando divenne sede imperiale, era tuttavia il centro preminente della valle Padana, dove convergevano, presso a poco come oggi, diverse strade da tutta Italia e vi dipartivano per il di là delle Alpi. Doveva essere quindi un punto di passaggio di soldati, di mercanti, di magistrati, ecc., e probabilmente albergare qualche colonia, sia pure piccola, di mercati orientali o di israeliti. Ora come la comunità cristiana di Lione nella persecuzione del 177 era costituita da elementi in prevalenza forestieri (216), e altrettanto avveniva nella stessa Roma nel I e II secolo, così non è un fuor di luogo il pensare che da questi elementi esotici siano forse penetrate anche in Milano le prime notizie intorno alla nuova religione, per quanto la vera evangelizzazione, pur lasciando da parte la leggenda che S. Barnaba vi abbia per il primo predicato la fede e che S. Pietro vi abbia mandato il primo vescovo, sia venuta probabilmente da Roma, centro d'irradiazione cristiana.
Comunque sia, dalle conclusioni dei più noti studiosi in materia, pare che l'origine della chiesa milanese debba porsi tra lo scorcio del secolo secondo e il primo decennio del terzo.
Quello che è certo si è che l'epigrafia non dimostra, sinora, la sicura presenza di cristiani a Milano se non verso la metà del secolo III.
Pertanto ci pare non azzardato il ritenere verosimile che il cristianesimo, in confronto di Roma e di altri centri minori della media e bassa Italia, sia penetrato più tardi nel centro e nell'ovest della Gallia transpadana, e che, dopo Milano siasi poi diffuso nelle altre città, mentre le nostre campagne, abitate da popolazioni di stirpe celtica, rimasero più a lungo, come nella Gallia transalpina, attaccate ai loro culti locali.
A queste condizioni generali non poté sfuggire la Brianza. Ed infatti non abbiamo alcun indizio per poter supporre in qualche modo penetrato il Vangelo nei primi tre secoli, mentre al contrario le molte lapidi e tombe pagane scoperte, e che di tanto in tanto vengono alla luce nel nostro territorio, ci dicono come ostinatamente durò a lungo il paganesimo. Del resto, come si è già osservato, al cadere del terzo secolo nelle stesse maggior città dell'Alta Italia, le comunità cristiane non erano ancora assurte ad una certa importanza, e ciò perché il cristianesimo aveva fatto relativamente magri progressi.
Né ciò deve fare meraviglia. Benché la Chiesa sia sempre stata attivamente impegnata a guadagnare nuove genti alla fede, non ha però avuto in tutti i tempi e in tutti i luoghi la stessa opportunità e possibilità di svolgere il suo apostolato, pure ammessa una particolare assistenza divina carismatica, specialmente agli inizi della Chiesa, onde la sua fondazione, in un mondo pagano ed ostile, apparisse opera non umana ma essenzialmente divina.
Le persecuzioni, le forze non sempre sufficienti all'impresa, la tenacia degli abitanti agli antichi culti, ed altre difficoltà, secondo i diversi tempi e luoghi, sono stati i principali ostacoli ad una più vasta e rapida opera di conversione.
Ciò nonostante non si può escludere qualche infiltrazione di cristianesimo nelle nostre campagne man mano che ci avviciniamo al declinare del terzo secolo, e che non ci sia stato qualche aderente alla nuova religione, se non fra la massa contadina, per lo meno fra coloro che per ragioni di commercio o di servizio militare, avevano rapporti con le città dell'impero romano. Ad ogni modo non si tratterebbe che di eccezioni e l'eccezione conferma la regola (217).
* * *
La penetrazione del Vangelo nelle campagne dell'Alto Milanese la si deve, molto probabilmente, collocare nel secolo IV; supposizione indiziaria che più si accosta al vero, per quanto con certezza non lo si saprà mai (218), ed è quella accennata dagli storici briantini della terza categoria.
Il secolo quarto è uno dei secoli più importanti nella storia del cristianesimo: esso si apre, si può dire, col così detto editto di tolleranza religiosa emanato da Costantino nel 313, e si chiude con Teodosio il Grande, sotto il quale la religione cristiana divenne l'ufficiale per tutto l'impero. Secolo poi di particolare lustro per la Chiesa milanese. t infatti al quarto secolo che si ascrive il costituirsi dei diritti metropolitici della sede milanese, in conseguenza dell'importanza civile di Milano sede degli imperatori, e raggiunsero il massimo splendore con S. Ambrogio. Con la traslazione della residenza imperiale, che avvenne verso il 404, allorché Onorio si stabilì a Ravenna, Milano incominciò la sua decadenza, e, mentre prese a diminuire la sua importanza politica, vennero man mano affievolendosi anche i diritti giurisdizionali ecclesiastici.
Tuttavia nei primi tre quarti di quel secolo, e cioè sino all'episcopato di S. Ambrogio, la nuova religione nelle nostre campagne non poté fare notevoli progressi (219).
* * *
Le prime leggi contro il culto pagano, promulgate nell'epoca costantiniana, furono pochissime o niente osservate. Lo stato, nonostante apparenze cristiane rimaneva profondamente e ostinatamente pagano, per cui le pratiche e lo spirito pagano si perpetuavano nelle consuetudini private e nelle istituzioni pubbliche.
Non può quindi recare sorpresa, ad esempio, il fatto che Costanzo, visitando Roma nel 357, abbia trovato non solo i templi pagani frequentati come prima, ma che a dispetto delle sue leggi continuasse a fumare sulle are il sangue delle vittime, e nondimeno lasciasse correre (220). Se questo avveniva in Roma ben possiamo immaginare cosa accadesse nelle campagne del'Alta Italia. L'Allard stesso osserva come nella prima metà del IV secolo il paganesimo era in Italia ancora fiorente (221). Si deve pertanto sempre distinguere tra la legge e la sua applicazione pratica, poiché la forza conservativa della tradizione oppone resistenza grandissima a tutte le leggi.
Con Giuliano l'Apostata quelle leggi perdettero quella qualunque forza che potevano avere, e il rifiorire del culto idolatrico non scomparve col cessare del suo corto impero, ma continuò sotto Valentiniano I, e solo con Graziano vennero provvedimenti energici. " Ciò che fu di impedimento, osserva il padre Grisar, al progresso più rapido del cristianesimo, non fu tanto la libertà che godette il moribondo culto degli dei, quanto piuttosto le riforme che uomini insigni presero a fare nella religione idolatrica. Molti furono ingannati da una certa rinnovazione spirituale degli antichi riti. L'avere introdotto nei miti la filosofia con geniale colorito, la diffusione di allettanti culti misteriosi orientali, pei quali si offriva buon posto alla sensualità ed ai vizi, furono cose tutte che tennero incatenati molti intelletti nelle braccia della superstizione " (222).
Ad un rapido e largo progresso del cristianesimo nelle campagne dell'Alta Italia si opponevano altre difficoltà. Di queste una mi pare di ravvisarla nella scarsità del clero, il quale era ancora insufficiente agli stessi bisogni delle comunità cristiane cittadine uscite scombussolate dall'ultima persecuzione, e in seguito dilaniate dalle eresie, specialmente dall'arianesimo, dividendo clero e fedeli in partiti intenti, più che altro, a battagliare fra di loro. L'arianesimo in quanto turbava la purezza della fede e dei costumi, era quasi la rivincita del paganesimo. La lotta perciò contro tale eresia diffusa nella città, più che contro l'idolatria stessa dominante nelle campagne, fu la preoccupazione massima dei vescovi cattolici di allora. Un'altra difficoltà sorgeva dalla stessa condotta morale non sempre edificante di non pochi cristiani (223), il che non era certamente una spinta ad una facile conversione dei rurali. La penetrazione evangelica trovava inoltre una resistenza, non facilmente superabile, nella tenacia delle masse campagnole alle loro idee, abitudini e superstizioni; incredulità e diffidenza per tutte le cose nuove che, non rare volte, constatiamo ancor oggi a tanti secoli di distanza e di progresso.
E poiché da una parte non erano più i tempi eroici della Chiesa in cui gli Apostoli operavano conversioni istantanee e numerose in virtù di straordinari carismi, e dall'altra non essendo cosa facile, e ben lo sanno i nostri missionari, per un popolo che ha raggiunto un certo grado di civiltà, il rinunciare alle credenze professate da tanti secoli, credenze che non sono soltanto un patrimonio di idee religiose, ma che entrano a far parte di tutta la vita, e si manifestano in tutte le forme del vivere individuale, familiare e sociale, ne avveniva che il culto pagano, nonostante gli editti imperiali in favore della nuova religione, continuasse a vigoreggiare, specialmente nelle campagne.
Con tutto ciò non voglio mettere in dubbio che dal 313 in poi il cristianesimo nell'Alta Italia venisse allargando relativamente le sue conquiste, ma non con quella rapidità e larghezza che il nostro desiderio amerebbe credere. L'erezione stessa delle diocesi è un fatto ancor raro nella prima metà di quel secolo, mentre si fa più frequente man mano che ci avviciniamo alla fine (224).
C'era nel complesso ancora molto da fare nelle città perché si potesse seriamente pensare ai rurali. Il paganesimo era venuto sensibilmente indebolendosi, ma esso non intendeva darsi vinto senza una lunga lotta: la disgregazione non era ancora la demolizione.
Forse in questo periodo di tempo, ossia nei primi tre quarti del IV secolo, il cristianesimo veniva penetrando qua e là fra i rurali più che per l'opera missionaria di qualche sacerdote, per mezzo di quei ferventi cristiani, i quali uscendo dalle città alle ville o ai latifondi loro, o recandosi per affari ai fori o pubblici mercati (225), avranno qua e là sparso qualche seme della nuova religione.
Comunque sia, l'azione metodica del clero si farà efficamemente sentire forse probabilmente con S. Ambrogio, e sicuramente dopo la sua morte. Il Cattaneo riterrebbe che " valutando esattamente la leggenda e le testimonianze epigrafiche cristiane è difficile staccarsi dalla persuasione che il cristianesimo sia stato diffuso con metodo nella campagna lombarda prima dell'episcopato di S. Ambrogio; così che solo negli ultimi anni del secolo IV possiamo pensare a gruppi di cristiani rurali e nel secolo V avere la certezza della diffusione ovunque della nuova religione " (226).
Pur non escludendo, in tanta oscurità, che qualche sacerdote o diacono possa talora essersi occupato della conversione dei rurali della campagna milanese, la congettura mi sembra poco convincente.
Di una evangelizzazione nella campagna lombarda metodicamente intrappresa prima di S. Ambrogio, non solo ci mancano elementi per poterla confermare, ma nemmeno seri indizi per supporla.
Dalle note leggende, frutti di molti secoli dopo, e che non danno alcun affidamento, nulla si può ricavare. Le testimonianze epigrafiche cristiane sembrerebbero anzi escluderlo, in quantoché una propaganda svolta con metodo, ossia ben organizzata da un clero missionario, se avvenuta, avrebbe recato il costituirsi per tempo qua e là per la campagna di comunità cristiane, sia pur piccole, le quali con tutta probabilità avrebbero lasciato qualche traccia, mentre invece tutto ciò che si conosce finora di cristiano, nella nostra campagna milanese, comasca e varesina, risale al V secolo inoltrato.
* * *
L'ultimo quarto di quel secolo corrisponde all'episcopato di S. Ambrogio, vescovo di Milano dal 374 al 397 e metropolita. Vescovo di mente vasta, di profonda pietà, di zelo instancabile, succedeva al vescovo ariano Ausenzio.
Nei primi anni si trovò impegnato nel combattere le eresie e in particolar modo l'arianesimo, nel formare e accrescere il clero, nel richiamare i fedeli alla purezza della fede e dei costumi, ecc., così che arriviamo verso l'ultimo decennio del suo episcopato per trovare un tempo veramente favorevole ad una metodica propaganda del Vangelo fra gli abitanti delle nostre campagne.
Ed invero, mentre Milano si può ritenere ormai cristiana nella sua maggioranza con un clero relativamente numeroso e ben preparato, come si può desumere dagli scritti di S. Ambrogio, dall'altra il potere statale non solo emana leggi contro il paganesimo, ma ne cura altresì la loro applicazione sia pure in modo piuttosto blando, poiché, nota l'Allard, non si trova un solo caso in cui sia stata inflitta la pena capitale ad un pagano sorpreso nell'esercizio della sua religione (227).
Che S. Ambrogio abbia combattuto il paganesimo è noto. Egli fu il confidente e l'inspiratore degli imperatori cristiani del suo tempo, per cui in certo qual modo le leggi emanate contro l'idolatria da Graziano e da Teodosio si devono, almeno in parte, attribuire al suo consiglio. Ma se osserviamo l'opera esplicata in merito da S. Ambrogio, vediamo che egli prese a combatterlo da un alto punto divista, e cioè coll'intento di distruggere l'alleanza tradizionale del culto pagano con lo Stato per sostituirvi la Chiesa. Reso cristiano lo Stato nelle sue leggi e nei suoi ordinamenti, più facile sarebbe stata la vittoria definitiva del cristianesimo.
Perciò Graziano nel 382 prese la decisione di separare completamente lo Stato dalla religione pagana. Fece rimuovere l'altare della dea Vittoria dalla Curia del Senato, confiscò alle vestali ed ai collegi sacerdotali le loro rendite, e tolse loro ogni sovvenzione e privilegio da parte dello Stato. Egli stesso aveva già respinto nel gennaio del 379 il titolo imperiale di Pontefice Massimo. In altre parole colpì alla radice il culto pagano, pur lasciandolo ancora sussistere ma a spesa dei privati.
I pagani avvertirono il grave colpo, e con alla testa Simmaco Prefetto di Roma, non ristettero, dal reclamare presso Graziano e successori la soppressione di quei provvedimenti, finché Teodosio nel 392 proibì definitivamente in tutto l'impero il culto pagano sia in pubblico che in privato con minaccia di grave ammenda (228).
La dea Vittoria personificava il paganesimo politico ed officiale. Per questo riusciva perniciosa al cristianesimo, donde la strenua lotta di S. Ambrogio contro Simmaco ed il suo partito perché più non si compissero atti di culto pagano in nome ed a spese dello Stato (229).
Simili controversie non erano però tali da influire in modo immediatamente pratico su le nostre popolazioni di stirpe celtica: ben altre credenze locali, più che non fosse il decadente paganesimo officiale ridotto ad un impasto di riti orientali e di filosofia neoplatonica, tenevano avvinti gli abitanti della campagna al tempo di S. Ambrogio (230).
Di una predicazione fra i rurali dell'agro milanese per mezzo di sacerdoti non si fa esplicitamente parola negli scritti di S. Ambrogio e di Paolino, suo segretario e biografo, e nemmeno in altre fonti. Strano e significativo silenzio quando si pensa alla molteplice opera di bene spiegata dal grande vescovo in favore della sua e di altre Chiese.
È noto che nelle città dell'Italia Superiore, al tempo di S. Ambrogio, il cristianesimo andava allargando le sue conquiste, benché non egualmente in tutte, poiché a Como, per esempio, città a noi vicina, nell'ultimo quarto di quel secolo la nuova religione richiedeva ancora un'intensa propaganda come si rileva da due lettere di S. Ambrogio al vescovo Felice (231), ma nella campagna non avveniva ancora con altrettanta facilità.
La diocesi di Trento era tuttora pressoché pagana quando S. Vigilio nel 385 ne assunse il governo (232). Verso il 397 il cristianesimo era ancora ignoto in Val di Non, presso Trento, e gli abitanti erano tanto attaccati ai loro culti che il 29 maggio di quell'anno uccisero i tre missionari stranieri venuti dalla Grecia, Sisinio diacono, Martirio lettore, e Alessandro ostiario, e incendiarono la chiesa di recente edificata.
Di S. Vigilio vescovo di Trento (385-405?) che ci lasciò il racconto del martirio di detti santi (233), si dice che anch'egli fu ucciso per la fede, ed a lui si attribuisce la conversione stessa di Trento a Cristo, e un'attiva opera di evangelizzazione in plaghe non solo della sua diocesi, ma ben anco del Veronese e del Bresciano, fondandovi una trentina di chiese (234).
S. Massimo, vescovo di Torino dallo scorcio del IV secolo a circa il 420, trova necessario in alcune omelie di premunire i suoi dal contatto pericoloso dei pagani e dall'uso fra i neo-convertiti di mantenere ancora e di lasciare venerare nelle campagne e nei boschi i piccoli tempietti e le statue degli dei: " cum vos Deo adoretis in Ecclesia, vestri diabolum venerentur in fanis " (235). Nella campagna bresciana si verificava lo stesso fatto, per cui S. Gaudenzio, morto verso il 410, ne rimproverava i cristiani: " An existimatis quod Deum diligat tepidus ac negligens Christianus, qui idola in possessionibus suis coli permittit, qui fanum daemoniis et aram diaboli stare in contumeliam Dei patitur? " (236).
Altrettanto avveniva nel veronese, e S. Zeno, vescovo di Verona si lamentava coi suoi fedeli: " Hic quaerite, Christiani, sacrificium vestrum an esse possit acceptum, qui vicinarum possessionum omnes glebulas, lapillos, et sorculos nostis, in praedictis autem vestris fumantia undique sola fana non nostis quae (si vera dicenda sunt) dissimulando subtiliter custoditis " (237).
Purtroppo in questo tempo la Chiesa contava dei cristiani infiacchiti nella pace perché non pochi nelle città erano passati un po' rapidamente al cristianesimo guidati non da profoda convinzione, ma da calcoli di convenienza.
Vi era cioè un numero di mezzi convertiti, i quali non avevano che una tinta di cristianesimo, ed erano rimasti nel mondo pagani e ben poco avevano assimilato della morale evangelica. Perciò se quanto deploravano i vescovi di allora avveniva nelle proprietà di coloro che avevano abbracciato la nuova fede, ben di peggio accadeva nei possessi di coloro che duravano ostinatamente attaccati alla vecchia religione.
Nel novarese sappiamo che parimenti forte e vigoroso si manteneva il paganesimo. Si dice che i due fratelli Giulio e Giuliano, di nazione greci, l'uno prete e l'altro diacono, avrebbero ottenuto da Teodosio (morto il 7 gennaio nel 395) la missione di " divellere profana simulachra, luccos succidere, aras et delubra igni concremare, sacras domos erigere et altaria dedicare, populos tingere unda baptismatis ". I due fratelli avrebbero quindi erette nientemeno che cento chiese, delle quali l'ultima nell'isola del lago d'Orta (238). Con questi due missionari vi lavorò altresì S. Gaudenzio, primo vescovo di Novara (397-418), a convertire i pagani e ad aumentare il suo clero.
Nulla di straordinario quindi se la vecchia religione, data la sua ostinata resistenza nelle campagne, era divenuta la "religio pagorum", e chiamati " pagani " i suoi cultori (239). Pertanto se da una parte Sulpicio Severo, il quale scriveva nei primi del V secolo, poteva con verità asserire che al suo tempo, in confronto del passato, " mirum est quantum invaluerit religio christiana ", (240) dall'altra e non a torto per quanto con alquanta esagerazione, si poteva dire che Cristo era solamente venerato nelle grandi città: " Signum quod perhibent esse Crucis Dei Magni qui colitur solus in urbibus Christus " (241).
Si può quindi affermare col Savio che sul finire del IV secolo, nelle campagne della Liguria (presa in senso antico), e più ancora nelle colline e nei monti, a dispetto delle leggi imperiali, le statue degli dei rimanevano al loro posto, e davanti ad esse i contadini ed i montanari continuavano ad immolare vittime ed a scrutare il futuro nelle loro viscere, o in altre parole che l'idolatria rimaneva il culto della maggioranza dei rurali.
Resti notevoli di paganesimo come vorrebbero taluni? Potrebbe darsi, se li consideriamo in rapporto alla complessiva diffusione del cristianesimo ormai raggiunta nel mondo romano e specialmente nelle nostre città, ma è da escludere se invece il raffronto lo si pone fra gli aderenti dei due culti nelle nostre campagne. Anche l'Allard ritiene che la fede nelle campagne della maggior parte dell'Occidente si propagò più tardi che non in quelle d'Oriente, dell'Africa, della media e bassa Italia. Egli scrive che ai tempi di S. Martino (contemporaneo di S. Ambrogio) l'idolatria dominava ancora in pieno nelle campagne del centro, del nord e dell'ovest della Gallia, e che a questa situazione partecipava il nord d'Italia tra le Alpi e il
Po (242).
Orbene, dato che nessuna memoria sicura si ha di una predicazione nell'agro milanese al tempo di S. Ambrogio, si può inferirne che gli abitanti, facendo eccezione, fossero già in gran parte cristiani? Ritengo che non si possa ammetterlo.
Infatti di questo secolo, mentre nell'agro si sono trovate non poche iscrizioni ed oggetti tombali di carattere pagano, a tutt'oggi nulla si è rinvenuto di sicuramente cristiano, né epigrafi, né resti di sacri edifici, né oggetti sepolcrali (243). La più antica iscrizione cristiana nella campagna milanese, comasca e varesina, come si è detto, è del 425, scoperta in Valsassina ed è finora l'unica che si conosca della prima metà del V secolo, mentre diventano relativamente numerose nella seconda metà, e nella prima del VI secolo (244).
* * *
Secondo l'Alessio la mancanza di epigrafi cristiane nei primi secoli della Chiesa non deve sorprendere. Egli, parlando del Piemonte, fa delle osservazioni che, se dal suo punto di vista fossero esatte, potrebbero valere anche per la nostra regione.
Scrive che i cristiani dei primi tre secoli del cristianesimo, secoli di persecuzioni, ad eccezione di Roma dove avevano le catacombe, non potevano con pubbliche lapidi dare a conoscere che uno della famiglia era stato cristiano senza esporre gli altri a sicuro martirio; oppure perché non sempre tutti i membri di una famiglia si convertivano al cristianesimo, e quelli che sopravvivevano pagani, giudicando stoltezza la fede cristiana, non potevano con pubblico elogio farne merito al parente od amico defunto.
D'altra parte i cristiani, umili per istinto di vita e per massime di religione, solo aspiravano ad avere scritti i loro nomi in libro vitae, e neanche è da credere che subito dopo il famoso decreto costantiniano del 313 le cose siano mutate in modo da far cambiare d'un tratto i costumi dei cristiani (245).
Senonché, pure ammesso che nei primi tre secoli, secoli di persecuzioni, si potessero incontrare difficoltà nel collocare lapidi ad un cristiano defunto, come spiegare seriamente la mancanza di qualsiasi epigrafe per tutto il IV secolo, secolo della libertà cristiana, mentre si trovano in tanto in tanto nelle nostre campagne iscrizioni e tombe pagane? Se l'introduzione del cristianesimo fra i nostri rurali fosse avvenuta fin dai primi tempi, nel quarto secolo doveva probabilmente aver raggiunta una diffusione tale che, come già si è osservato, qualche oggetto cristiano, almeno negli ultimi anni di quel secolo, non sarebbe potuto mancare, come avvenne nelle regioni dell'Oriente e in quelle località dell'Occidente dove la fede si propagò di buon'ora.
Soggiunge l'Alessio che si deve inoltre tener calcolo dei mille accidenti (guerre, terremoti, assedi, incendi, saccheggi, ecc.), i quali attraverso i secoli possono aver concorso alla dispersione o distruzione delle lapidi cristiane. Ma anche questa ragione non persuade, sia perché non tutte le regioni o località ebbero a soffrire di tali disastri, oppure non furono colpite nello stesso modo; e sia perché i sopra ricordati accidenti avrebbero dovuto far scomparire non solo le lapidi cristiane ma anche quelle pagane.
* * *
Un'ultima osservazione fa poi l'Alessio col dire che fra tante lapidi frammentarie, oppure fra quelle senza data, non è impossibile che ve ne siano di molto antiche anteriori al V secolo. Possibilità questa ben difficile a dimostrarsi, perché se non si può fissare l'anno preciso, nondimeno dallo studio dei " simboli che portano incisi, dai nomi gentilizi, dai monogrammi, dai vocaboli e dalle forme grafiche delle lettere " si può conoscere " a quale età, almeno in via approssimativa, possano appartenere " (246).
Ora, nessuna lapide cristiana frammentaria o senza data, fra le scoperte dell'agro milanese e comasco, si è potuto finora assegnarla a secoli anteriori al quinto.
Certamente che l'epigrafia è un indizio il quale, al pari degli altri, va preso con discrezione, ma che tuttavia sotto un certo aspetto, ha la sua importanza, perché ci fa conoscere sia pure con larga approssimazione, il propagarsi del cristianesimo nelle campagne. Infatti, se il trovare epigrafi cristiane solamente col V secolo non ci permette di asserire che la fede cristiana abbia soltanto allora incominciato a propagarsi fra i nostri rurali, rimane pure evidente che la loro tarda presenza ci dice come non si possa spostare ai primi secoli la conversione dei nostri contadini gallo-celti, e che anche nel secolo IV, per lo meno fin all'episcopato di S. Ambrogio, doveva contare ben pochi aderenti.
D'altra parte, per non dire che della Brianza della quale ci occupiamo, non mancano validi indizi del perseverare vigoroso del paganesimo sulle nostre terre ancora sul declinare del quarto secolo.
S. Agostino, ritiratosi nel 386 per alcuni mesi a " Cassiciaco " nella villa campestre del grammatico milanese Verecondo, onde prepararsi al Battesimo, non accenna all'esistenza di cristiani in quel luogo o nei dintorni, e si che si trovava in una condizione d'animo di doverne fare parola qualora ce ne fossero stati (247).
I rustici di Cassiciaco, luogo che probabilmente corrisponde all'odierno Cassago, dovevano essere ancora pagani come lo era il loro padrone Verecondo. E questo potrebbe trovare conferma nella necropoli pagana del non lontano Calpuno (Lurago d'Erba) (248), e nel culto pagano praticato nella vicina Barzanò (249).
Un tipico esempio del perdurare del paganesimo lo vediamo nel culto orientale di Mitra e del dio Sole praticato ad Angera, dove si ancorava il naviglio imperiale romano che esercitava la polizia del lago e difendeva le vie dirette alle Alpi.
Comunque sia delle origini del culto di Mitra ad Angera, è certo che tale culto vi fu molto in auge nel quarto secolo, particolarmente sotto Giuliano l'Apostata, e che vi durò per tutto il primo quarto del secolo quinto. Con la sua scomparsa, dovuta probabilmente alla legge di Valentiniano III del 425 (cod. Theod., XV, 5, 63), abbiamo ad Angera le prime sicure memorie cristiane: una lapide del 492, e due altre senza data, delle quali una è verosimilmente del quinto e l'altra del sesto secolo. Tuttavia il cristianesimo, coll'avvicendarsi di militari, funzionari, ecc., provenienti dalle diverse parti dell'impero, non doveva essere probabilmente sconosciuto nel quarto secolo in quel luogo importante unito a Milano con strada militare, come lascerebbero supporre due lucernette cristiane di quel secolo ivi scoperte (250).
Che le popolazioni agricole del Comasco e della Brianza rimanessero fortemente attaccate al gentilesimo, lo si può altresì argomentare da certe costumanze pagane durate a lungo; costumanze che non si possono spiegare se non nella ripugnanza ad abbracciare la nuova religione (251).
Non intendo dare a questi fatti un valore tale quasi a negare che il Vangelo al tramontare del secolo quarto venisse allargando le sue conquiste anche fra i rurali, ma mi sembra esagerazione, ripeto, il pensare che al tempo di S. Ambrogio gli abitanti dell'agro fossero già in maggioranza cristiani, mentre in Milano stessa alla morte di S. Ambrogio esisteva ancora un buon numero di pagani (252).
E quanto avveniva nelle allora selvose colline briantee, altrettanto presso a poco accadeva nel basso milanese.
Presso Abbiategrasso, per citare un esempio, venne ultimamente alla luce una necropoli di tipo gallo-romano con circa 200 tombe tutte pagane. I sepolti lo furono col rito della cremazione e appartenevano a poveri discendenti di tribù galliche. Le tombe risalgono al V secolo, ma non se ne è trovata una cristiana, benché vi si rinvenissero monete di Teodosio imperatore, amico di S. Ambrogio. In queste località agresti tra le boscaglie del Ticino, lontane dai centri cittadini, e dalle grandi strade romane, il paganesimo resistette a lungo, e ci volle non poca fatica prima che il Vangelo prendesse il sopravvento (253).
Nondimeno, il vedere i nostri vescovi sul finire del IV secolo e nel seguente, sorretti in pieno dal potere civile, fortemente impegnati a combattere la resistente idolatria nei loro territori, mi fa pensare che anche il nostro grande S. Ambrogio, benché non risulti in modo esplicito, abbia fatto altrettanto nella sua diocesi (254), sull'esempio altresì dell'amico suo Martino, vescovo di Tours, che tanto si adoperò per la conversione dei rurali nella Gallia.
* * *
Il Dozio afferma che S. Vigilio, vescovo di Trento, non solo avrebbe faticato alla conversione dei pagani nel territorio della sua Diocesi e in quelli vicini di Verona e Brescia, ma che secondo vecchie tradizioni popolari si sarebbe spinto persino in alcune valli del bergamasco e nel lecchese, e, passata l'Adda, giungesse nunzio della nuova fede nelle nostre terre briantine (Garlate, Calco) (255).
Di più, sempre in base ad antiche tradizioni, avrebbe lavorato a convertire i pagani nel milanese anche S. Giulio prete. Sia l'uno che l'altro vi avrebbero edificate poi più chiese (256).
Che dire di queste vecchie tradizioni! Per sé non sono inverosimili, considerate nel quadro generale dell'evangelizzazione di quel tempo nella Gallia Cisalpina. Ma il Dozio non ci dà la fonte donde le ebbe a ricavare, né d'altra parte ne ho trovato cenno nei vecchi storici briantini. Sembra pertanto che siano sue personali congetture, in quanto cerca di dar loro un fondamento basandosi sul fatto delle chiese in loro onore costruite.
Nondimeno dalle chiese a loro dedicate nel milanese non si può seriamente arguire che vi abbiano propagato il Vangelo, poiché, trovando pure tra le antiche nostre chiese quelle, per esempio, dedicate ai santi Apostoli, si dovrebbe allora inferire, per la stessa ragione, che gli Apostoli vi avrebbero predicata la fede.
Come che sia, dagli ultimi anni del quarto secolo il Vangelo viene con zelo predicato nelle campagne dell'Alta Italia, né potevano essere escluse le nostre e perciò la Brianza.
S. Ambrogio chiude, si può dire, il secolo quarto lasciando alla sua morte la Chiesa in una situazione favorevolissima di sviluppo. Tra paganesimo e cristianesimo di fronte allo Stato la situazione si era ormai radicalmente invertita: proibito in pubblico e in privato il primo, favorito e privilegiato il secondo (257). Perciò il Padre Savio ritenne, e non a torto secondo il Lanzoni, che sotto S. Ambrogio o per lo meno sotto l'Imperatore Onorio (258), e prima dell'invasione di Alarico (401), l'autorità ecclesiastica, d'accordo con quella civile, prendesse un generale provvedimento di stabilire un vescovo nei principali luoghi (259).
Si tenga inoltre presente che l'ultimo quarto di quel secolo e la prima metà del seguente è il periodo dei grandi dottori e padri della Chiesa.
Con tale favorevole situazione di fatto e di diritto, continuata quasi sempre in meglio dai successori di Teodosio, quanto rimaneva di paganesimo nelle città, per convenienza o per convinzione, svanì ben presto, e i pochi che continuarono ostinati nelle vecchie credenze non ebbero più influenza nella società (260).
* * *
L'idolatria, rifugiatasi nei recessi delle campagne e dei monti, veniva serrata e battuta da vicino. Anche l'Oltrocchi parlando dell'episcopato di S. Venerio, vescovo di Milano dal 401 al 405 circa e successore di S. Simpliciano, scrive che una delle maggiori sollecitudini dei vescovi di quel tempo era appunto quella di estirpare l'idolatria, la quale, nonostante gli editti imperiali, vigoreggiava nei pagi e nei monti (261). E l'esperienza ci dimostra ancor oggi, nelle missioni dei popoli infedeli, che approfittando dell'opportunità e dei mezzi che offre la Provvidenza, si può ottenere relativamente in breve tempo quello che non si è potuto in un lungo periodo precedente in condizioni meno favorevoli.
A rendere maggiormente efficaci gli sforzi dei vescovi e del loro clero interverrà pure un mezzo violento: le invasioni dei barbari. L'uomo sotto l'incubo delle calamità si rivolge più facilmente a Dio e ne ascolta i suoi ministri. E non molto dopo la memoranda invasione di Attila il " flagellum Dei " (452), che tanta impressione lasciò nei contemporanei, si fanno infatti man mano più frequenti le epigrafi cristiane; sicuro indizio dell'ormai larga diffusione del cristianesimo nelle nostre terre.
Non si creda tuttavia che l'idolatria nelle campagne, e specialmente nei luoghi di difficile accesso, dove si poteva facilmente sfuggire alla vigilanza dei missionari e delle leggi civili, sia stata sradicata per intero e dappertutto in breve tempo. Della sua persistenza vi è cenno nell'editto di Teodorico del 524 (262); e S. Benedetto nel 528 prima di fondare il monastero di Montecassino dovette prima di tutto purgare il luogo del culto di Apollo, e consacrare l'opera sua e quella dei suoi discepoli alla conversione dei pagani, ancora numerosi, nelle campagne sottostanti. Più tardi S. Gregorio Magno emanò parecchi ordini ai vescovi d'Italia perché togliessero usi e superstizioni e procedessero alla conversione dei pagani Longobardi e Romani, ossia tanto degli invasori quanto degli indigeni, lamentando poi che, per la convivenza interessata di governatori greci, in Sardegna e in Corsica, vi fossero ancora numerose le comunità pagane, e vi mandava perciò dei missionari (263).
Se nonostante le circostanze favorevoli alla propagazione del cristianesimo dopo S. Ambrogio e Teodosio, si hanno ancora in Italia dei pagani indigeni, non è difficile ammettere come lenta sia stata nelle campagne celtiche dell'Alta Italia la sua diffusione nei tempi anteriori che presentavano maggiori ostacoli.
Ad ogni modo una sol cosa è certa, ed è che le prime memorie positivamente sicure del cristianesimo nella Brianza datano dalla seconda metà del quinto secolo. Di questo tempo sono le più antiche iscrizioni funerarie che si conoscano, e rinvenute, poiché allora era in uso nelle campagne il farsi seppellire presso le chiese (264), là dove si erano erette le antiche chiese plebane battesimali (Galliano, Garlate, Incino, ecc.).
Di preti vi è memoria nella prima metà del sesto secolo a Galliano, Lecco, Agliate, e forse fin dall'ultimo quarto del secolo V a Galliano ed a Garlate. A Galliano vi è pure ricordato un diacono Savino, la cui iscrizione può essere del 485 o del 522 (265). Col prete ci sarà stato in quelle località un edificio sacro per celebrare i sacri riti.
* * *
Concludendo questa prima parte del nostro breve studio, mi pare di poter approssimativamente asserire:
1°. Che nei primi tre secoli il cristianesimo si è sviluppato quasi esclusivamente nelle città. Non abbiamo prove e nemmeno seri indizi per accertare che sia penetrato nelle campagne dell'alto milanese, e quindi anche nella Brianza, benché non si possa escludere che, man mano ci avviciniamo al IV secolo, non potessero esservi degli aderenti alla nuova religione.
2°. Che nei primi tre quarti del IV secolo, nonostante l'editto di tolleranza di Costantino, non poté fare notevoli progressi, perdurando nel loro complesso le precedenti difficoltà ambientali.
3°. Che un'evangelizzazione missionaria verrà forse probabilmente intrappresa con S. Ambrogio, e sicuramente dopo la sua morte con S. Simpliciano e successori in correlazione con quanto facevano i vescovi nelle loro circostanti diocesi, così che negli ultimi anni del quarto secolo si può ragionevolmente supporre il formarsi qua e là nelle campagne di gruppi o comunità cristiane, se già nel 425 troviamo il cristianesimo arrivato in Valsassina (266).
4°. Che verso la fine del V secolo le nostre campagne si possono ritenere cristiane nella loro quasi totalità, argomentando dal numero delle epigrafi cristiane che si fanno sempre più numerose, ed in riferimento alla generale diffusione del cristianesimo in tutte le campagne del nord d'Italia.
Naturalmente la nuova religione si sarà diffusa, dove prima e dove dopo, a seconda delle circostanze locali e della disposizione più o meno pronta degli abitanti a ricevere il Vangelo, precisamente come avviene ancora oggi nelle terre di missione, poiché questo è nella natura delle cose.
II
LE ANTICHE PIEVI BRIANTINE
Se è quanto mai oscuro il conoscere quando e come penetrò e si diffuse il Vangelo nelle nostre campagne, altrettanto lo è riguardo al quando e come si formarono e si organizzarono le nostre pievi rurali.
Si è soliti richiamarsi a quanto avveniva nelle Gallie, nella Spagna, e in altre regioni, ma, a mio avviso, sono riferimenti da usarsi con grande cautela, in quanto che le pievi rurali non originarono né si organizzarono dappertutto nello stesso tempo e nello stesso modo, date le diverse condizioni ambientali dei popoli.
Ad ogni modo, lo studio delle origini e dell'organizzazione delle prime nostre pievi (267), si riconnette a quello della diffusione del cristianesimo ed all'evolversi dell'organizzazione ecclesiastica.
Era norma nei primi tre secoli cristiani che, quando la nuova fede penetrava in un luogo, sia città o villaggio, e vi si costituiva una comunità formata sia pure di soli dodici cristiani maggiorenni maschi, vi si ponesse a capo un vescovo.
Ed è quanto si è verificato nelle provincie dell'Oriente e dell'Africa mediterranea, nella media e bassa Italia, ed in qualche località della Gallia meridionale.
Nelle campagne dell'Italia settentrionale non si ha memoria né di corepiscopi né di vescovi di villaggio, sia perché il cristianesimo vi si diffuse meno rapidamente che non nelle sopra citate regioni, e sia perché coll'aprirsi del quarto secolo si iniziò un movimento il quale tese non solo a restringere il potere dei vescovi di campagna, ma ad eliminarli; movimento sorto in correlazione al rafforzarsi dell'organizzazione metropolitana, e culminata nelle decisioni del Sinodo di Sardica tenuto verso la metà di quel secolo (343-344). Col cànone 6° infatti si prescrisse, nell'interesse della stessa dignità episcopale, che in un villaggio o in una piccola città in cui fosse sufficiente un sol prete, fosse proibito mettere un vescovo; cànone ribadito con maggior vigore nel Concilio Ecumenico di Costantinopoli del 381 (268).
Le decisioni del Sinodo di Sardica, alle quali presero parte Vescovi occidentali tra i quali il nostro di Milano, ebbero valore anche per l'Occidente, ed influirono a restringere la creazione di nuove sedi vescovili senza vera necessità. Nell'Italia nordica trovarono un facile campo di applicazione, poiché fin verso la metà del terzo secolo, per la scarsa diffusione del cristianesimo, in essa non risultano residenti che soli tre vescovi, e cioè quelli di Milano, di Ravenna e di Aquileia. Ne avvenne che furono relativamente poche le diocesi della Gallia Cisalpina, dove del resto erano rare le città e i municipi romani, e organizzate appunto lungo il quarto secolo, e specialmente nella seconda metà, dalla chiesa metropolitica di Milano (269).
La susseguente organizzazione cristiana delle nostre campagne si svolse perciò non già come nei secoli precedenti, mediante il moltiplicarsi delle sedi vescovili, ma bensì con la subordinazione ai vescovi diocesani delle comunità cristiane che venivano man mano costituendosi nei rispettivi loro vasti territori.
La parrocchia rurale si formò di conseguenza dopo le diocesi e nell'ambito delle medesime, per la necessaria assistenza religiosa ai rurali.
Non merita fede quanto volle sostenere il Negri, e cioè che i primi parroci di campagna furono corepiscopi o vescovi rurali, basandosi sul leggendario presupposto che le nostre pievi siano state fondate dal vescovo di Milano S. Mona (270).
Le nostre pievi non furono istituite né da S. Mona e nemmeno da S. Dionigi (271), ma si formarono molto più tardi in un tempo nel quale il corepiscopato era ormai scomparso anche dall'Oriente.
Le prime nostre pievi battesimali di campagna ebbero a capo non un vescovo, ma un semplice prete con attribuzioni speciali.
Un potere, ad esempio, che forse rimonta ai primi secoli del medioevo e durato fin verso la metà del secolo XII, era quello che l'arciprete o il prevosto potesse dare gli ordini minori ai chierici della sua plebana; potere che fu abolito nella nostra diocesi da Guido da Somma, arcivescovo di Ostia e legato pontificio, tranne che per l'arciprete di Monza il quale continuò ad usarne ancora per molti secoli (272).
Altrettanto si dica di Pontirolo vecchio la cui chiesa dedicata a S. Giovanni Evangelista fu un'insigne collegiata di rito romano che si pretendeva fondata, come quella di S. Giovanni Battista in Monza, dalla Regina Teodolinda. Il rito romano di questa collegiata si richiama probabilmente allo Scisma dei Tre Capitoli. Orbene, nessun documento o serio indizio ci dimostra che il capo di quella pieve fosse, in origine, corepiscopo o coepiscopo, e nemmeno esercitasse vera giurisdizione episcopale.
In realtà non si tratta che di un capo pieve come tutti gli altri, ma che seppe, nonostante tutto, attraverso i tempi conservare parte delle antiche prerogative arcipretali, e aggiungerne abusivamente delle altre. Teneva il suo Vicario Generale, usava bastone pastorale e mitra nei pontificali, promuoveva ai quattro ordini minori i chierici della sua chiesa, assegnava i benefizi vacanti della sua vasta pieve, rilasciava dimissorie ai chierici, e, con la pretesa che la sua pieve fosse nullius diocesis, ossia esente, usurpava anche diritti arcivescovili in cause civili e criminali.
Non poche riprensioni, in vari tempi, furono fatte ai prevosti e ai loro vicari, finché S. Carlo Borromeo, con l'assenso del Pontefice, nel 1577 soppresse senz'altro quella collegiata (273).
I prevosti di Pontirolo pretendevano in certo qual modo di gareggiare con gli arcipreti di Monza. Senonché la Chiesa Monzese, data l'importanza del luogo e la protezione della Santa Sede e degli imperatori franchi e tedeschi, poté mantenere a lungo i suoi antichi privilegi (274).
Ma né la chiesa plebana di Pontirolo né quella di Monza possono vantare alle loro origini un corepiscopo.
* * *
Non è pertanto inverosimile, giova ripeterlo, che una proficua propaganda della nuova fede nell'agro milanese per mezzo del clero siasi probabilmente iniziata con S. Ambrogio, o comunque sul finire del IV secolo, - benché il cristianesimo, per cause diverse e fra queste le disposizioni più o meno facili degli abitanti a ricevere la nuova religione, non si diffondesse egualmente dappertutto -; e che i primi luoghi ad essere evangelizzati saranno stati, logicamente parlando, quelli più importanti o relativamente vicini a Milano o comunque in facile comunicazione con la città, per poi procedere in località più discoste e di difficile accesso o di minore importanza (275). Ne viene di conseguenza come probabile che le prime parrocchie rurali o battesimali devono essersi abbozzate, man mano a seconda dell'opportunità e del bisogno, lungo il secolo V. Negli scritti di S. Ambrogio non vi è cenno dell'esistenza di pievi rurali.
Ci sembra infatti che una primitiva qualsiasi organizzazione parrocchiale presupponga una certa qual diffusione del cristianesimo fra le disperse popolazioni della campagna, per cui si richieda in luogo l'opera di sacerdoti funzionanti in nome del vescovo, non essendo ormai più possibile lo scendere dei fedeli dalla campagna alla chiesa matrice vescovile, dato il crescente numero dei convertiti al cristianesimo.
Ed è appunto sotto Valentiniano III, imperatore dal 425 al 455, che il Vangelo, al dire del Gabotto, penetra largamente tra il nostri rurali. E soggiunge che tradizioni ecclesiastiche più o meno attendibili, ma ad ogni modo significative, farebbero rimontare a questo tempo atterramenti o adattamenti di templi pagani ai bisogni del nuovo culto, oppure costruzioni di nuove chiese, dedicandole ai santi Apostoli, a S. Stefano, a S. Vittore, a S. Vincenzo ecc. (276).
Dico abbozzate perché verranno via via perfezionandosi in base allo scopo per cui furono erette.
La necessità stessa della stabile assistenza religiosa alle disperse popolazioni della campagna portava ad un estendersi graduale delle attribuzioni (battezzare, benedire, funerare, predicare, insegnare, educare i chierici, ecc.), e perciò a distinguersi dalla parrocchia diocesana, col tendere a segnare un proprio distretto con un proprio patrimonio ed un proprio clero.
È per effetto dell'estensione di questi poteri che la parrocchia rurale o pieve diverrà a poco a poco un organismo autonomo, completo, definitivo con a capo un arciprete, e con un clero proprio che simile a quella della cattedrale, costituirà l'ordo plebis in forza del titolo di incardinamento e ordinazione; ossia un clero ordinato e incardinato stabilmente presso la chiesa matrice battesimale. Un organismo però sempre alle dipendenze del proprio vescovo (277).
|
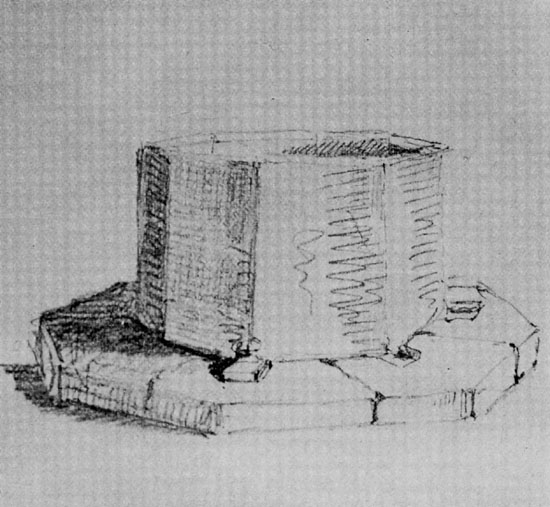
|
|
|
Fonte battesimale di San Salvatore di Barzanò; schizzo di A. Garovaglio.
(Fondo Garovaglio, Biblioteca Comunale di Como).
|
|
|
|
|
Seguire passo passo l'evolversi della parrocchia rurale milanese (e briantina) dalle origini alla sua completa organizzazione non è possibile.
Del periodo pre-carolingio mancano documenti diretti. Successivamente si incomincia ad avere, da una o da altra pieve, qualche accenno che lascia intravedere qualcosa sulla sua costituzione e funzionamento; cenni e documenti che si fanno relativamente più frequenti dopo il Mille.
Qualcuno ha invece opinato che nelle diocesi le pievi primitive siano state canonicamente erette di punto in bianco nello stesso tempo; introdotte cioè secondo un piano meditato e uniforme, creando ex-novo, con decreto, l'organismo parrocchiale plebano (278).
Congettura che non persuade, per lo meno riguardo alle nostre pievi milanesi, perché non solo ci manca il documento o l'atto che dia il tempo e l'essenza della loro costituzione giuridica, ma altresì una fonte che accenni all'emanazione od all'esistenza di un simile decreto.
È perciò piu verosimile che siansi formate non ex-novo contemporaneamente, ma man mano in quei centri dove erano solite adunarsi le comunità già in gran parte cristiane di un dato distretto o pago assistite da qualche sacerdote o diacono, e che le condizioni locali indicavano la necessità in luogo di una chiesa battesimale, non essendo più possibile il scendere tutti in città al battistero diocesano e alla cattedrale, press'a poco come avviene ancora oggi nelle terre di missione.
Il Dozio, in parecchi suoi scritti, insinuò che le pievi briantine si iniziarono verso la fine del IV secolo o nei primi anni del seguente; opinione ammessa da altri studiosi. Riteniamo possa corrispondere al vero l'iniziarsi, lo svilupparsi e l'organizzarsi della pieve lungo il secolo V.
Lo Schiaffini invece, mentre ritiene che il cristianesimo nell'Italia transpadana (esclusa la parte orientale) siasi diffuso più tardi che non nella media e bassa Italia, tanto che negli stessi grandi centri le comunità dei convertiti intorno al IV secolo erano di scarsa importanza, pone l'erezione delle pievi nel III e IV secolo (279). È un'ipotesi molto discutibile.
Infatti, per non dir altro, se nei primordi del quarto secolo nelle stesse città nostre le comunità cristiane contavano ancora poco, com'è possibile congetturare pievi rurali sin dal terzo secolo nelle nostre campagne?
La costituzione imperiale del 27 luglio 398, emanata in Milano dall'imperatore Onorio, stabiliva che " pro magnitudine vel celebritate uniuscuiusque vici ecclesiis certus iudicio episcopo clericorum numerus ordinetur " (280).
Benché sia alquanto incerto cosa precisamente si voglia indicare nel decreto con la parola vici, sembra tuttavia trattarsi probabilmente, anziché di grossi centri cittadini, dei più importanti capoluoghi pagensi, per grandezza o per celebrità, presso le cui chiese doveva porsi una data percentuale di clero. E poiché l'opportunità non poteva essere in tutti identica si richiedeva il giudizio del vescovo.
Comunque stiano le cose, che le pievi o chiese battesimali nelle nostre campagne incominciassero a sorgere col secolo V lo si può inferire anche dal fatto che nei primi tre secoli, e ancora nel quarto, ai soli vescovi era riservata l'ordinaria amministrazione del battesimo, così che non c'era che un battistero per città episcopale o diocesi.
Il nostro S. Ambrogio dedicava appunto parte della sua attività in questo officio, e Paolino potrà dire di lui, sia pure con alquanta esagerazione, che quanto egli era solito adempiere intorno ai battezzandi, alla sua morte a stento poteva essere disimpegnato da cinque vescovi. Segno del largo diffondersi della nuova fede.
Al battesimo, che ordinariamente si conferiva agli adulti presso il battistero della cattedrale seguiva l'amministrazione della cresima.
I sacerdoti potevano amministrare il battesimo privato in caso di estrema necessità.
La parrocchialità in quei primi secoli era tutta raccolta presso la cattedrale o presbiterio vescovile.
Vi si concentrava tutta l'amministrazione della Comunità cristiana diocesana tanto nello spirituale quanto nel temporale. Il clero formava un tutt'uno col proprio vescovo seco lui convivente.
Ed è infatti col quinto secolo che abbiamo le prime memorie della costruzione di edifici sacri nella campagna milanese e comasca. Il battistero di Riva San Vitale, oggi appartenente alla diocesi di Lugano ma anticamente a quella di Como, affonda le sue origini nei primi decenni di quel secolo, benché le soprastrutture attuali rimontino al secolo XI (281). E altrettanto si dica per Galliano, le di cui originarie costruzioni cristiane rimonterebbero a quel lontano secolo, e che subirono una rifabbrica nel secolo XI, allorquando vi era custode Ariberto da Intimiano (282).
Che nel secolo V nelle nostre campagne non potessero mancare edifici cristiani per il culto, di poi scomparsi o rifabbricati nel giro dei secoli successivi, lo si può arguire dal fatto che verso la fine del quinto e nella prima metà del sesto si hanno, come si è detto, le più antiche memorie di preti o diaconi nelle comunità cristiane di Galliano, Garlate, Lecco, Agliate. Si può pertanto ragionevolmente supporre che già fin da quel tempo esistevano chiese plebane rurali.
Quelle iscrizioni, strettamente parlando, ci attesterebbero l'esistenza, se non di una pieve, certamente però di un centro cristiano col loro presbiter. Ma se consideriamo che quelle epigrafi vennero trovate in luoghi dove si formarono le chiese plebane o matrici, mi sembra che già fin d'allora vi esistesse embrionalmente la parrocchia rurale, in quanto che i présbiteri che vi risiedevano lo erano evidentemente allo scopo di assistere spiritualmente quei fedeli in nome del vescovo, e che perciò presso la chiesa non doveva mancare la vasca battesimale, la quale è uno degli elementi più importanti costitutivi della parrocchialità.
Non si può inoltre supporre che il prete stesse soltanto per il servizio religioso della singola comunità cristiana del luogo, quasi che allora non esistessero altri cristiani in località minori dei dintorni, perché sul finire del V secolo le popolazioni indigene delle nostre campagne erano ormai tutte più o meno cristiane. Questi cristiani non potevano essere lasciati in balia di se stessi, fluttuanti qua e là, ma avere il loro centro, ch'era la chiesa battesimale del proprio pago o distretto, nel quale riunirsi ed avere la necessaria assistenza spirituale. S'imponeva perciò fin d'allora una certa qual distrettuazione rurale ecclesiastica, ossia una primitiva qualsiasi organizzazione parrocchiale.
Né mi pare possa fare difficoltà il trovare in quelle nostre più antiche iscrizioni sacerdotali la semplice espressione di presbiter in luogo di archipresbiter, che indicherebbe con certezza la pieve organizzata con pluralità di clero. Infatti nella prima metà del sesto secolo abbiamo nelle Gallie parecchi Concili, i quali tra l'altro, fecero oggetto di particolari disposizioni le parrocchie di campagna. Orbene il sacerdote capo delle medesime è chiamato presbiter e non archipresbiter (283).
Forse presso a poco, dev'essere avvenuto così anche da noi, per quanto non si possa dire con certezza, per mancanza di documenti, quali riferimenti avesse in quel tempo la parrocchia rurale milanese con la francese, date le diverse condizioni politiche e sociali (284).
Il primo accenno all'esistenza di arcipreti rurali (archipresbyteri vicani) è nel Sinodo di Tours del 567, mentre in Italia non appaiono prima del secolo VIII, e nel milanese col secolo IX (285).
Se alle origini delle pievi, poteva essere sufficiente un prete singolo con qualche chierico minore, nondimeno la necessità di un clero, più o meno numeroso, presso ciascuna chiesa battesimale doveva farsi sentire man mano che la parrocchia rurale veniva organizzandosi. E ciò per più motivi, e cioè per la vastità del territorio cui si doveva attendere nella cura delle anime, per il miglior decoro possibile nei divini offici (salmodia ecc.), e specialmente per il bisogno di formare presso il plebano un clero che continuasse nel tempo la vita spirituale della parrocchia.
Non va dimenticato che la parrocchia rurale originaria si è modellata, nella sua evoluzione strutturale, sulla chiesa madre vescovile, la cattedrale; e come in questa si svolgevano i riti più importanti del culto e vi si riproduceva il clero, così nelle campagne questi offici, (esclusi quelli propri del vescovo), vennero esercitati dalle chiese plebane rurali rispettivamente per il proprio territorio. Funzionavano, sotto quest'ultimo aspetto, in certo qual modo, come piccoli seminari.
Giovani non coniugati, a quanto pare, si raccoglievano in vita comune col sacerdote seniore, capo della parrocchia, per ricevere l'educazione spirituale e l'istruzione ecclesiastica, ed essere così preparati a ricevere gli ordini sacri.
Ce lo conferma il Concilio dei vescovi franchi tenuto a Vaison nel 529, nel quale si dice che questa era consuetudine nel clero di tutta Italia (286).
Probabilmente, ritengo con altri, che fin d'allora ci doveva essere nel clero plebano, qualunque ne fosse il numero, una certa qual comunanza di vita perché questo era lo spirito e la pratica della Chiesa dei primi secoli cristiani, e sia perché vantaggiosa alla disciplina ecclesiastica, al regime delle rendite comuni, al vivere in stato di celibato, al vicendevole aiuto nell'assistenza religiosa alle popolazioni, alla formazione dei giovani che si incamminavano alla vita ecclesiastica, ecc.
Nel comasco, tra il quinto ed il sesto secolo, come si ha nella vita del beato Antonio Lerins scritta da Ennodio, sembra che vi fosse nel capoluogo della Valtellina un certo numero di ecclesiastici viventi in comunità (287).
Un altro indizio, a parer mio, dell'abbozzarsi delle nostre più antiche pievi, lungo il secolo V, si è che sul declinare di quel secolo e nella prima metà del seguente, vediamo la massa dei beni episcopali tendere al suo frazionamento giuridico ed economico, appunto perché, tra l'altro, venivano man mano affermandosi le parrocchie di campagna con chiesa battesimale o matrice officiata da un clero
stabile (288). Il recarsi del clero alla sede vescovile a ritirare settimanalmente o mensilmente le derrate ad esso assegnate dal vescovo non era sempre né comodo né conveniente.
È noto che il vescovo, fino a quel tempo, era rimasto l'unico amministratore del patrimonio della sua diocesi, e distribuiva a suo giudizio i frutti del patrimonio agli addetti della sua casa ai membri del clero, ai poveri, e una parte alla conservazione degli edifici sacri e della suppellettile per il culto.
Questa distribuzione divenne un obbligo di diritto, dopo che papa Simplicio nel 475 legalizzò la consuetudine, ordinando la quatripartizione delle rendite delle sue chiese di Roma, e che papa Gelasio nel 484 estese il provvedimento di Simplicio dapprima alle chiese dell'Italia meridionale direttamente soggette a Roma, e poi entro breve giro di tempo anche ai vescovi dell'Italia settentrionale e poi di tutto l'Occidente. Pur rimanendo sempre la libera assegnazione dei frutti del patrimonio diocesano una prerogativa del vescovo, si costituirono, per così dire, mense separate per le diverse mansioni, e quindi anche le chiese battesimali ebbero assegnata la loro parte.
Incominciò quindi ad essere considerata in sé stessa la funzione ecclesiastica, non la persona. E di importanza per la storia dei benefici ecclesiastici minori è altresì il decreto di papa Gelasio, per il quale nessuna nuova chiesa poteva aprirsi al culto se prima non fosse sufficientemente dotata per il suo funzionamento e l'assistenza spirituale.
In Francia le disposizioni di papa Gelasio sono accolte l'anno 517 nel Sinodo di S. Romano d'Albon, che non permette l'apertura di chiese se prima non sono assicurati al clero officiante i mezzi sufficienti al vitto e al vestito, e vengono poco dopo confermate in quello d'Orleans del 541, che precisa le generiche intimazioni anteriori, esigendo per ogni chiesa battesimale la dotazione di " terrae... sufficientes " (289).
Altrettanto sarà avvenuto probabilmente anche nell'Italia superiore.
Possiamo perciò, stando sulle generali, distinguere nella formazione delle nostre pievi o prime parrocchie rurali tre momenti importanti nel loro processo evolutivo. In un primo tempo si ebbe la così detta fase missionaria o di propaganda da parte di sacerdoti o chierici mandati dal vescovo, ma seco lui conviventi.
In un secondo tempo, il largo diffondersi del cristianesimo rese necessaria l'erezione di chiese battesimali rurali in dati distretti con un clero stabile di uno o più sacerdoti che esercitasse poteri già del vescovo, esclusi quelli ch'erano rimasti di particolare spettanza vescovile (Ordine, ecc.).
Senonché il risiedere di sacerdoti presso quelle chiese, richiedeva di necessaria conseguenza una loro sistemazione economica.
Ciò che farà infatti il vescovo in un terzo tempo, coll'assegnare a queste chiese battesimali una porzione dei beni comuni diocesani, dei quali era l'unico amministratore; beni che i fedeli col passare degli anni, completeranno in meglio con offerte e lasciti, e che formeranno il patrimonio comune della chiesa. In tal modo la pieve rurale finì coll'essere autonoma spiritualmente ed economicamente, amministrandosi in ultimo da sé, sotto il controllo e la giurisdizione del vescovo (290).
Secondo una teoria di non pochi studiosi, la diocesi per la circoscrizione territoriale si sarebbe modellata sul municipio romano, e la pieve sul pago, teoria accettabile in linea di massima, perché non mancano eccezioni. Infatti - al dire del Lanzoni - come s'incontrano municipi che non furono diocesi, e diocesi che non furono municipi (291), così nel medioevo troviamo che talora l'estensione di una pieve non corrisponde a quella del pago romano. Tuttavia non si può negare che tanto le diocesi quanto le pievi più antiche abbiano, in generale, la loro radice nei quadri territoriali dell'amministrazione romana.
Il pago romano nella nostra regione briantina è, si può dire, la continuazione del pago celtico (gau), perché Roma rispettò le circoscrizioni territoriali preesistenti, come di poi le rispettarono i barbari invasori. Perciò si spiega come i pagi, e quindi le pievi, di Garlate, Brivio e Pontirolo si estendessero anticamente al di qua e al di là dell'Adda, ossia in territorio spettante in parte al municipio di Bergamo e in parte a quello di Milano (292).
Il pago comprendeva un determinato territorio rurale, più o meno vasto e popolato, che si reggeva con una propria organizzazione, ed i cui abitanti sparsi nei vici e nei fondi, erano chiamati pagani. Aveva i suoi capi detti magistrati ai quali spettavano gli affari interessanti il pago.
Centro del pago era ordinariamente il luogo dove sorgeva il delubro sacro ad una o più divinità venerate con culto comune dagli abitanti del territorio come numi tutelari. Colà accorrevano per le feste religiose, per il mercato, per gli affari di amministrazione riguardanti il territorio.
Il pago aveva inoltre una funzione censuale nell'ordinamento catastale romano, per cui si conservava inalterato e poteva durare anche se quasi spopolato, e i suoi determinati confini venivano riconosciuti ogni anno con una processione sacra che era indicata col nome di lustratio pagi.
Era pertanto una circoscrizione territoriale civile e religiosa ad un tempo, carattere che, colle pievi cristiane conservò pure nei secoli successivi.
La chiesa, secondo questa opinione dominante fra gli studiosi, avrebbe disposto con saggia opportunità le sue organizzazioni sulle circoscrizioni civili già esistenti. Dapprima organizzò le diocesi, e di poi col tempo gradatamente le pievi. E come il pago aveva il capoluogo distinto dai centri minori, così anche la pieve ebbe il suo centro nella chiesa battesimale, e le decime continuarono ad essere riscosse in base alle preesistenti organizzazioni rurali (293).
In generale al tempio pagano, il quale per lo più sorgeva in località appartate per quanto centrali al rispettivo territorio, sostituì in quel luogo o lì vicino la chiesa battesimale, dedicandola, di preferenza, ai santi Apostoli o a Martiri illustri. E poiché l'importanza dei luoghi di allora non va giudicata con criteri odierni, è forse questa la ragione per la quale troviamo antiche chiese plebane briantine erette in luoghi ancora oggi, a tanta distanza di secoli, con ben scarsa popolazione in confronto dei vicini borghi come a Galliano (Cantù), Agliate (Carate), Garlate (Olginate), Incino (Erba).
Dico in generale, perché la chiesa avendo finalità sue proprie pose talora il centro della pieve in luoghi che per qualsiasi motivo riteneva più adatti al suo scopo (castra ecc.).
Adottò inoltre la Chiesa la maggior parte delle consuetudini locali, in quanto non erano incompatibili con la nuova religione, volgendo in onore del vero Dio le processioni e le feste che prima si facevano in onore degli Dei, e ciò per facilitare la conversione dei pagani attaccati tenacemente alle loro credenze e tradizioni.
Non si ha però a credere che il culto cristiano sia stato inquinato dai riti pagani. È vero che l'uso dell'incenso, dell'acqua lustrale, delle lampade, degli ex-voto, delle immagini sacre agli angoli delle strade e delle piazze, delle processioni, ecc. passò nel culto cristiano, ma tutto questo ci dice che certi segni o manifestazioni esteriori non sono propri di una religione piuttosto che di un'altra, ma che appartengono a quella serie di atti comuni a tutte le religioni, che l'uomo universalmente compie per manifestare l'ossequio alla divinità. Così ad esempio, se i pagani si prostravano davanti alla statua di Giove, non vuol dire per questo, se noi faciamo altrettanto verso Dio, che il nostro sia atto da pagano e non da cristiano (294).
* * *
Al momento dell'invasione dei Longobardi (568) ritengo per certo, ripeto, che la Brianza fosse pressoché tutta cristiana come tutto l'agro milanese, e perciò divisa in pievi stante l'urgente necessità di assistere religiosamente i rurali, con un clero vivente in comune secondo la consuetudine romana-bizantina, benché non compaia il titolo di arciprete a designare il plebano.
Fin verso la metà del VI secolo il comasco e i colli briantei rimasero tra i luoghi che ebbero meno a soffrire per le invasioni barbariche, perché fuori mano dalle strade che tenevano gli invasori nel scendere nella valle padana. Si mantennero perciò in una condizione di relativo benessere, per quanto non potessero sfuggire ai disastrosi effetti economici e sociali che si riflettevano oltre i confini dei territori direttamente percossi. Nelle campagne dominate dal latifondismo regnava l'insicurezza e la miseria.
Odoacre ed i re Goti si dimostrarono in generale tolleranti verso le chiese ed il clero cattolico. Nell'insieme il patrimonio ecclesiastico non fu danneggiato per le vicende politiche del secolo V e dei primi decenni del VI, benché le rendite si assottigliassero per le terre che andavano semincolte e svalorizzate.
Le dolenti note incominciarono anche per noi coll'aspra guerra tra Goti e Bizantini (535). Nel 539, mentre Milano veniva per una seconda volta presa e danneggiata ben più terribilmente dal goto Uraia, un'orda di Franchi, condotti da Teodeberto, scendeva dal Gottardo a saccheggiare i nostri paesi (295).
Le condizioni nostre si fecero peggiori, non molti anni dopo, colla discesa dei Longobardi, in parte ariani e in parte pagani, gente di stirpe germanica dai costumi rozzi e violenti, che commisero spogliazioni e stragi, non risparmiando nemmeno le chiese, nei primi anni del loro dominio. Era tale il terrore che procedeva l'avanzata di questi barbari, che gran parte delle popolazioni fuggivano mettendo in salvo le persone e gli averi. Lo stesso vescovo di Milano, Onorato, con gran parte del clero e dei cittadini, si rifugiò a Genova, dove rimase trapiantata la chiesa milanese fin quasi alla metà de secolo seguente.
L'affermazione di Gregorio di Tours (296), che in Italia, in seguito all'invasione longobarda molti sacerdoti furono uccisi e le chiese impoverite (ecclesiis spoliatis, sacerdotibus interfectis); le reticenze di Paolo Diacono; i lagni di qualche Sinodo provinciale come quelli del Sinodo Gradense del 579 (297); le lettere di papa Pelagio di qualche anno appresso (298); i monaci che (barbarica occasione) dispersi fuggono a Roma; l'asilo aperto dai papi nelle loro città a migliaia di vergini scappate alle minacce dei Longobardi, ci fanno ritenere che gli invasori occuparono non solo i beni dei grandi proprietari laici, ma ben anche quelli di chiese e di monasteri. E probabimente anche le pievi, se non in tutto, almeno in parte non saranno andate esenti da violenze.
La desolazione in certi luoghi durò a lungo. Nel 593 S. Gregorio Magno constata con dolore che in Lombardia (la lettera è diretta al clero milanese) i fondi delle sue chiese sono senza coltivatori (nullus terram nostram cultor inhabitat).
|

|
|
|
Laghi del Pian d'Erba
(da : Lombardia pittoresca, Milano, Stella e figli, 1836, Litografia su disegno di Elena).
|
|
|
|
|
Il dominio dei Longobardi durò oltre duecento anni (568-774). Gli ariani ebbero forse, come pensa taluno, clero proprio fino alla loro conversione, ch'ebbe principio con la cattolica regina Teodolinda sul finire del secolo VI, e ultimata verso il tramonto del secolo seguente.
La religione cattolica concorse a rendere meno difficile la fusione tra gli indigeni e il popolo invasore. Perciò coll'avvento di re cattolici le condizioni sociali migliorarono alquanto, e si ebbe un risveglio religioso esplicantesi qua e là in fondazioni e dotazioni di chiese.
Senonché, mentre consta che regnanti e signori longobardi eressero chiese e monasteri per conto loro, - e per quello che riguarda la Brianza si attribuisce alla regina Teodolinda la chiesa di S. Giovanni Battista in Monza; al re Desiderio la chiesa di S. Pietro sopra Civate; al re Cuniperto il monastero ossia la collegiata di S. Giorgio a Cornate d'Adda, e di quel tempo sarebbe pure la chiesa già collegiata di S. Pietro a Beolco, ecc., - nessuna memoria ci è rimasta che abbiano eretta qualche nuova pieve rurale, tranne quella di Desio, che in base ad una certa qual tradizione la si vorrebbe fondata non da re o signori longobardi, ma dall'arcivescovo di Milano Giovanni Bono nel 649 quando da Genova ritornò a Milano.
La fondazione e la distrettuazione delle diocesi e delle pievi cristiane erano infatti fino dalle origini di spettanza dell'autorità ecclesiastica.
Che cosa sia particolarmente avvenuto delle pievi rurali durante la dominazione longobarda non si conosce. Forse le pievi non interessavano gran che i Longobardi, i quali tenevano diviso il loro territorio in iudiciarie, centene, e decaníe.
Quello che, in generale, si può asserire si è che attraversarono un periodo di decadenza: imbarbariti i costumi, rallentati i vincoli della disciplina ecclesiastica, deperiti gli edifici sacri, usurpati da mani rapaci parte dei beni ecclesiastici, manomesso in parte talora, per confusione o per usurpazione, lo stesso territorio delle pievi nelle zone confinarie. Ce lo conferma l'opera di riforma e di restauro intrappresa dall'autorità religiosa e civile dopo la caduta del regno longobardo (299).
Forse per questo, mentre in Francia coi Merovingi la parrocchia rurale poté perfezionarsi coll'archipresbiterato, da noi la dominazione longobarda ne ritardò il suo sviluppo organizzativo, e l'arciprete comparirà più tardi.
Ma nonostante tutto, la chiesa plebana battesimale continuò ad essere un centro di affratellamento della popolazioni rurali. Nello stesso tempo che vi si recavano per le obbligatorie funzioni parrocchiali imparavano a conoscersi e ad aiutarsi nei loro bisogni e nelle loro aspirazioni. Sappiamo infatti che davanti alle chiese tenevano le loro adunanze.
La chiesa di S. Giovanni Battista in Monza eretta, come si è detto, per volontà della regina Teodolinda, e nella quale fece battezzare nel 603 il figlio Adaloaldo, per via di privilegi da parte di regnanti e di pontefici, raggiunse in seguito tale importanza da divenire la matrice del luogo e del suo distretto, ecclissando probabilmente la chiesa battesimale precedente che a Monza non poteva mancare, data la sua rilevanza locale allorquando la occuparono i Longobardi (300).
S. Giovanni Battista divenne un santo protettore dei Longobardi (301).
Di origine longobarda si potrebbe inoltre forse sospettare l'antica pieve di Trenno, dedicata al Battista, da tempo scomparsa assorbita dalla città di Milano.
Si scrisse che nel secolo VII vi fu un'immigrazione di monaci e di preti orientali nel milanese, scacciati dai loro paesi dalle guere islamiche, i quali si fusero col nostro clero. Quale influsso abbiano potuto avere sulla disciplina ecclesiastica o sul rito ambrosiano è difficile dire.
Per quello che riguarda le nostre pievi briantine nulla di certo possiamo conoscere, benché da alcuni siasi pensato di far risalire alla prima metà del secolo VII le pievi di Incino e di Oggiono, dichiarandole di ispirazione Tricapitolina, in base al culto ivi praticato a S. Eufemia, e in un primo tempo appartenenti alla diocesi di Como (302). Ma non si tratta che di supposizioni più o meno attendibili. Di veramente certo niente si può affermare. Si stenta per altro a credere, ad esempio che Incino, nota località fin dal tempo della dominazione romana per incrocio di strade, possa avere aspettato fino al secolo VII ad avere una chiesa plebana battesimale. E altrettanto press'a poco si dica di Oggiono.
Durante la dominazione franca, con Carlo Magno e successori troviamo, come si è osservato, il potere civile ed ecclesiastico impegnato, tra l'altro, nella sistemazione delle pievi.
Uno dei principali mezzi per raggiungere lo scopo, fu quello di rimettere in vigore la vita canonica fra il clero non solo delle cattedrali, ma altresì in quello delle pievi. È noto che Carlo Magno voleva " omnes clerici aut monaci aut canonici ", come sta scritto nel Capitolare dell'anno 789.
Al dir del Savio gli ecclesiastici della nostra metropolitana avrebbero incominciato ad abbracciare la vita regolare canonica sotto Angilberto II, arcivescovo di Milano dall'824 all'859 (303), ma non consta che si allargasse anche alle pievi tranne forse che a Monza (304); e se introdotta non dev'essere continuata a lungo, perché la regola di Codregango conteneva il germe della dissoluzione coll'aver acconsentito fra i canonici la proprietà privata dei proventi del ministero, facendo nascere cupidigie e dissensi fra i membri della stessa comunità, germe ch'ebbe il primo sviluppo nel precedente Concilio di Aquisgrana dell'anno 817.
L'imperatore Lotario nell'anno 823, da Corte Olona presso Pavia, impose a ciascun vescovo che prima delle calende di ottobre dell'anno seguente introducesse nel proprio clero sia di città che di campagna, la vita canonica, e che a questo scopo si sistemassero tosto le abitazioni canonicali. Ogni chiesa plebana doveva essere restaurata a spesa del popolo a cui serviva.
Decretò inoltre che qualunque persona la quale facesse costruire una chiesa battesimale (non è detto se plebana o privata signorile), e il vescovo ne consacrasse il fonte, non per questo il fondatore venisse a perdere il diritto di patronato (305).
L'anno seguente volle che ogni chiesa battesimale plebana avesse i confini del suo distretto ben precisati, e che ad essa fossero chiaramente assegnati i villaggi dai quali esigeva le decime: " ut terminum habeat unaquaque ecclesia de quibus villis decimam accipiat ".
Saggio decreto, osserva il Giulini, perché in tal modo le pievi furono definite nel loro ambito territoriale e giurisdizionale, e tali si conservarono lungo i secoli. I governi stessi per pratica comodità amministrativa adottarono di poi anche nel civile tale circoscrizione territoriale (306).
* * *
Di parere contrario si è recentemente dichiarato il Palestra, scrivendo che " È da tener presente che le pievi sorgono gradualmente, e che la graduatoria è possibile fissare quasi sempre se si considera il santo titolare della chiesa plebana; sorsero Pievi nel secolo V, nel secolo VI, e nel VII in piena dominazione longobarda; infatti la Pieve di Desio sarebbe stata fondata, secondo una certa tradizione, verso il 649 dall'arcivescovo Giovanni Buono quando lasciò Genova per ritornare a Milano ". E continua a dire che " sorsero numerose Pievi nell'ultimo periodo della dominazione longobarda (secolo VIII), e la graduatoria si spinge fino ai tempi di S. Carlo Borromeo, il quale soppresse vecchie pievi e ne fondò delle nuove " (307).
Con tutto il rispetto delle opinioni altrui, questo continuo prolificare di pievi dal secolo V al secolo XVI mi sembra un'evidente esagerazione, non sorretta da documenti, e del resto ben difficilmente documentabile.
Non si può tuttavia escludere, benché la Chiesa sia di sua natura, e specialmente nel passato, conservatrice delle sue istituzioni, la possibilità, date le diverse condizioni sociali, politiche, e religiose svoltesi nei secoli, dell'erezione di qualche nuova pieve, togliendo il necessario territorio alle circostante pievi originarie, come avvenne per quella di Desio dedicata a S. Siro. Si tratterebbe però sempre di supposizioni e non di certezza, e in ogni caso di eccezioni.
Comunque sia avvenuto, per la Brianza ed il restante territorio milanese, sta il fatto che durante il periodo longobardo non si conosce che la fondazione della sopr'accennata pieve di Desio.
Se è vero che i Longobardi ebbero dei santi preferiti (Santa Maria, S. Giovanni Battista, S. Pietro apostolo, S. Michele, S. Giorgio, ecc.), è altrettanto vero che il culto dei santi, per lo meno qui da noi, era già in uso presso le locali preesistenti popolazioni rurali cristiane.
Inoltre si può anche osservare che, se avessero fondate altre nuove pievi, se ne sarebbe pur rimasta qualche memoria, come ci è rimasta di altre loro chiese private signorili.
Riguardo poi ai tempi di S. Carlo, la pieve, in quanto primitiva parrocchia rurale, più non esisteva, essendo divenute parrocchie i singoli villaggi d'ogni distretto plebano. Vi erano subentrati i Vicariati foranei che erano e sono ben altra cosa.
* * *
Ordinò inoltre Lotario che si distruggessero le chiese dove fossero più del bisogno. Là dove invece fossero necessarie e non avessero dote e cioè beneficio, volle che gli uomini liberi i quali dovevano intervenire ai divini offici, le assegnassero un podere di dodici misure di terreno, detto manso, con due servi acciò vi potessero stare dei sacerdoti ad officiarle.
Dalla distruzione delle chiese ritenute superflue nacquero gravi inconvenienti, ai quali cercò di porre riparo Lodovico il Pio nell'829 (308).
Ventisei anni dopo nel Sinodo di Pavia dell'850, presente Angilberto II arcivescovo di Milano, furono stabiliti 25 decreti riguardanti la disciplina ecclesiastica, fra i quali al c. 13 si impose che ad ogni pieve dovesse presiedere un arciprete il quale non solo vigilasse sul volgo, ma ben anche sui sacerdoti residenti presso i titoli minori (chiesuole vicane non battesimali). Né dicesse il vescovo di voler farne a meno dell'arciprete, perché com'egli deve presiedere alla chiesa matrice (cattedrale), così gli arcipreti devono presiedere alla plebana " ut in nulla titubet ecclesiastica sollicitudo " (309).
E nella Dieta di Pavia dell'876, presenti Carlo il Calvo e Ansperto arcivescovo di Milano (310), al c. 7, 8 fu stabilito che i fedeli laici nei giorni festivi se in città dovessero partecipare alle pubbliche stazioni, se nei villaggi e nei possedimenti (cascinali) alle funzioni liturgiche della plebana, e che nessuno osasse celebrare o far celebrare nelle loro case (oratori signorili) senza licenza del vescovo. I sacerdoti non dovevano essere commendati seculari potestati.
Si potrebbe aggiungere altri provvedimenti emanati durante la dominazione franca, come ad esempio: solo presso la plebana stesse il battistero; le chiese e gli xenodocchi fossero rimessi secondo la consuetudine; soltanto le chiese plebane avessero il diritto delle decime (ubi sacrosanta dantur baptismata come prescrisse anche papa Leone IV nell'850); l'arciprete fosse un degno sacerdote da eleggersi dal seno del clero plebano coll'assenso del popolo (311); i nobili e i potenti, benché tenessero oratorii o chiesuole presso le loro dimore, dovessero partecipare ai riti festivi che si celebravano nella chiesa plebana (312); qualora i vici ossia i villaggi della pieve volessero un sacerdote presso la loro chiesuola vicana lo potessero tenere ma col consenso del vescovo e a loro spese; ecc.
È un movimento di restaurazione che procedette fra molte difficoltà dati i tempi ancora semibarbarici. Tuttavia, se non in tutto, almeno in parte diede buoni frutti.
Nel milanese il capo di una chiesa plebana nell'ottavo secolo era distinto col titolo di seniore oppure di presule, o di custode. Nei secoli seguenti troviamo in uso quello di arciprete (archipresbyter, archipresbyter et custos), finché nel secolo XII, con la vita regolare canonica imposta dalla riforma gregoriana, assunse il titolo di preposto (praepositus), il quale finì per generalizzarsi, fatta qualche eccezione, e si mantenne ai Vicari foranei, anche dopo scomparsa la vita comunitaria, e la pieve stessa in quanto tale (313).
Delle pievi briantine il cui pievano appare la prima volta col titolo di arciprete è quello di Missaglia nell'anno 835 circa, ma poiché nella pergamena si accenna a cose di quarant'anni prima, quel titolo potrebbe forse risalire al secolo precedente, ossia allo scorcio del secolo VIII (314).
Arciprete significa capo di preti: suppone quindi un clero a lui soggetto.
La chiesa plebana col suo battistero era la parrocchiale per tutta la pieve, e soltanto in essa si celebravano le funzioni parrocchiali: solo parroco l'arciprete coadiuvato dal suo clero.
All'arciprete incombeva innanzitutto l'obbligo della predicazione, per cui in caso d'impedimento veniva supplito da altro sacerdote o da qualche diacono col leggere un'omelia dei santi Padri, e dell'amministrazione dei Sacramenti, dei quali il Battesimo ordinariamente lo si amministrava nei giorni della vigilia di Pasqua e di Pentecoste, poiché durava ancora l'uso di riceverlo quando si era giunti ad una certa età: soltanto in caso di estrema necessità (pericolo di morte, ecc.) lo potevano altri in qualunque tempo (315).
A lui spettava il dovere di sorveglianza sui laici e sul clero tutto del suo distretto, compresi i monasteri e gli xenodocchi, e di avere cura dei poveri, delle vedove, degli orfani, degli ammalati, e di visitare alla domenica i carcerati.
Assegnava ai cappellani le chiese o titoli minori della pieve, ma alla plebana spettavano le decime. Con le rendite della sua chiesa doveva provvedere al mantenimento dei suoi chierici, degli inservienti, ecc.
Aveva stretto obbligo di tenere presso di sé dei giovani chierici per istruirli nelle lettere, nel canto, e nelle scienze sacre preparandoli al sacerdozio: all'arciprete era concesso di dare gli ordini minori ai suoi chierici, concessione che, come si è detto, fu tolta dal card. legato Guido Somma nel 1149, esclusa la chiesa di Monza (316).
Questi ed altri, in generale, gli obblighi annessi alla carica di arciprete, il quale veniva eletto dal clero locale, scegliendolo dal suo seno; e come in città il popolo prendeva parte all'elezione del vescovo altrettanto in ciascuna pieve si richiedeva il consenso della popolazione o dei suoi rappresentanti per l'elezione dell'arciprete: l'eletto non poteva essere rimosso dal vescovo se non per giusta causa (317).
Col passare degli anni i diritti dei laici andarono man mano eliminandosi fino a scomparire. Nel secolo XIII, e precisamente nel 1234, i canonici di Vimercate eleggevano a pluralità di voti i loro colleghi, e parimenti, in uno coi cappellani della stessa pieve, a quanto sembra, eleggevano e presentavano all'arcivescovo il nuovo prevosto (318). Probabilmente presso a poco doveva similmente avvenire in tutte le nostre pievi.
* * *
La fine dell'impero carolingio con la morte di Carlo il Grosso nell'888, le susseguenti turbolenze coi re d'Italia, e il successivo passaggio ai tedeschi con Ottone I (962) della dignità imperiale del sacro romano impero, segnarono la decadenza di quel tanto di vita in comune che poteva essersi introdotta qua e là durante la dominazione dei carolingi, poiché era stata in gran parte frutto della loro politica religiosa. Ad ogni modo non fu di certo la forma prevalente di vita nel clero d'Italia, e tanto meno nel nostro clero milanese.
Corruzione e abusi, che già fermentavano nel secolo IX, presero a dilagare nel clero nei secoli X e XI.
Secoli di fede, se si vuole, ma turbolenti e di costumi rilassati.
Ad aggravare la situazione delle nostre pievi l'arcivescovo Landolfo, sul finire del secolo X, introdusse l'abuso di infeudarle ai laici.
Il vivere del clero in comunità si rendeva perciò sommamente necessario per risollevare spiritualmente il tenore della vita sacerdotale, e così nello stesso tempo influire efficacemente all'emendamento dei costumi dei laici. Era inoltre di giovamento per tenere a freno, col sistema unitario collettivo plebano, le invadenze e le prepotenze dei signori feudali nelle cose di chiesa.
Ariberto, arcivescovo di Milano dal 1018 al 1045, tentò di imporre qualche rimedio, ma alla sua morte tutto svanì (319).
Vediamo pertanto nel secolo XI santi sacerdoti, vescovi e pontefici, e tra questi ultimi in particolare modo Gregorio VII (papa dal 1073 al 1085), che si affaticarono in quest'opera salutare di riforma. A Milano si distinse S. Arialdo, ucciso dai suoi avversari nel 1066 (320).
Le loro fatiche si conclusero con la vittoria. E così debellati anche nella nostra diocesi la simonia ed il nicolaismo, la vita regolare canonica verrà finalmente abbracciata e praticata sul declinare del secolo XI e specialmente nei primi anni del seguete (321).
Riguardo alla Brianza, il Dozio pensò che a Vimercate ci fosse vita regolare canonica fin dal 1039, perché in un documento di quell'anno la plebana, dedicata a S. Stefano, è detta " basilica et canonica ", e in susseguenti carte i preti son chiamati officiali e canonici. Il fatto non sarebbe per sé inverosimile, in quanto quel clero avrebbe abbracciato il vivere canonicamente, seguendo la riforma che in quegli anni venivano inculcando nel clero milanese S. Arialdo, Erlembaldo, e Landolfo Cotta.
Similmente inclinò a credere che lo fosse anche a Brivio fin dal 1036, argomentandolo dal fatto che allora vi erano preti detti officiali (officiales), i quali nella chiesa plebana celebravano la Messa e vi recitavano le ore canoniche (322). Ma forse più che ad una vita regolarmente canonica, si può anche pensare ad una forma capitolare per motivi patrimoniali e rendite comuni.
Senza condannare in blocco la classe sacerdotale di quei tempi, il che sarebbe ingiusto, perché non mancavano dei buoni e santi preti o comunque in buona fede, le ben note tristi condizioni in cui versava la Chiesa milanese per il dilagare della simonia e del nicolaismo, vizi che decisamente si opponevano ad una vita regolare canonica che non esisteva nemmeno presso i corpi ecclesiastici più distinti della diocesi, ci fanno ritenere che il mal esempio, scendendo dall'alto non poteva certamente rendere migliore il clero della campagna.
Ammesso pure che allora vi fosse un capitolo collegiato nelle pievi, questo per sé non presuppone di conseguenza il vivere in comune. È noto che, anche dopo scomparsa la vita regolare canonica imposta da Gregorio VII, rimasero i capitoli collegiati per ragioni di patrimonio e di servizio religioso.
Comunque, la riforma gregoriana entrata nella pratica sul declinare del secolo XI e nei primi decenni del seguente, durò più o meno ben osservata, fin quasi alla fine del secolo XIII. (323)
* * *
Il prevosto (paepositus) continuò ad essere scelto dal loro seno dagli stessi canonici, e presentato all'arcivescovo per la conferma. I canonici si dicevano fra loro fratelli o confratelli (fratres, confratres).
Il numero dei canonici non era uguale in tutte le pievi, ma dove più e dove meno: non vi mancavano diaconi, suddiaconi e chierici minori.
Tutti gli atti inerenti ai beni capitolari erano stipulati in nome collettivo, ossia coll'assenso di tutto il collegio dei canonici.Alle canoniche plebane era di sovente unito qualche xenodochio od ospizio, il quale dipendeva dal prevosto.
Il fine principale, oltre il vivere comunitariamente in una sol casa (canonica) e con un unico refettorio e dormitorio secondo la regola, era l'ufficiatura quotidiana corale, il servizio parrocchiale per tutta la pieve (amministrare i Sacramenti, predicare, assistere gli ammalati, funerare, distribuire elemosine ai poveri, benedire, ecc.), e l'educazione e istruzione dei giovani, nella grammatica e nel canto, che si avviavano alla carriera ecclesiastica per essere a suo tempo ordinati sacerdoti dal vescovo (324).
Il prevosto continuava ad essere l'unico vero parroco della pieve, e la plebana l'unica parrocchiale. Al prevosto infine, come già all'arciprete, spettava la sorveglianza del suo clero.
* * *
La seconda metà del secolo XII fu dominata dalla lunga ed aspra guerra fra i Comuni Lombardi ed il Barbarossa; lotta terminata con la vittoria dei Comuni e suggellata nella pace di Costanza (1183): Milano e gli altri Comuni ebbero riconosciuta la propria autonomia comunale.
Come tutte le grandi guerre, aveva causato un grande scompiglio dal quale scaturì e prese l'avvio un profondo mutamento politico, sociale ed economico, dal quale non sfuggirono, per lo meno in parte, le stesse istituzioni ecclesiastiche.
Già nei primi anni del secolo seguente (XIII) in piena libertà comunale, mentre da una parte Milano s'incamminava verso uno spiccato incremento industriale, commerciale e civile, dall'altra abbiamo i sintomi non solo del rallentarsi del vivere in comune del clero (325), ma altresì della corrosione della parrocchia in senso antico. Infatti le chiese sussidiarie dei vicinati cittadini si avviano a loro volta a diventare, di fatto, chiese battesimali (326).
È l'aspirazione all'autonomia, ad una maggiore indipendenza e libertà che si manifesta negli individui e nelle istituzioni, e che dalla città a poco a poco si estenderà alla campagna.
Infatti non pochi signori, e specialmente quelli ecclesiastici tradizionalmente più conservatori, già dallo scorcio del secolo XII e quasi per tutto il XIII secolo, cercheranno coll'emanare statuti di mantenere il potere di imporre ordinamenti, di pronunciare sentenze, di stabilire e riscuotere tasse, di esigere prestazioni reali e personali nei loro feudi.
Della regione briantina sono noti gli statuti signorili di Arosio, e quelli di Cremella, Bulciago, Calpuno, Monguzzo e Castelmarte; i primi emanati dal Monastero Maggiore di Milano, gli altri dalla Chiesa Monzese.
Questi statuti coi quali i signori si sforzavano di tutelare i loro diritti e privilegi sono un indizio di quel moto liberale che dalla città era penetrato nel contado: indizio sicuro dell'agitarsi dei rustici anelanti a forme più libere di vita sull'esempio del Comune cittadino (327).
Dalle cose civili era facile il passo a quelle religiose per la stretta connessione che vigeva in quei tempi, dando principio, attraverso l'afflosciarsi della vita regolare canonica, alla lenta ma progressiva tendenza di emancipazione dalla matrice delle cappelle o titoli minori dei villaggi, e che finirà poi col scindere completamente la parrocchia unitaria, tanto più che le cappelle o chiesuole vicane avevano già, per lo più, dei beni proprii più o meno sufficienti, venutisi formando lungo gli anni per via di offerte e lasciti dei rispettivi fedeli locali. Questi beni stanno all'origine, di gran parte dei benefici delle odierne parrocchie rurali.
I villaggi (universitates locorum), incominciando dai più importanti, presero ad ambire un centro parrocchiale in luogo per un più comodo servizio religioso. Riusciranno infatti ad averlo col passare del tempo, dove prima e dove dopo a seconda dei mezzi per il suo funzionamento, attraverso il trasformarsi della cappellania in rettoria, e da questa in parrocchia vera e propria col Concilio di Trento. Il trapasso si svolgerà gradualmente, e in via di fatto, confusionariamente, per naturale evoluzione, più che di diritto.
Gerardo da Sessa, arcivescovo di Milano e legato pontificio, nel 1211 ritenne necessario di emanare decreti per la Chiesa milanese e per le suffraganee.
Per la chiesa ambrosiana, dopo aver deplorato la decadenza dal suo antico splendore a cagione delle eresie (328), e della mancanza di correzione, ordina agli ecclesiastici di non vestire lussuosamente, ai chierici che non avessero alcun beneficio di tenere buona condotta se non volevano essere esclusi da qualsiasi grado; che coloro i quali si ascrivevano al clero dovevano ricevere la tonsura presso quella chiesa alla quale erano destinati a servire, procedendo quindi ad ottenere i vari benefici assegnati a quella chiesa dagli ultimi gradi fino ai maggiori.
Inoltre nessun ecclesiastico poteva dormire fuori della canonica senza licenza dei superiori.
Al clero delle diocesi suffraganee, e che implicitamente valeva anche per la metropolita, si ribadisce, tra l'altro, il vivere in comune entro una casa canonica, dalla quale dovevano essere escluse le donne, e che si avesse un solo dormitorio e un solo refettorio nel quale durante la mensa si dovesse fare lettura spirituale (329).
Probabilmente questi decreti, che colpivano abusi e vizi allora serpeggianti nel clero lombardo, ebbero a sortire poca o nessuna efficacia, se nel dicembre del 1229 il cardinal legato Goffredo da Castiglione in un Concilio provinciale tenuto a Lodi e al quale intervennero vescovi del Piemonte, della Lombardia e della Liguria, ribadì ancor più espicitamente ordini sulla vita ed onestà del clero, sull'obbligo della vita regolare in comunità del clero, e di non essere investiti che di un sol beneficio: ordini che ogni vescovo doveva promulgare e far eseguire nella propria diocesi, come infatti per la diocesi milanese fece l'arcivescovo Enrico da Settala (330).
Nel 1250 l'arcivescovo Leone da Perego, visto che le istituzioni ecclesiastiche anziché migliorare tendevano al peggio, in un sinodo diocesano emanò decreti riguardanti la difesa della fede contro gli eretici, la disciplina e la libertà ecclesiastica. Richiamò il dovere di tutti i beneficiati di dimorare e prendere cibo presso le rispettive chiese e servire ad esse, tranne che fossero alle scuole o assenti per legittima causa, o tanto giovani che meglio convenisse fossero educati ed istruiti presso i loro parenti. Vietò l'investitura di più benefici in una sola persona, dispose che si attendesse alla cura d'anime da parte di coloro ch'erano tenuti, e non farsi supplire da altri (331).
Trent'anni dopo l'arcivescovo Ottone Visconti, dovette richiamare in vigore i decreti di Leone da Perego, e nel 1287 tenne un Concilio provinciale, " per emendare, nota il Giulini, la disciplina ecclesiastica che in mezzo a si tante e lunghe rivoluzioni era caduta in grande disordine " (332).
Il secolo XIII, per non parlare che della nostra diocesi, fu infatti uno dei secoli più movimentati con le lotte tra nobili e plebei, tra Torriani e Visconti, con fermenti di eresie e di ascetismo. Un insieme di avvenimenti che per inevitabile riflesso spingevano il clero a liberarsi dalla pesante e quasi monacale vita comunitaria, intaccando nello stesso tempo l'antico ordinamento parrocchiale plebano col dare facile occasione ai prevosti ed ai canonici di sottrarsi all'obbligo della residenza, e quindi trascurare la cura d'anime che per forza di cose veniva supplita dai sacerdoti residenti presso le chiesuole dei villaggi.
Comunque sia, nonostante i richiami dell'autorità ecclesiastica, il decadimento continuò lento ma inarrestabile il suo corso.
Vale la pena di ripetere che, se la pieve unitaria col suo clero vivente in comunità fu necessaria nell'alto medioevo per mantenere il clero nella retta via sacerdotale, e (in contrapposto per meglio resistere alle invadenze e prepotenze dei nobili e dei potenti), nondimeno il sorgere e lo svilupparsi di nuove insopprimibili esigenze di vita individuale e sociale, veniva man mano esaurendo la ragione della sua esistenza.
Benché il Liber Notitiae Sanctorum Mediolani, della fine del secolo XIII, non dia altra parrocchia che l'originaria plebana, tuttavia è certo che il moto evolutivo non era affatto cessato, pur continuandosi giuridicamente a considerare la chiesa plebana l'unica parrocchiale del suo distretto.
Infatti nel secolo seguente non mancano atti di immissione di sacerdoti nelle chiese dei villaggi delle nostre pievi, nei quali il prete immesso è chiamato rettore (beneficialis et rector); siamo dinnanzi ad una certa qual cura d'anime esercitata in luogo da un sacerdote beneficiato. L'antica parrocchia, in quanto tale, è pertanto in cammino a dissolversi, a suddividersi nei villaggi della pieve.
Si possono recare più esempi. Citerò soltanto un atto della parrocchia di Giusanno (pieve di Agliate), confinante con la parrocchia nella quale io risiedo.
In un istromento del 29 novembre 1367, nel quale vengono riconosciuti e descritti i beni e le decime spettanti alla chiesa dei santi Filippo e Giacomo, il sacerdote di quella chiesa è dichiarato beneficiale e rettore (333).
I rettori delle cappelle erano ancora eletti dal plebano, qualora non c'erano di mezzo patronati civili o monastici.
Non deve recare meraviglia se sul finire del secolo XIV nella Notitia cleri mediolanensis de anno 1398 circa ipsius immunitatem non troviamo ancora segnata parrocchia alcuna o meglio rettoría, all'infuori della canonica plebana e delle altre canoniche non plebane. Ciò si spiega, a parer mio, col fatto che trattandosi di un estimo, non si è fatto altro che seguire il metodo in uso per simili lavori, senza preoccuparsi di cose non inerenti allo scopo. Tanto vero che anche per la città di Milano chiama cappelle quelle che già sappiamo rettoríe (334).
D'altra parte giuridicamente la pieve rimaneva pur sempre l'unica parrocchia canonicamente riconosciuta, benché le cappelle o chiese dei villaggi avessero i loro particolari benefici, e per i quali erano tassate.
Da questo documento si rileva inoltre come più individui fossero contemporaneamente canonici beneficiati in diversi luoghi (335); il che è sicuro indizio non solo del grave affievolirsi della vita in comune, ma altresì dell'obbligo della residenza.
Il processo evolutivo continuerà nel secolo XV, spinto altresì dalle turbolenze avvenute durante lo Scisma d'Occidente (1378-1415).
Infatti lo Status Ecclesiae Mediolani del 1466 segna l'esistenza di non poche chiese parrocchiali nelle pievi della nostra diocesi (336), e l'arcivescovo Nardini con decreto del 26 settembre 1468 riservava a sé per l'innanzi l'approvazione dei sacerdoti eletti alla cura d'anime (337). Condizione di cose che similmente risulta dalle visite pastorali dell'arcivescovo Gabriele Sforza (338).
Nei primi tre decenni del secolo XVI, colle guerre che funestarono il milanese dopo la caduta di Ludovico il Moro, e più ancora l'assenza degli arcivescovi, giacché quando S. Carlo Borromeo nel 1565 assunse personalmente il governo della diocesi, questa da oltre mezzo secolo più non vedeva i suoi arcivescovi, i quali si accontentavano di riscuoterne le rendite delegando ad altri il governo, lo sfacelo della pieve sotto tutti i rapporti era un fatto già da tempo compiuto.
Ce lo prova il Liber Seminarii Mediolanensis del 1564 (339), nel quale vediamo quasi tutte le chiese principali dei villaggi delle pievi specificate col titolo di rettoríe. Non solo, ma parecchi benefici dichiarati ancora cappelle erano in realtà pur esse rettoríe come ci risulta dalle carte degli atti di visita anteriori a quell'anno.
Gli atti di visita pastorale di S. Carlo ci mostrano lo stato miserando nel quale erano cadute le prepositure plebane e non plebane. Vi erano di quelle che non avevano più nemmeno le case canoniche, rase al suolo completamente, o inabitabili, oppure convertite in altri usi (340).
I beni della massa residenziale per le quotidiane distribuzioni in gran parte usurpati. Dovunque assai ridotto il numero dei canonici e quasi nessuno residente in luogo: si erano in parte stabiliti nelle rettoríe della pieve in cura d'anime. S. Carlo che, al dire del Bescapè (341), ebbe dapprima in animo di richiamare come un tempo i canonici alla vita in comune, dovette desistere di fronte all'impossibilità, adoperandosi invece a sistemare col solo obbligo della residenza quelle canoniche che ancora potevano esserlo, con lo stabilire un numero sufficiente di canonici, onde potessero officiare con decoro, e col procurarvi le rendite necessarie. A questo scopo riunì collegiate, o altri titoli e benefici in luogo o presi altrove, oppure, se le collegiate si trovavano in luoghi poco abitati e incomodi, le trasferì in vicini grossi centri (342).
Tuttavia dove le collegiate canoniche poterono continuare furono nient'altro che un ente locale a sé stante residenziale, senza alcuna ingerenza nella cura d'anime dei villaggi un tempo soggetti.
L'antica originale parrocchia rurale era completamente finita. La pieve continuò, più che altro, quale circoscrizione civile amministrativa, come già nel passato; e Milano se ne valse fin quasi alla fine del secolo XVIII per la ripartizione e riscossione delle imposte e dei dazi.
Un particolare malanno aveva prodotto lo sfasciamento della vita canonica e del vincolo unitario della pieve: la scomparsa della scuola per i giovani chierici, che per antica originaria consuetudine si educavano e si istruivano presso le rispettive chiese plebane per essere ordinati ed incardinati poi alla stessa chiesa e far parte dell'ordo plebis. Ne avvenne di conseguenza che i giovani, i quali intendevano avviarsi alla carriera ecclesiastica, non ebbero più una appropriata istruzione ed educazione clericale, per cui si finì ad avere nelle campagne specialmente un clero racimolato da qualsiasi parte ed allevato in qualsiasi modo, e quindi per lo più ignorante, incapace e senza zelo, come ci è rivelato dagli atti di visita di S. Carlo Borromeo. E questo spiega come una delle riforme più urgenti cui pose mano S. Carlo, in base ai decreti del Tridentino, fu quella dell'erezione dei seminari diocesani.
Il periodo del Rinascimento (343), pur così splendido nelle lettere e nelle arti, nelle industrie e nei commerci, aveva segnato in modo speciale, come si è detto, per complesse ragioni politiche, sociali e religiose, un grave scadimento nella fede, nella disciplina ecclesiastica e nei costumi. Nelle pievi prevosti e canonici, per lo più di nobili famiglie, e investiti talora di più benefici, più non si curavano di farvi residenza e di attendere alla cura parrocchiale, e il malesempio scendeva dall'alto, mentre l'aumentata popolazione, con le esigenze portate dall'evolversi dei tempi, più non si sentiva di recarsi alla lontana plebana per le funzioni parrocchiali e per ricevere i Sacramenti.
I sacerdoti, residenti presso le chiese principali dei villaggi, a poco a poco si trovarono perciò nella necessità di operare in tutto parrocchialmente, divenendo cioè rettori ossia parroci di fatto senza che vi entrasse, fatta qualche eccezione, la legge canonica, finché il Concilio di Trento riconobbe anche giuridicamente il fatto compiuto per via di consuetudine. I rettori si chiamarono quindi parroci e di pieno diritto.
Questa, a mio avviso, l'origine delle odierne parrocchie rurali.
* * *
La nuova parrocchia rurale, si formò man mano a seconda dell'importanza dei luoghi e dei mezzi economici per il suo funzionamento. Sono alle volte gli abitanti stessi dei villaggi che vi provvedono, talora famiglie signorili od anche congregazioni monastiche, donde i diversi patronati o diritti di nomina.
La maggior parte tuttavia delle nostre parrocchie sorsero senza patronato; rimanendo di libera collazione degli arcivescovi.
Con S. Carlo e i suoi successori la parrocchia rurale venne sistemata economicamente e giuridicamente, in base ai decreti del Concilio di Trento. Nel lungo periodo anteriore, che possiamo chiamare di transizione, non c'è che povertà, confusione e disordine nelle rettoríe di campagna, per la ragione che si erano formate man mano senza norma, confusionariamente, come si rileva dagli atti di visita di S. Carlo, di Federico Borromeo, e dei loro delegati. Si amministrava il battesimo persino presso i monasteri: così a Brugora di Monte Siro, presso Besana Brianza, il cappellano battezzava i coloni del monastero di quelle monache benedettine.
Col trapasso definitivo dell'antico al moderno orientamento parrocchiale, la pieve rurale milanese cessava di esistere: rimase l'ombra di sé stessa.
* * *
Data la situazione, alla pieve si sostituì il vicariato il di cui centro residenziale continuò ad essere, per lo più, il rispettivo plebano precedente, e il titolare conservò la dignità di prevosto e di arciprete.
L'investito aveva l'obbligo di sorvegliare il clero del proprio distretto, che quasi sempre comprendeva l'antico territorio piebano; di eseguire le visite vicariali; ecc. In altre parole era un funzionario, un collaboratore esecutivo del vescovo. Tuttavia non pochi, per consuetudine, continuarono a chiamare pieve il subentrato vicariato.
Ben diversa era la giurisdizione plebana, la quale, in quanto parrocchiale, era annessa al ministero e quindi al luogo, inalterabile e continua, così che la chiesa matrice non cessava di essere tale anche se vacante; mentre la vicariale era personale e mutabile, non strettamente fissa al luogo come la plebana (344).
Al tempo di S. Carlo si ha infatti che talora funzionava da vicario qualche semplice parroco dello stesso vicariato.
Di conseguenza nei secoli successivi il territorio dei singoli vicariati non più formando un'unica parrocchia, andò più facilmente soggetto a ritocchi e a smembramenti a seconda delle necessità locali. E dallo scorcio del secolo XVIII vi concorse, sia pure indirettamente, anche il fatto che l'autorità civile nei suoi rapporti amministrativi abbandonò l'antica suddivisione territoriale ecclesiastica, e vi introdusse, con l'imperatore d'Austria Giuseppe II, i Distretti; di poi coi Francesi si ebbero i Cantoni, e di nuovo i Distretti con la seconda dominazione austriaca; e con l'Unità d'Italia i Mandamenti. Per dire solo della Brianza, è noto che S. Carlo fece trasportare l'antico centro plebano di Garlate ad Olginate, di Galliano a Cantù, di Incino a Vill'Incino-Erba, ossia da vecchie località a vicini luoghi più popolati e importanti, ma prudentemente senza operarvi alcun smembramento.
Aveva pure pensato di trasferire il centro vicariale di Agliate nel vicino borgo di Carate, ma senza venire ad una definitiva sistemazione, probabilmente per alcune difficoltà insorte. Invece il card. Gaisruk, arcivescovo di Milano, nel 1838 divise senz'altro l'antico territorio plebano di Agliate, attribuendone una parte a Besana e l'altra a Carate, ed elevando nello stesso tempo le due località a vicariato. Ma l'arcivescovo cardinal Ferrari nel 1901 volle richiamare sotto la vetusta basilica quattro parrocchie dell'antica pieve togliendone due al vicariato di Besana e altre due a quello di Carate, e vi ricostituì il vicariato di Agliate, oggi di nuovo soppresso, con quello di Besana e di Casatenovo, in base alle ultime riforme ecclesiastiche post-conciliari.
Del territorio dell'antica pieve di Pontirolo, soppressa, come si è detto, da S. Carlo con permissione pontificia, si formarono i vicariati di Trezzo, di Treviglio, e di Verdello: quest'ultimo rimase alla diocesi di Bergamo.
Nel 1787, i Vicariati di Olginate e di Brivio dovettero abbandonare quella parte a loro spettante che si trovava al di là dell'Adda in territorio bergamasco (345).
Altri distacchi ebbe a subire successivamente il vicariato di Brivio: nel 1854 la prepositura di Merate eretta nel 1842, fu elevata a vicariato, sottoponendovi parrocchie tolte in parte a quello di Brivio e a quello di Missaglia. Il cardinal Ferrari vi aggiunse di poi anche le parrocchie di Verdello Superiore e Inferiore.
Dal vicariato di Missaglia, oltre le sopraddette furono tolte nel passato le parrocchie di Rovagnate, Perego, Osnago, Cernusco, Montevecchia e aggregate a quello di Brivio, e altre ancora nel 1906 (Galgiana, Monticello, Lesmo), essendosi eretto il nuovo vicariato di Casatenovo.
Dall'ampio vicariato di Incino-Erba originarono i vicariati di Lurago d'Erba (1902), di Canzo (1907), di Alzate (1907), di Costa Masnaga (1910).
Il vicariato di Vimercate, nonostante la sua estensione, fu tra quelli ch'ebbero a soffrire minori smembramenti: vi conservò ben 22 parrocchie, delle quali alcune importanti per popolazione e industrie.
Senonché, ultimamente col Concilio Vaticano II venne sviluppandosi un vasto e grave fermento di riforme ecclesiastiche, e fra questa una nuova strutturazione dei vicariati urbani e foranei e loro titolari, con soppressione di non pochi vicariati e spostamento di parrocchie da un vicariato all'altro. Ai vicariati vennero sostituiti i decanati. Inoltre la diocesi fu suddivisa in 6 zone pastorali coi rispettivi dirigenti (346).
Altri, a suo tempo, diranno della più o meno opportunità pratica ed efficacia di queste riforme: " ex fructibus eorum cognoscetis eos ".
GIAN GIACOMO DE MEDICI
IN BRIANZA (1527-1531)
* Questo scritto venne pubblicato per la prima volta nel lontano 1916 nell' Archivio Storico Lombardo.
I
Gian Giacomo de Medici. - Suo dominio a finire della prima guerra di
Musso. - Si unisce agli alleati contro gli spagnoli fattisi padroni dello Stato di Milano. - Occupa Monguzzo. - Respinge i cesarei e invade la Brianza. - Suo governo. - Sconfitto a Carate tenta la conquista di Lecco. - Si accorda con Leyva e abbandona lo Sforza e gli alleati. - La Brianza dopo il trattato di Pioltello.
Su lo sfondo turbinoso della prima metà del cinquecento spicca la maschia figura di Gian Giacomo de Medici, detto il Medeghino o Castellano di Musso, con i suoi difetti e colle sue virtù. Dagli uni chiamato tiranno e pirata, dagli altri esaltato come un eroe. Non fu né l'una cosa né l'altra. Figlio del suo tempo, applicò per conto proprio quello che in altro campo facevano i conquistatori e loro ministri suoi contemporanei. Tempra gagliarda, intraprendente, acuta, di un'audacia senza scrupoli, volle farsi un nome illustre e crearsi un dominio, e non un dominio qualunque ma il più vasto che gli fosse possibile. I tempi gli erano propizi: lo stato milanese versava nelle ben note tristi condizioni (347).
Segnò i primi passi della sua avventurosa carriera con gravi eccessi, e si diede a sostenere la causa ducale con mirabile energia, pur avendo di mira il proprio vantaggio. Sul lago di Como, che doveva divenire il campo preferito de' suoi ardimenti e delle sue prepotenze, battagliò contro i Francesi e i Grigioni. Il narrare e il discutere quegli avvenimenti, per quanto interessanti, non entra nell'ambito limitato di questo breve studio. Basti il dire che, al finire della così detta prima guerra di Musso, egli aveva nelle sue mani il castello di Musso, le Tre Pievi, ed altre terre. In un privilegio da lui mandato ai Gravedonesi il 7 novembre del 1526 egli poteva intitolarsi " Johannes Iacobus de Medici Arcis Mussi Castellanus, Trium Plebium ac Porletiae Dominus, Lacus Comi ac Ripariae Gubernator ".
Ai Francesi, vinti nella celebre battaglia di Pavia del 24 febbraio 1525, nel dominio milanese subentrarono gli spagnoli. Per respingere i nuovi dominatori e reintegrare il duca nel suo stato, il 22 maggio 1526 a Cognac fra il papa, i Veneziani, e i Francesi si era stretta una lega: il terribile sacco di Roma compiuto dalle truppe imperiali (maggio 1527) la rinsaldò, e vi si aggiunsero i Fiorentini e gli Inglesi (348).
Il Medeghino si accostò agli alleati. Egli, che già reclutare dei soldati, offriva alla lega di far muovere subito seimila svizzeri tosto che gli fossero dati seimila ducati e si desse a quei soldati il restante della paga appena discesi nel ducato. L'offerta fu accettata (349). Egli ambiva di emergere, di segnalarsi insomma con qualche atto straordinario che gli desse maggior riputazione e potenza. Il provveditore dell'esercito veneziano informava infatti il 4 giugno 1526 che il "castellan di Musso vol 6000 homini pagati con lui et haver lui la impresa di soccorrere il castello di Milan " (350). Lo Sforza già da mesi sosteneva un duro assedio da parte degli imperiali, e Francesco Maria della Rovere duca d'Urbino, agli stipendi dei Veneziani e generale supremo degli alleati, benché avesse forze superiori al nemico non intendeva venire a battaglia fino a tanto che non gli fossero arrivati gli Svizzeri, dei quali si annunciava di giorno in giorno l'arrivo e mai giungevano perché, nota il Guicciardini, il Medici era intento a defraudare una parte del denaro mandatogli per pagare le reclute. Sui primi di luglio, pressato dai messaggi dello Sforza, il della Rovere si appressò coll'esercito a Milano, ma poi senza nulla concludere se ne ritornò a Melegnano (351). Allora per risparmiare gli scarsi viveri, il 17 luglio lo Sforza dovette far uscire dal castello nella notte le bocche inutili (donne e fanciulli), parte delle quali, passando attraverso le trincee nemiche, riuscirono a riparare a Melegnano dove narrarono la misera condizione degli assediati. Il duca d'Urbino, alcuni giorni dopo, venne coll'esercito ad accamparsi a Lambrate. Nel frattempo giunsero più di cinquemila svizzeri condotti dal Medeghino. Il 23 luglio si tenne consiglio: i capitani volevano che si assaltassero le trincee e liberare il duca, ma il della Rovere, giudicando l'impresa difficile, oppose nuovo rifiuto. Fu allora che Gian Giacomo, meravigliandosi che in tanto bisogno non si facesse che discutere, d'intesa coi capitani pontifici, propose di voler egli solo con i suoi Svizzeri soccorrere il duca, purché il campo della lega gli facesse spalla. Sdegnossi il d'Urbino a tal proposta che offendeva non poco la sua autorità, e dispose di farlo imprigionare; ma il Medeghino accortosi in tempo riparò velocemente a Musso. Intanto lo Sforza ridotto all'estremo per la fame, il giorno seguente capitolava (352). Gian Giacomo non era uomo da dimenticare facilmente gli affronti. Nel settembre avvenne che passassero per le sue terre due gentiluomini veneziani, Sebastiano Giustiniani e Francesco Lorenzo Bragadino, i quali andavano oratori alla corte francese. Li fece prendere e condurre a Musso, ne volle mai rilasciarli fino a che, dopo lunghe trattative, i Veneziani non gli avessero a sborsare cinquemila ducati per il reclutamento degli Svizzeri e altri mille e cinquecento per i quattrocento fanti che, d'intesa coi Veneziani, era stato obbligato a mantenere a difesa del lago. Ottenuto il suo intento lasciò liberi i prigionieri e mandò a far sue scuse a Venezia (353).
* * *
Il Medici si tenne in relazione col re di Francia, e il fratello Battista seppe alla corte così bene condurre le pratiche che il 12 gennaio 1527 se ne ritornava in Italia, lasciando in suo luogo un gentiluomo di sua fiducia (354). Il monarca francese veniva preparando un forte esercito, e nel giugno ottenne dalla Dieta Federale degli Svizzeri di poter arruolare diecimila uomini, i quali dovevano scendere e unirsi ai francesi che calavano dalle Alpi. L'armata, sotto il comando del Lautrec, avrebbe marciato verso Lodi dove si sarebbe riunita ai Veneti, e così di comune accordo battere gl'imperiali. Il re concesse al Medeghino un dato numero di Svizzeri e Grigioni coi quali tentare un'avanzata nel milanese.
Mentre Gian Giacomo aspettava sul lago di Como quelle truppe, composte in piccola parte di Svizzeri e nella maggiore di Luganesi, Bellinzonesi e Chiavennaschi, capitanate da Iacopo Troger e da Dietegen Salis (355), pensò di scendere dalle sterili alture del lago verso i fertili colli della Brianza, e di allargarsi al piano, creandosi in tal modo un più esteso ed utile dominio, e una buona base per le sue prossime operazioni militari. La pieve d'Incino e il Monte di Brianza non gli erano terre ignote, poiché le aveva percorse anni prima coi fuorusciti milanesi combattendo contro i Francesi (356). Pose quindi dapprima gli occhi sulla forte posizione di Castelmarte, feudo dei Missaglia, nella pieve d'Incino; ma poi trovò più confacente ai suoi disegni il non lontano castello di Monguzzo, già ridotto a mediocre fortezza e dominante un più largo orizzonte.
Monguzzo, così si esprime il Missaglia, da un lato scopre la pieve d'Incino, dall'altro il Monte di Brianza, e da sud le spaziose campagne di Giussano, Carate ed altre buone terre delle più piacevoli e fertili parti che abbia il ducato di Milano (357). Noti il lettore che l'espressione " Monte di Brianza " va presa, come è evidente dal contesto, nel senso di circoscrizione territoriale, e non del monte o colle propriamente detto. La plaga collinosa così denominata si stendeva tra l'Adda e il Lambro; e il Ripamonti osserva per l'appunto che Monguzzo stava sul confine tra gli Orobii e i Briantei (358).
Il castello, situato sulla cima del colle, era tenuto in feudo da Alessandro Bentivoglio (359). Gian Giacomo, secondo il Giovio, il Guicciardini e il Capella (360), se ne impadronì con inganno; ma, stando al Missaglia, l'occupazione non mancò di una certa qual legalità. Ci narra infatti che, con lettere e raccomandazioni d'amici, fece intendere al duca come il Bentivoglio custodisse fiaccamente la rocca, e che se a lui invece la concedesse avrebbe saputo assicurare quella parte del ducato dalle incursioni dei nemici e tenere a segno la fortezza di Lecco. E quanto diceva il Medeghino era vero: il Bentivoglio, alieno dalle armi, se ne stava colà riparato con altri gentiluomini milanesi, mentre i nemici scorazzavano pel Monte di Brianza saccheggiando (361).
Lo Sforza, il quale reso il castello di Milano si era ritirato a Lodi, benché non si fidasse troppo del Medeghino, riconobbe buone quelle ragioni e, dubitando di peggio, scrisse al Bentivoglio di rimettere il luogo nelle mani del Medici. Le lettere furono consegnate allo stesso Medeghino perché le presentasse al destinatario. Gian Giacomo, ben conoscendo che questi non avrebbe ceduto tanto facilmente, e dubitando inoltre che se avesse mandato proteste al duca, giacché godeva di molta autorità presso di lui, fosse per riuscir vano il suo disegno, senza por tempo di mezzo con una grossa mano d'armati scalò nottetempo il castello. Il Bentivoglio, di fronte alle lettere del duca e più ancora davanti alla forza, dovette cedere e uscire co' suoi (362). Il racconto del Missaglia ci sembra verosimile, perché se il Medici, pure combattendo per la causa ducale, era uomo da usare qualsiasi mezzo pure di raggiungere il suo fine, tuttavia non avrebbe certamente osato urtare brutalmente lo Sforza col rapire il castello al Bentivoglio, parente del duca e dallo stesso pochi mesi prima lodato e beneficato per la sua fedeltà, senza aver prima, almeno in apparenza, tentato procedimenti più onesti (363).
L'occupazione sarebbe avvenuta nel mese di giugno del 1527, e probabilmente verso la fine di quel mese (364).
Al Leyva, successo al Pescara nel comando dell'esercito spagnolo in Lombardia, non garbò affatto tal cosa: da Milano e da Como spedì truppe con artiglieria agli ordini del conte Lodovico Belgioioso onde prendere a viva forza il castello (365). Il Medici non si lasciò sorprendere: approfittando della lentezza del nemico rafforzò le difese e il presidio, ottenendo dai Veneziani un aiuto di cinquanta stradioti, venti uomini d'arme, e centocinquanta archibugieri (366).
Il Belgioioso, verso la metà di luglio, tentò vari assalti ma fu respinto e costretto a ritirarsi colla perdita di più di cento soldati e quattro cannoni. Al campo veneziano era giunta la nuova, certamente esagerata, che il Belgioioso vi avesse perduti ben quattrocento uomini (367). Lasciato quindi nel castello il fratello Battista, Gian Giacomo, (scrive il Missaglia) con una eletta banda di fanti italiani invase la Brianza, la sbarazzò dai nemici, osando persino assalire i castelli di Brivio e di Trezzo presidiati dagli spagnoli. In quel tempo premeva al Medeghino di ingrossare le sue truppe, ma per sostenerle occorreva il denaro. Che fa egli? Obbliga le comunità a forti contributi, taglieggiandole senza misericordia, e sopra tali contribuzioni erige un rigido magistrato, eleggendovi a suo commissario Martino da Mondonico. Aggiunge il Ripamonti che, facendola quasi da sovrano, vi organizzò tribunali e carceri, innalzando dei pubblici patiboli a salutare timore in diversi luoghi, e costringendo molti giovani paesani ad incorporarsi fra i suoi soldati facendoli istruire dai veterani. Dei ricchi brianzoli quelli che non riconosceva atti ad alcun suo servizio li faceva imprigionare e tradurre a Monguzzo, dove con l'asprezza dei tormenti li costringeva a pagare grosse somme di denaro. A coloro invece che si dichiaravano suoi seguaci, ed erano per riuscirgli di qualche utilità, non solo lasciava loro il dominio delle torri e castelluzzi che possedevano, e ciò a minor sua spesa, ma li soccorreva quando erano travagliati dal nemico (368).
Non conosco altre fonti colle quali poter meglio precisare sia riguardo al tempo che al modo, quanto affermano in modo troppo generico i due storici sul regime del Medici in Brianza. Ritengo tuttavia opportuno di osservare che Gian Giacomo col trattato di Pioltello del 31 marzo 1528 ebbe in suo riconosciuto dominio, nelle nostre parti, soltanto la Vallassina, la corte di Casale, la pieve d'Incino, le squadre dei Mauri e di Nibionno, e Valmadrera. Centro di questi possessi era Monguzzo, dove ordinariamente risiedeva Battista che vi governava in nome del fratello. Nei sotterranei del castello stavano orride carceri, ma che vi fosse anche un tribunale non ho trovato (369).
Riguardo ai gentiluomini imprigionati e obbligati a riscattarsi con denaro, il Bombognini ricorda un Guido da Sirtori, il quale, condotto a Monguzzo, per riavere la libertà dovette sborsare 7271 lire: l'autore non dice quando, ma soggiunge che fu imprigionato per la sua fedeltà al duca. Questo lascia supporre che sia avvenuto dopo che il Medici ebbe ad abbandonare lo Sforza. Ci rammenta inoltre il Bombognini la nobile famiglia Riboldi di Besana molto danneggiata dalle rappresaglie del Medeghino (370). Sappiamo ancora che il prevosto d'Incino, Gio. Francesco Parravicini, e suo fratello si videro tolti i beni paterni, e il prevosto anche quelli ecclesiastici: beni che godeva il capitano Pellizzoni (371). Il milanese Gerolamo Carcano, fatto prigioniero nel 1526, mentre navigava alla volta della Valtellina, e condotto a Musso, fu costretto a redimersi con quattromila scudi. Lo Sforza lo risarcì nel 1531 con beni confiscati al Medeghino, e nell'atto si dice appunto che il Medici
" istud idem contra multos alios nostros subditos fecisse " (372). E di quali tormenti fosse capace il castellano di Musso verso questi malcapitati ce lo prova questo fatto. Nell'ottobre del 1523 aveva mandato Gasparino da Malgrate con una buona mano d'armati a Cava in Valsanmartino a fare prigioniero Stefano da Birago, uomo molto ricco. Quel disgraziato fu preso infatti sulla pubblica piazza del paese, spogliato de' suoi denari, gioie, collane, braccialetti che sempre portava indosso, perché " non se confidebat in aliquo nec in propriis filiis ", e tradotto a Musso. Quivi il Medeghino gli mise " testiculos in vinculis " e lo tormentò, e così per tre mesi, fino a tanto ch'ebbe a soddisfare ad una taglia di mille e seicento scudi (373).
Comunque, ben grama doveva essere la condizione dei brianzoli, perché se per un verso avevano sul collo il Medici e i suoi scherani, dall'altro non mancavano, appena lo potevano, di venire nelle nostre terre le soldatesche del Leyva a far bottino. Compivano l'opera i ladri e gli assassini di strada numerosi assai in quegli anni turbinosi e di miseria (374).
E col Medici non c'era da scherzare. Se egli sapeva accarezzare ed aiutare quei che si mostravano a lui fedeli, dall'altra era inflessibile coi traditori. Narra il Missaglia che il Leyva, andatagli a male la spedizione del Belgioioso, considerando il pericolo nel vedersi tagliate dal Medeghino e dai suoi partigiani le comunicazioni tra Milano e Lecco, pensò di danneggiarlo con altri mezzi. Con doni e promesse riuscì a trarre dalla sua il Mondonico e lo indusse a tradire coll'occupare il castello di Perego, tenuto da un fervente partigiano del Medici (375). Il castello, con grosse mura e due torri senza fossato le cui vestigia si vedono tuttora, era situato in una eccellente posizione strategica, dominando la valle di Rovagnate la quale da un lato si spinge per Monticello verso l'Adda, e dall'altro per Dolzago ad Oggiono. Il Mondonico fece legare, come fossero dei malfattori, alcuni suoi, e si presentò a sera tardi al castello, pregando il padrone che gli lasciasse custodire quei prigionieri presi per ordine del Medici. Il castellano, ch'era suo amico, annuì nulla sospettando di male. Senonché il Mondonico, fatti slegare nella notte i suoi, s'impadronì del castello scoprendosi partigiano del Leyva. Gian Giacomo, udita la cosa, spedì immediatamente il suo valoroso e fidato Pellizzoni (376) con truppe a ricuperare quel luogo. Eseguite di notte alcune imboscate all'intorno, fu ripreso il castello e il Mondonico coi suoi condotto a Monguzzo: il Mondonico, dopo avere fra i tormenti palesate le intese col Leyva, fu crudelmente fatto morire arrotandolo vivo; gli altri furono impiccati (377).
Il Ripamonti, per mostrarci di qual tempra fosse il Medeghino, ci narra un altro fatto. Due preti erano venuti meno ad un suo divieto. Furono presi e condotti dinnanzi a lui a Monguzzo. Gian Giacomo fece loro assaporare le terribili sensazioni di una morte crudele e imminente, quindi li lasciò liberi colla raccomandazione di non trasgredire un'altra volta ai suoi ordini (378). Scrive lo storico di averlo udito narrare quand'era fanciullo da un vecchio de' suoi monti, il quale diceva di esser stato presente a quella scena. Mi nasce però il dubbio che si tratti, più che di un fatto realmente accaduto, di una storiella popolare per quanto consona al carattere dell'uomo. Di leggende o dicerie popolari devono certamente esserne formate intorno al castellano di Musso, il quale colle sue gesta colpì l'immaginazione dei contemporanei. Tuttavia che nemmeno ai preti la menasse buona, quando osavano venirgli meno, ce lo prova l'aver fatto pubblicamente impiccare a Lecco nel 1531, senza tanti complimenti, il sacerdote Angelo " de Torno ", accusato di tradimento (379).
* * *
Verso la fine di luglio del 1527 gli arrivarono a. Monguzzo, dal lago di Como, gli Svizzeri e i Grigioni: li alloggiò nei paesi circonvicini, e cento ne collocò nel monastero delle monache di Lambrugo, le quali a loro spese dovettero mantenerli per quattro giorni. Mancavano ancora quei di Svitto e di Glarona che si trovavano in cammino; ma al Medeghino urgeva di far presto per riuscire nel suo piano di sorpresa. Riunì pertanto alle sue bande le truppe che aveva sottomano, e con una forza di oltre tremila fanti, venne ad accamparsi a Carate col proposito, fattosi giorno, di passare oltre (380).
Obiettivo immediato del Medici era per il momento la presa di Monza, ritenuta in quei tempi la chiave del Monte di Brianza. I Veneziani, fatti consapevoli di quella mossa, gli avevano offerto in aiuto le fanterie che tenevano sul bergamasco, ma egli le rifiutò (381). Evidentemente voleva operare colle sole sue forze nella speranza forse di poter fare sua quella città se l'impresa gli riusciva (382). Era nei piani di Gian Giacomo, se tutto gli andava bene, di spingersi fino a Milano, nella quale aveva segrete intelligenze, prima che vi ritornasse il Leyva. Inoltre non aveva mancato di lasciare Monguzzo ben fortificato perché in tutti i casi gli servisse di un sicuro e vicino appoggio.
|
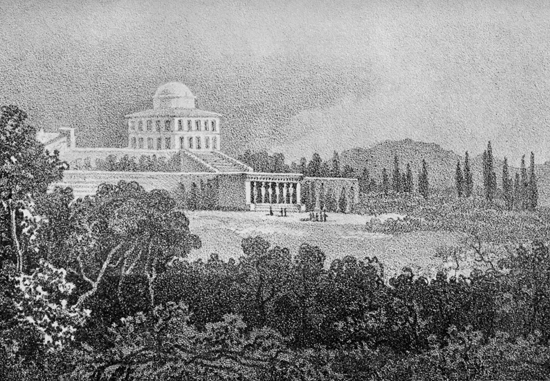
|
|
|
La Rotonda di Inverigo progettata dall'architetto Cagnola
(da: ;Lombardia pittoresca, Milano, Stella e figli, 1836, litografia su disegno di Elena).
|
|
|
|
|
Il Leyva, benché si trovasse a Melegnano a fronteggiare l'esercito della lega, conosciute per mezzo di spie le intenzioni del Medeghino, decise di assalirlo improvvisamente. Il 29 luglio ritornò a Milano col suo esercito, ed " el dì seguente, overo la nocte ", come si esprime il Burigozzo, con tutta segretezza, non lasciando che duecento uomini alla custodia della città, se ne venne a Monza e di là mosse verso Carate dove giunse sul far dell'alba (383). Una sentinella del Medici, la quale vegliava sul campanile della chiesa, avendo scorto l'avanzarsi di una grande continuata bianchezza (384), corse a darne avviso al Medeghino, il quale comprese subito quanto stava per accadere, per quanto ritenesse di non avere a che fare con tutto l'esercito nemico. Senza lasciarsi turbare dalla sorpresa, ordinò ai suoi archibugieri Italiani di opporre nel borgo una strenua difesa, e con carri fece barricare dai contadini le vie di entrata; agli Svizzeri e ai Grigioni, che stavano gozzovigliando nelle case senza alcuna vigilanza di sentinelle, ingiunse di portarsi lestamente sulla Costa d'Agliate (ora Costa Lambro), così che il nemico, volendo transitare il Lambro e salire l'erta, sarebbe stato facilmente assalito e sconfitto. Senonché, diffidenti del Medici, vollero invece disporsi in salda ordinanza sulle rive del fiume, scrive il Missaglia, o forse meglio in un pianoro alquanto sotto Carate, come vogliono il Guicciardini e il Capella. Tenendo calcolo dei particolari dei cronisti, crediamo di poter identificare il posto di schieramento nel pianoro che si stende sulla riva del Lambro tra le attuali strade, esistenti fin d'allora, le quali scendono da Carate l'una verso Realdino e l'altra verso Agliate. Il pianoro è dominato dalla parte di Carate da un ciglione piuttosto ripido tuttora coperto di piante e di cespugli. Gli Svizzeri e i Grigioni devono essersi verosimilmente collocati nei pressi di Realdino (385). Non tardò ad ingaggiarsi la battaglia. Il Leyva, che si avanzava sulla strada d'Albiate, conosciute le posizioni del nemico, diede ordine agli Italiani del Belgioioso e del Maggi di tenere a sinistra e di respingere i soldati del Medeghino serragliati nel borgo, e agli Spagnuoli fece tenere la destra per venire ad attaccare gli Svizzeri ed i Grigioni. Costoro si videro ben presto bersagliati dall'alto dalle archibugiate dei nemici: non un colpo andava a vuoto. Furenti imboccarono allora la strada e mossero verso Carate. Gli spagnoli con gran prestezza barricarono con carri la via e dietro i ripari continuarono a sparare su di loro, ma gli Svizzeri e i Grigioni che assalivano con l'usata tenacia e valore, riuscirono a farli piegare. Mossero in soccorso dei fuggenti le truppe del Maggi e del Belgioioso e la battaglia divampò ancora accanita, rimanendo ferito in un fianco il Maggi stesso. L'esito dello scontro era ancora incerto, quando il Leyva, che nel frattempo aveva respinti fuori del borgo e messo in fuga i soldati del Medici, sopraggiunse coi Lanzichenecchi comandati dal valoroso Frundsberg (386). Gli Svizzeri e i Grigioni, dei quali molti erano già caduti morti o feriti, di fronte a forze forse superiori, si diedero alla fuga (387). Il Medeghino appena si accorse che la partita era perduta si salvò in groppa ad un rapido cavallo, e, secondo il Reissner, senza informarne gli Svizzeri e i Grigioni (388). Giunta a Milano la nuova della vittoria furono suonate le campane a festa e dal castello si fecero spari d'artiglieria (31luglio) (389). Lo Sforza con lettera da Lodi del 1° agosto informava il podestà di Crema che le truppe del Medeghino, assalite da due parti, erano rimaste sconfitte (390).
La causa della rotta la si volle trovare non solo nella insubordinazione degli Svizzeri e dei Grigioni, che non vollero attenersi alle disposizioni del Medici, ma altresì nel fatto che costoro invece di rimanere vigilanti se ne stavano bivaccando fra il vino e i giuochi d'azzardo (391). Tuttavia è lecito dubitare di una vittoria, quand'anche non si fossero verificati tali atti di indisciplina, allorché si pensi che il Leyva, tra i più capaci condottieri del suo tempo, aveva seco truppe sperimentate e deciso non solo a battere il Medici, ma ad averlo, se possibile, nelle sue mani, come risulta da informazioni veneziane.
Il Leyva, il quale d'altra parte doveva tener testa all'esercito della lega, non credette opportuno l'inseguimento, e ritornò a Milano. Conservò pertanto il Medici non solo i suoi possessi, ma, come asserisce il Giovio, da Monguzzo corse ad occupare Cantù, facendo scorrerie nel territorio comasco (392). Questa occupazione, non fu, per altro, di lunga durata, come ce lo provano i successivi avvenimenti. Che parimenti Gian Giacomo ritenesse Carate e ne presidiasse il castello lo afferma pure il Giovio: il Tatti e il Pagani lo seguirono, ma nessun cenno ne abbiamo in altre fonti o memorie locali (393). Osserverò invece che l'aver trovato fra i seguaci del Medeghino, graziati l'anno appresso, un frate Alessandro prevosto di Carate (è noto che quivi esisteva un'antica prepositura degli Umiliati soppressa poi nel 1571 con tutto l'Ordine) mi fa ritenere che quel prevosto sia fuggito, a battaglia perduta, per evitare da parte del Leyva rappresaglie per aver aiutato il castellano di Musso.
* * *
Gian Giacomo, trovandosi più sicuro fra le regioni montane, lasciò un presidio col fratello Battista in Monguzzo e ritornò a far campo delle sue imprese il lago di Como. Della patita sconfitta pensò di rifarsi colla conquista di Lecco, feudo del Morone, e presidiata per gli Spagnuoli da Lucio Brisighelli con una banda di crudeli ma valorosi calabresi (394). Fatti i debiti preparativi, il 27 ottobre, dopo aver occupato Olginate, si portò sotto Lecco, prese il ponte, e quindi la strinse di assedio con circa seicento fanti, mentre sul lago la sua flotta, rendeva impossibile agli Spagnuoli, ch'erano in Como, di poter navigare in soccorso (395). Era divisamento del Medici di prendere Lecco per fame. Il Brisighelli infatti, venendo a difettare di viveri e vedendo assottigliarsi il presidio per malattie, si trovò costretto a mandare al Leyva il Caravacca per aiuti. Il Medeghino s'intese tosto coi Veneziani perché l'avessero ad aiutare nella difficile impresa, e verso la metà di dicembre gli arrivavano truppe veneziane con pezzi di artiglieria. Urgeva far presto, prima che potessero giungere soccorsi al nemico. Le operazioni d'assedio vennero spinte con grande energia: mentre tutti i passi erano ben guardati e difesi, i Veneti dal lato di terra e la flotta del Medici dal lago presero a bombardare furiosamente la fortezza. Il presidio però si difendeva valorosamente. Intanto da Monza in soccorso del Brisighelli arrivavano ad Oggiono, luogo tenuto dal Medeghino, mille e duecento tra Spagnuoli e Lanzichenecchi con due pezzi d'artiglieria, due stendardi d'uomini d'arme, e cento cavalleggeri; si diressero a Malgrate trasportandovi su di un carro una barca. Era con essi il Caravacca, abilissimo nel trovare modo di disimpegnarsi nei casi più difficili. In un luogo adatto e meno custodito si mise in acqua la barca, vi entrarono cinque o sei soldati, e si attraversò il lago approdando a Lecco, dove il Brisighelli teneva pronto un brigantino armato. Con tutta prestezza, protetti dalle artiglierie del forte, con quei due legni si riuscì in più volte a introdurvi circa cento archibugieri, dieci o dodici buoi morti, farina, sale, e polvere. I cesarei, dopo esser rimasti due giorni a Malgrate, per la via di Olginate e Cernusco, paesi occupati dal Medici, ritornarono a Milano. I Veneti per altro sospettarono che Gian Giacomo avesse permesso l'entrata di quel soccorso per vendicarsi del duca, il quale preferiva veder Lecco in mano degli spagnoli piuttosto che nelle sue; e la cosa non pare verosimile poiché il Medeghino non avrebbe poi continuato nell'assedio. Il soccorso poté penetrare di sorpresa per un piano già ben preordinato dal Caravacca col comandante del presidio (396). Vero è che al duca premeva più che altro di ricuperare la città di Milano e di tener testa all'esercito del Leyva, il quale si era portato in Lomellina col proposito di occupare Novara, Montana e Vigevano. D'altra parte comprendeva che Lecco, una volta occupata dal Medici, era per lui perduta. Di qui la ragione per cui instava presso gli alleati di non perdere d'occhio il più importante. Comunque sia, la Repubblica di Venezia fece ritirare le sue truppe coll'artiglieria; Gian Giacomo continuò da solo l'assedio, e ad impedire l'entrata in Lecco di qualsiasi barca cinse tutto all'intorno il lago con borelli e catene (397).
Il Brisighelli, di lì a non molto, si trovò nella necessità di invocare dal Leyva nuovo soccorso. Il 9 febbraio 1528 uscirono da Milano verso Monguzzo un migliaio circa di fanti con due falconetti sotto il comando di Pietro Birago: correva voce che si volesse assalire quel castello per obbligare il Medici a ritirarsi dall'assedio di Lecco: ma eran forse dicerie. Monguzzo era ben presidiato e fortificato, e i cesarei non potevano aver dimenticato la lezione avuta l'anno prima: per raggiungere lo scopo ci volevano ben altre forze. D'altra parte il Medeghino aveva ottenuto dai Veneziani quattro cannoni e un rinforzo di cinquecento fanti che vennero a collocarsi a Villadadda pronti a marciare, secondo il bisogno, agli ordini del Medici. Gli imperiali infatti si guardarono dall'attaccare Monguzzo, ma girando al largo occuparono Cantù, dove vi lasciarono ottanta fanti di presidio, e il 16 febbraio, dopo aver alloggiato a Giussano, si spinsero verso il Monte di Brianza. Per dove passavano, e specialmente nei possessi del Medici, tutto veniva saccheggiato. Vista l'impossibilità di accostarsi a Lecco, dietro ordine del Belgioioso e del Leyva, quelle truppe ritornarono al di qua del Lambro, e giorni dopo andarono a ricongiungersi colle genti del Torniello e di altri capitani che il Leyva aveva richiamate dalla Lomellina, e che sul finire di febbraio mandava in aiuto di Lecco, ormai agli estremi (398). Si trattava, complessivamente, di una forza di tremila fanti, quattrocento cavalli, e quattro pezzi d'artiglieria (399). Il Leyva col rimanente dell'esercito andò ad accamparsi a Pioltello, facendo spargere la voce di voler tentare qualche fazione sul bergamasco onde impedire ai Veneti di inviare i necessari aiuti al Medici. Gian Giacomo non si intimorì: domandò ed ebbe nuovi soccorsi di truppe dai Veneziani, e ingiunse, narra il Missaglia, ai signorotti brianzoli suoi dipendenti di tormentare colla guerriglia il nemico che si avanzava attraverso la Brianza. Per mantenere libere le retrovie con Monza, già esposte alle scorrerie dei Veneziani che custodivano la riva bergamasca dell'Adda, si dovette infatti con perditempo espugnare torri e castelli: tra i più tenaci nella lotta fu il castellano di Perego (400).
Sui primi di marzo gli imperiali giunsero ad Olginate: il presidio di Lecco tentò allora una sortita ma fu respinto dal Medici; egual sorte toccò alla flotta comasca venuta contemporaneamente in soccorso. Espugnata la torre di Olginate, valorosamente difesa, con una ventina di soldati da Antonio Maria Negro cugino di Gian Giacomo, e tenendo a bada con finte mosse i Veneti trincerati di fronte sull'altra sponda dell'Adda, riuscirono qualche giorno dopo a passare poco sotto il fiume. Il primo a sbarcare sarebbe stato il capitano Cesare Maggi co' suoi. Una compagnia di Veneziani, comandata dal conte Ercole Rangoni, che custodiva quel passo fuggì senza opporre resistenza: accorsero gli altri capitani veneti coi loro soldati, ma gli imperiali, che vi si erano tosto saldamente stabiliti, li respinsero spingendosi a conquistare le stesse trincee nemiche (401).
Il Medici, sdegnato, dal ponte di Lecco il 10 marzo scriveva al Moro, provveditore generale veneziano, ch'egli non poteva fare l'impossibile, e cioè attendere a " Lecco et la Riviera fino a la Chiusa, così la Chiusa et li monti "; gli si mandassero seicento soldati scelti ai suoi comandi, per difendere quei luoghi, fino a tanto che si prendesse Lecco, la di cui resa era inevitabile entro il mese, diversamente egli era costretto, benché di mala voglia, ad accettare i vantaggiosi patti che il Leyva gli offriva con insistenza (402). Che anzi la vittoria poteva dirsi certa se coi soldati gli fosse mandato il conte di Caiazzo. Sollecitava quindi pronta risposta perché delle possibili conseguenze egli voleva " esser excusato con tutto el mondo ". Rispose il Moro il dì seguente dolendosi dell'accaduto, e promettendo che avrebbe mandato gli uomini richiesti, dei quali quattrocento alla Chiusa e duecento sopra " il monte per custodia et defension di quel passo ", pronto a mandangliene di più qualora ve ne fosse bisogno, e che inoltre, gli avrebbe spediti i denari domandati per le paghe (403).
I cesarei, dopo di avere inutilmente tentato di passare per i luoghi fortificati e presidiati dal Medici, fecero salire in ricognizione a Carenno un grosso corpo di truppe per vedere, se fosse possibile, girando la Chiusa, di trovare qualche passo per discendere a Lecco. Saccheggiarono quel luogo e i dintorni, e col bottino e i prigionieri fatti ridiscesero a Calolzio dove, attaccati dal Medeghino, ripassarono ad Olginate perdendovi quasi tutta la preda fatta (404). Il 14 dalla Chiusa il Medici informava il provveditore generale veneto che il nemico era ancora fermo a Olginate e a Garlate, ma che gli erano giunti in aiuto altri trecento Spagnuoli; richiedeva pertanto altri cento fanti non essendone arrivati che trecento, e l'invio di un'altra compagnia sulla montagna in rinforzo a quella del Cagnola, sollecitando inoltre il denaro per le paghe (405). Carenno veniva perciò il dì seguente di nuovo fortificato e si accrebbe il presidio coi soldati di Guido Naldo: Gian Giacomo aveva promesso che, qualora i nemici ritentassero la via di Carenno, egli sarebbe accorso in aiuto con le sue forze (406). Se non che i nemici, data la stagione ancor invernale e i luoghi senza risorse, giacché gli scarsi viveri venivano sulle retrovie di Monza per lo più intercettati da una parte da Battista Medici che uscito da Monguzzo aveva nel frattempo rioccupati i castelli presi dai cesarei, e dall'altra dal conte di Caiazzo che irrompeva dal bergamasco co' suoi cavalleggeri, non potevano più a lungo durarla. Il 17 in grandi forze ripassarono l'Adda e risalirono a Carenno, mentre il resto delle truppe coll'artiglieria si recava a bombardare il ponte di Lecco così da tenere impegnato il Medici coi suoi. I veneti del Cagnola e del Naldo all'appressarsi del nemico, invece di opporre una tenace resistenza, fuggirono vilmente verso Bergamo (407). Da Carenno, pel passo del Pertugio, scrivono il Grumello e il Missaglia, i cesarei percorrendo un aspro e difficile sentiero coperto di neve, che veniva spianato dai guastatori, poterono discendere indisturbati verso Lecco (408). Quando il Medici seppe che il nemico aveva superato quel passo, ritenendo vana ogni ulteriore resistenza, ritirò i suoi dalla Chiusa, li imbarcò sulla flotta, e si appostò a Mandello: i quattro pezzi che i Veneziani gli avevano imprestati li fece trasportare a Musso (19 marzo 1328) (409).
Non è a dire quanto Gian Giacomo rimanesse sdegnato nel vedersi sfuggire una preda che già stava per cadergli nelle mani. Sospettò che i Veneziani non avessero opposto che una debole resistenza per far piacere al duca, il quale, come si è detto, preferiva veder Lecco in mano degli Spagnoli che non nelle sue. Dal Sanudo e dal Missaglia risulta vero questo sentimento dello Sforza (410), ma non così si può affermare dei Veneti i quali non mancarono di fargli giungere aiuti di gente e di denaro, per quanto preoccupati della difesa del bergamasco. La poco o nessuna difesa fatta dalle truppe venete la si deve alla viltà di quei mercenari e alla discordia fra i loro capitani (411). Comunque sia, il Medici non volle uscire da quell'impresa a mani vuote, e pensò di ottenere per via di accordi quello che non poté colle armi, tanto più che correva voce che i cesarei sarebbero poi venuti contro Monguzzo. Riannodò le trattative, lasciate in sospeso, col Leyva, e, nonostante le insistenze dei Veneziani perché non li avesse ad abbandonare, il 31 marzo 1528 venivano in Pioltello conclusi i patti o capitoli fra le parti (412), i quali se erano vantaggiosi al Medici non lo erano meno pel Leyva che veniva a liberarsi di un turbolento nemico e ad avere il mezzo di ottenere non solo, sia pure dietro pagamento, i viveri dei quali grandemente difettava, e cioè tre mila sacchi di grano e due mila some di sale, ma ancora trentamila scudi come nota il Guicciardini (413).
Le trattative non seguirono per altro, così facili, come parrebbe: il Medeghino non smentiva mai sé stesso, e non intendeva di accettare patti meno che vantaggiosi, quasi fosse un vinto. Mentre si discuteva in Pioltello, il 29 marzo la sua armata, composta di nove grossi legni e di otto brigantini, si incontrò con quattro grandi barche comasche nelle quali vi era il Belgioioso con circa trecento fanti. Venuti alle mani, il Medeghino le bombardò affondandone una, e costringendo una seconda a riparare alla riva; le altre due col Belgioioso fuggirono a Como. Ciò fatto si rivolse contro un vicino paese del lago dove alloggiavano Spagnoli e Lanzichenecchi; fu in quel mentre che gli giunse da Como un brigantino con lettere nelle quali si diceva che l'accordo era stato firmato (414). Da quel giorno si voltò contro lo Sforza e la Lega, abbracciando la causa di Carlo V (415).
In base all'accordo fatto, il Leyva con diploma del 13 aprile, premesso un grande elogio delle virtù militari del Medici, gli riconosceva in libero possesso, col titolo di marchese, il castello di Musso, la torre di Olonio, il lago (escluso il circondario di dieci miglia intorno alla città di Como), la valle d'Intelvi, Osteno, la Valsolda, il contado di Porlezza, Menaggio e la valle Arzonica, le Tre Pievi, il lago sopra la Riviera, la Valsassina, Valmadrera, Monguzzo, la pieve d'Incino, la Corte di Casale, la Vallassina, e le squadre dei Mauri e di Nibionno (416). I territori venivano concessi a lui e discendenti, distaccati completamente dallo Stato di Milano, salva sempre la supremazia imperiale, con mero e misto imperio, con ogni potestà e giurisdizione, e con tutti i dazi delle mercanzie, ferrarizie, sale, tratta dei gualdi, gabelle, e pedaggi. Gli concedeva inoltre il diritto di battere monete d'ogni sorta colla propria immagine e con quei segni che a lui piacessero, purché equivalenti a quelle della zecca di Milano, da coniarsi tanto a Musso quanto in altro luogo di sua giurisdizione, così che potessero aver corso nello stato di Milano né i sudditi respingerle. Revocò quindi qualsiasi decreto, e nominatamente quelli del 1423 e 1490, che venisse ad opporsi a tali concessioni (417). Gli concedeva inoltre il borgo di Lecco col castello, il ponte, e l'annesso territorio alle stesse condizioni (418).
Con questi diplomi veniva ad essere danneggiato il Fisco, e col primo anche i diritti che Clara Sforza vantava sulla pieve d'Incino e Vallassina, già altra volta a lei riconosciuti dal Senato, ed altri ancora sul castello di Monguzzo e nella squadra dei Mauri e di Nibionno eccettuata la corte di Casale per la quale aveva avuto in cambio le terre di Mandello, Varenna e Bellano. Il Senato, vigile custode del diritto pubblico e privato, non mancò di far osservare al Leyva che non era giusto privare la camera dei dazi ordinari, che venissero danneggiati i terzi senza equa ricompensa, che i luoghi fossero donati liberamente senza titolo e obbligo di feudo, e che, dopo tutto, i diplomi non erano sottoscritti dal gran cancelliere dello stato di Milano. Con lettera del 24 maggio il Leyva rispondeva che si dovessero interinare com'egli aveva decretato, nonostante qualsiasi legge in contrario, e che riguardo ai terzi, comparendo, non avrebbe mancato di dar loro l'equivalente (419). Ma il Senato tenne duro e li interinò secondo il diritto vigente, e non secondo i criteri del generale spagnolo. Questi il 6 agosto si lamentò fortemente col Senato, dichiarando che i territori erano stati concessi non come feudo ma in libero possesso; che si togliesse il decreto del maggior magistrato giacché nobili o meno tutti dovevano sottostare alla giurisdizione del Medici; e che i dazi concessi il Medici li godeva del resto già da tempo: essere pertanto, nonostante tutto, sua " enexa et indubitata voluntà " che i suoi diplomi avessero senz'altro vigore (420).
|

|
|
|
Processione ad Oggiono, disegno della fine dell'Ottocento. (Collezione privata, Mariano Comense).
|
|
|
|
|
Con un terzo diploma del 17 maggio venivano graziati i fratelli di Gian Giacomo e i suoi seguaci sia gentiluomini che soldati, liberandoli da ogni bando, crimine, delitto, e imputazione, e ripristinandoli nello stato di prima coi loro beni, gradi e onori. I graziati nel termine di un mese dovevano personalmente presentarsi a prestare il giuramento di fedeltà, diversamente la grazia era nulla (421). In merito ho trovato interinazioni fatte dal Senato nel mese di giugno in favore di Azzone Visconti, Francesco e Lodovico Pusterla, Gio. Francesco Castiglioni " dicto el lozo ", Giorgio Lanizario, Lodovico e fratelli Lambertenghi, Bartolomeo del Conte, Nicolao Mugiasca, Giuseppe Besozzo, Gio. Simone Crivelli, Andrea e Palamede Carpani, e Lodovico Giocario.
Scrive il Galantino che " gli atti rogati dai notai nei possessi da lui posseduti furono intestati col suo nome, e colla formula dominante, e inoltre coi titoli attribuitigli dalla convenzione di Pioltello, di marchese di Musso, conte di Lecco (incisi di poi sulle sue monete) e la qualifica di signore totius Laci Comi et Montis Briantie " (422). Per quello che riguarda la qualifica di signore del Monte di Brianza non saprei spiegarmi come in realtà gli potesse competere tal titolo dal momento che dai capitoli di Pioltello, dai diplomi del Leyva, e da altri documenti risulta chiaro che il territorio propriamente detto del Monte di Brianza ed il Canturino vennero esclusi dalle terre riconosciute di dominio del Medici (423).
* * *
La pace conchiusa tra Gian Giacomo e il Leyva non migliorò affatto le misere condizioni dei brianzuoli. Il 1527 era stata un'annata delle più calamitose per le angherie commesse nel gennaio e febbraio dalle truppe del Belgioioso (424), per la calata del Medici, per le soldatesche amiche o nemiche le quali, per dove passavano o stanziavano, commettevano ogni sorta di vessazioni, per le scorrerie che di tanto in tanto facevano i Veneziani dal bergamasco, e per le requisizioni del mese di ottobre da parte degli Spagnoli che avevano tolte dal Monte di Brianza tutte " le vittuarie " che poterono trovare per trasportarle a Milano: in città si moriva quasi di fame. Ma non meno grande era la carestia nel contado (425). Nel dicembre e nei tre mesi seguenti del 1528 si ebbero altri movimenti di truppe attraverso la Brianza con saccheggi e requisizioni (426). Si credette che l'accordo di Pioltello avesse a volgere in meglio le cose, ma non fu che una vana e breve illusione, poiché il Medeghino si diede tosto a sequestrare violentemente grano e denaro. Narra il Giovio che il Medici col consenso del Leyva, faceva spogliare dal Borsieri i campagnoli comaschi del loro grano aggravandoli per sopra più di continui balzelli: quei che indugiavano o ricusavano faceva imprigionare, distruggere le loro case, condur via i buoi mentre aravano sì che il raccolto in quell'anno fu meno che la decima parte. Altrettanto facevano altri bravacci provenienti da Monguzzo (427).
Ora se questo avveniva nel territorio comasco, ben possiamo immaginare quello che accadeva altresì nel Monte di Brianza. Il 29 aprile il Fregoso, veneziano, informava che il castellano di Musso richiedeva " a brianceschi alloggiamento per 2000 fanti, over far page per esse " (428), e contemporaneamente toglieva loro anche il grano, poiché alcuni giorni dopo (3 maggio) il Moro, provveditore generale veneziano, da Cassano avvertiva ch'erano usciti verso Monguzzo 500 fanti e 150 cavalli a prendere vettovaglie. Informazioni venete ci fanno ancora sapere che dal Monte di Brianza nel luglio si requisiva il vino per il campo cesareo, e nell'agosto vettovaglie per Milano (429). I comaschi ebbero a dire al Leyva che la pace fatta col Medici era di ben lunga peggiore della guerra, perché il Medeghino, vantandosi amico dell'imperatore, faceva quanto gli talentava. Ma il generale spagnolo faceva lo gnorri, e permetteva inoltre che i suoi soldati, stanziati a Como e a Milano, venissero per conto proprio, come non pagati, a predare sulle nostre terre: tutto era buono, vettovaglie, bestiame, legando persino la gente per cavarne del denaro.
Tuttavia dopo la pace di Pioltello la Brianza, per qualche anno, non fu tormentata da altri avvenimenti di guerra. Il Medeghino e il Leyva si accordarono di penetrare contemporaneamente, da diverse parti, nel Bergamasco ai danni dei Veneziani. Nel giugno troviamo infatti Battista Medici e il Pellizzoni in val Brembana dove colle taglie e coi saccheggi fecero un bottino che si diceva ammontare a circa sessantamila scudi. La borgata di Zogno ne ebbe particolarmente a soffrire. Gravissimi danni subirono pure Caprino e la Valsanmartino. Da quelle vallate le truppe del Medici che si facevano ascendere a milletrecento uomini, si ritirarono verso la fine del mese di fronte alle grandi forze del nemico che minacciava di entrare in Valsassina e di assalire Introbio, ed anche perché si seppe che si erano ritirate quelle del Leyva (430).
* * *
Il 1529 non fu migliore dell'anno precedente. Milano era affamata, i soldati non pagati. Di qui continue vessazioni, saccheggi, taglie in città e nella campagna. Da un'informazione del 4 aprile si rileva che in Milano non vi era " altro viver se non quello che vien di giorno in giorno dal lago di Como ". I Veneziani d'altra parte non mancavano di far scorrerie nel Monte di Brianza: nel gennaio, per modo d'esempio, il conte Sanseverino si era spinto co' suoi cavalleggeri fino a Vimercate, tutto saccheggiando e facendo prigionieri il commissario cesareo e un altro del Medeghino (431).
Vasti progetti andava intanto accarezzando Gian Giacomo per sempre meglio ingrandirsi. Presso il Leyva, sempre bisognoso di denari e di viveri, e dal quale nel gennaio aveva già ottenuto Domodossola e il suo contado (432), instava per avere anche la città di Como, così da rendersi pienamente signore del lago. La calata in Italia del conte di Saint Paul coi francesi, gli porse il destro di entrare seco lui in trattavive, pronto ad abbandonare l'imperatore e ad accostarsi di nuovo agli alleati, pur di raggiungere il suo scopo, visto che col generale spagnuolo non veniva a capo di nulla. Mandò al condottiero francese le sue proposte o capitoli nei quali, dandosi il titolo di marchese e di conte, domandava " molte cose, videlicet Como et il lago et Lecho, et provision grandissime del stado di Milan a molti etc. ". I capitoli furono mandati al re di Francia, ma la sconfitta del Saint Paul (21 giugno) rovinò ogni cosa. Quando giunse a Monguzzo la nuova di tale rotta si voleva far salve d'allegrezza, ma Battista Medici, il quale era a parte dei segreti maneggi del fratello, rispose secca-mente che non c'era polvere da sprecare (433). A sviare, forse, i sospetti che potessero esser giunti all'orecchio del Leyva, Gian Giacomo si mise d'accordo col generale spagnolo per un'invasione nel bergamasco. Nel luglio Battista Medici, ingrossate le forze con reclute fatte ne' suoi possessi, da Lecco per Calolzio si avanzò
fino a Pontida con circa trecento fanti e sessanta cavalli mettendo a sacco i luoghi per cui passava, mentre da Trezzo si inoltravano i cesarei. I Veneziani, nonostante che nelle valli bergamasche serpeggiasse la peste, tennero testa e ben presto gli altri dovettero ritirarsi. Battista Medici aveva tentato di far restaurare la rocca di Vercurago, dove esisteva anticamente un castello allora ruinato, col proposito di mettervi un presidio, ma i Veneti glielo impedirono (434).
Era ancora nei piani del Medeghino non solo di aver Como, ma altresì di occupare, coll'astuzia o colle armi, la Valtellina. Fin dal cadere del 1528 egli aveva astutamente cercato di indurre il vescovo di Coira, per mezzo dell'abate Schlegel, a rinunciare il vescovado in favore di Angelo Medici, arciprete di Mazzo, suo fratello. A questi movimenti non era estraneo lo sposalizio di sua sorella Clara con Wolf Dietrich di Ems, il cui viaggio doveva farsi attraverso il territorio dei Grigioni. Se ciò gli riusciva era sicuro di potersi poi insignorire della valle. Ma la trama fu scoperta nel gennaio dell'anno seguente. L'arciprete dovette ritirarsi dalla parrocchia per sfuggire all'ira dei Grigioni, e l'abate Schlegel finì nel novembre coll'essere giustiziato, mentre Dietegen Salis, che pure era stato imprigionato sotto tale accusa, fu riconosciuto innocente (435). Nel gennaio stesso tentò Gian Giacomo di coprire le insidie e lo smacco sofferto con altri pretesti in favor suo presso i cantoni confederati in Lucerna, onde non si tenessero a male se con la guerra o in altro modo, avesse poi a procedere contro le tre Leghe (436). Di qui ne venne tra il castellano di Musso e i Grigioni una tensione di rapporti, i quali del resto non furono mai veramente amichevoli. Inoltre per tenersi pronto ad agire secondo le circostanze, tanto più che gravi avvenimenti politici venivano maturando, non solo aveva dato incarico a suo cognato di assoldargli tremila lanzichenecchi, e per far denaro aveva imposto a' suoi sudditi di pagargli la metà delle loro entrate e ai mercanti la terza parte, ma si diede a fortificare i confini verso i Grigioni (437). Tra l'altro, sul finire di giugno, aveva preso a far innalzare all'estremità del lago, così da dominare il passo per la Valtellina, una robusta torre. Se ne insospettirono i Grigioni, i quali ritenevano inoltre ch'egli fabbricasse sul loro territorio: il Medici rispose ch'egli lavorava sul suo; ma i Grigioni fecero di tutto, risoluti in caso estremo di ricorrere alle armi, per farlo desistere (438).
I I .
Congresso di Bologna. - Il Medici deluso nelle sue aspettative. - Cerca di accordarsi con lo Sforza mentre sottomano si prepara a muover guerra ai Grigioni. - Sospensione delle trattative e tregua di sei mesi. - Invade la Valtellina. Vittoria di Morbegno. -Gli Svizzeri e i Grigioni lo respingono dalla valle e invadono i suoi possessi. - Lo Sforza conclude un'alleanza coi nemici del Medici. - I ducali assediano Monguzzo. - Presa del castello. - Il Medici abbandona la Brianza.
Il 1529 tramontava con un avvenimento che veniva ad intralciare gli ambiziosi divisamenti del Medeghino. Carlo V era giunto a Bologna il 5 novembre per definire con papa Clemente VII le ultime pendenze rimaste in sospeso nel congresso di Barcellona. Il 23 dicembre Francesco Sforza riceveva lo Stato di Milano a patto che pagasse all'imperatore, entro dodici mesi, quattrocentomila ducati d'oro (439), e nei dieci anni consecutivi cinquantamila ogni anno, restando in mano dell'imperatore, come pegno, il castello di Milano e la città e il castello di Como, che Carlo V si obbligava di consegnare appena fosse fatto il versamento del primo anno (440).
Il Medici, che aveva subodorato il vento infido, nonostante che nei patti di Pioltello si fosse stabilito che, cedendo l'imperatore per qualsiasi ragione al duca o al re di Francia o ad altri lo Stato di Milano, gli sarebbero stati riservati i suoi possessi coi capitoli concordati, fornito di molto denaro era venuto a Bologna dove, coll'aiuto del Leyva e di altri ostili al duca, fece di tutto per ottenere dall'imperatore la conferma di quanto gli era stato concesso; ma Carlo V, pressato dallo Sforza e da altri a lui favorevoli, fu irremovibile (441). Gian Giacomo se ne ritornò deluso ma risoluto, se mai, a sostenere la guerra contro lo Sforza, che sapeva stremato di mezzi, piuttosto che cedere, e non mancò, scrive il Missaglia, di raccogliere maggior denaro il più possibile con ogni sorta di asprezze e di imposizioni (442).
Il duca infatti, impossibilitato pel momento a fronteggiare il suo nemico, non fece nulla, e, pur odiandolo in cuor suo, cercò di non urtarlo. Gian Giacomo pensò allora di prepararsi alla conquista di Chiavenna e della Valtellina (443).
Quali ragioni potevano spingere il Medeghino a muover guerra ai Grigioni, anziché pensare a difendersi dal duca che pretendeva i suoi possessi? Egli non si trovava in buoni rapporti né col duca né coi Grigioni. Questi, come osserva il Missaglia (444), più che a lui avrebbero prestato facilmente orecchio ai larghi partiti che loro avesse a proporre lo Sforza. Gian Giacomo divisò pertanto di battere separatamente i due nemici, schiacciando prima i Grigioni in aiuto dei quali credeva non sarebbero accorsi altri Cantoni svizzeri, divisi com'erano da questioni religiose da rninacciarsi vicendevole guerra. D'altra parte poteva colorire il suo divisamento presso le corti cattoliche col pretesto di combattere in favore della fede contro gli eretici. Non conveniva a lui, senza plausibili motivi, aprire innanzitutto guerra al duca, che si trovava in ottime relazioni coll'imperatore, senza incontrare lo sdegno imperiale. Se con lo Sforza poteva venire ad un accordo definitivo di pace tanto meglio, ma per il momento gli bastava di ottenere che rimanesse neutrale per essere sicuro alle spalle. Penetrare, a momento opportuno, in Valtellina con poderose forze, fortificarvisi, e in un modo o nell'altro, a seconda delle circostanze, farsene in breve tempo signore, rendendosi in tal modo tanto potente e ricco di mezzi da temere quindi assai meno il duca. Piano, come si vede, più di ardito guerriero che di abile e prudente diplomatico. Giustamente il Gritti ebbe a dire ad Agosto, fratello del Medici venuto a Venezia a domandare aiuti, che il marchese non aveva saputo mostrarsi in tempo di pace così esperto come in tempo di guerra. Gian Giacomo pertanto sui primi di maggio mandava dei nunzi al duca " per fare bona amicitia ", promettendo denari assai, dei quali lo Sforza ne aveva gran bisogno, " il che si tien (informava l'oratore veneto Gabriele Venier) si farà per li danari ". I Grigioni non furono tardi a comprendere dove potessero andare a finire quei maneggi: spedirono nel giugno 1530 a Venezia dei loro ambasciatori per conoscere se il castellano di Musso era stato compreso nella pace fatta coll'imperatore, e se, movendogli guerra, la signoria ne avesse a male e intendesse intromettersi direttamente o indirettamente. La Serenissima nicchiò, e per allora i Grigioni non si mossero (445).
Verso la metà di luglio capitò a Milano da Musso Gio. Antonio Dugnani, gentiluomo milanese, molto caro al Medici. Lo Sforza da Cremona, con lettera del 17, ordinò al Bentivoglio di prenderlo, " perché (scriveva) pensiamo col mezzo suo di cavare molte cose de le pratiche del castellano di Musso ". Gli agenti del Medici mossero lamenti pel fatto, e il duca con altra del 25 raccomandava al Bentivoglio di far loro intendere come il Dugnani non fosse detenuto né per cosa pubblica né per motivo del Medici. Il Medeghino, per tagliar corto a qualsiasi tergiversare, ordinò di far prigionieri nel Monte di Brianza una trentina di gentiluomini ducali, e tutti fece tradurre a Monguzzo. Scrisse quindi al Bentivoglio dicendogli che se la prigionia del Dugnani significasse la guerra, egli era pronto a sostenerla, ma badasse bene che qualunque male si avesse a fare al Dugnani egli l'avrebbe fatto soffrire a' suoi prigionieri. E Gian Giacomo era uomo da mantenere, in questo caso, la parola. Nonostante le " Bestial insolenze ", come si esprimeva il duca con lettera del 29 al Bentivoglio, e alle quali, soggiungeva, " speriamo in Dio ch'el tempo portarà magior comodità di castigo ", lo Sforza dovette cedere. Il Dugnani fu liberato e altrettanto fece allora il Medici coi suoi (446). Miglior trattamento ebbe il Dugnani quando il 30 settembre ottenne dal duca, per intercessione del conte Gio. Fermo Trivulzio, di poter venire a Milano per curarsi d'una infermità (447).
Aggiunge il Missaglia che liberato il Dugnani si attese a trattare l'accordo.
Il Medeghino frattanto senza lasciarne trapelare il vero scopo, continuava febbrilmente i suoi preparativi: assoldava truppe, raccoglieva grano, fortificava le posizioni più importanti. Oltre rendere Musso inespugnabile (448), a Nesso in particolar modo, che doveva servire per qualsiasi evenienza di baluardo contro Como, vi fece eseguire nei mesi di ottobre, novembre e dicembre grandi lavori. E siccome gli occorrevano denari emanò una grossa taglia su tutto il paese col pretesto di dover pagare il duca. Battista Medici, che di tanto in tanto si allontanava per trattare d'incarico del fratello gli affari presso le varie corti, il 26 ottobre lo vediamo ritornato in Monguzzo dove faceva incetta di grano nei dintorni e nel milanese che poi spediva sul lago al fratello. Il 10 novembre, per notizie avute da un disertore di Monguzzo riparatosi a Como, il Coppalato avvertiva il Bentivoglio come il Battista stesse per recarsi in Francia, lasciando " nel castello et la rocha " in suo luogo il Dugnani. E poiché non vi erano che pochi fanti di presidio gli si era domandato di metterne un maggior numero, ma il Battista " cominzò a bravar che con l'ombra sua stando le porte aperte ogni cosa si guarda ". Vi univa il Coppolato uno schizzo a penna del castello: schizzo troppo sommario e nemmeno in tutto esatto nell'orientazione dei paesi, ma che ha il pregio di essere il più antico disegno del castello.
Il Coppalato, nelle sue attive informazioni, l'8 dicembre avvertiva il Bentivoglio che al castellano di Musso erano arrivate nuove truppe e che " a Nesso si lavora grossamente et si sono fatte tre porte al ponte maggiore "; il 20 dicembre che in Monguzzo erano giunti altri fanti, e che il Medeghino aveva mandato a Genova a chiamare chi gli costruisse una galea, e a suo cognato di reclutargli gente (449).
** *
Col 1531 le trattative col duca entrarono in una fase risolutiva. Non per nulla il Medici si era raccomandato al duca di Savoia, suo amico, il quale aveva mandato il Ferreri, vescovo di Vercelli, per indurre lo Sforza ad un accordo (450). Il 4 gennaio il Medici ccstituì suoi nunzi, con piena e legale procura, il fratello Battista e Cesare Piola per trattare col conte Massimiliano Stampa, agente del duca, in forma di pace, o di lega, o di tregua. Le trattative per un accordo di pace si svolsero laboriose con proposte e controproposte. Al Medeghino tenace nelle sue pretese, (se cedeva da una parte pretendeva dall'altra), faceva riscontro la buona volontà del duca sempre pronto ad un equo accomodamento. Il 18 gennaio Battista Medici da Lecco scriveva allo Stampa che le difficoltà erano ridotte a poche cose e si avevano buone intenzioni di eliminarle, lo pregava perciò di adoperarsi presso il duca in modo da venire alla conclusione. Il Medeghino stesso non mancò di raccomandarsi allo Stampa (451). Se non che, quando ormai si stava per stringere i nodi, il Medeghino lasciò comprendere quello che in realtà egli voleva dal duca. Il 20 gennaio lo Stampa, ricevuta la definitiva risoluzione del castellano di Musso per mezzo di Galeazzo Missaglia e di messer Cosmo dottor comasco, si portò a Vigevano dallo Sforza. Il Medici, come scriveva il dì seguente il duca al Bentivoglio, nei capitoli aveva introdotte alcune nuove richieste, principalissima quella che gli fosse data licenza in iscritto di conquistare e di tenersi Chiavenna e la Valtellina. Lo Sforza si mostrò ancora una volta accondiscendente, ma rimase irremovibile su quest'ultimo punto: " quanto al consentimento di recuperare Chiavenna et Valtellina. Nui senza alcuna exceptione non volemo dare assenso alcuno in scritto ne permettere sij dato d'alcuno de nostri ministri " (452). Raccomandò pertanto al Bentivoglio che, qualora non si potesse venire ad una definitiva conclusione, di non rompere le trattative " ma con qualche legitima scusa di differirlo, come seria di voler et per Domossula et per l'alienatione di tante cose consultar s. M.stà poi che esso Castellano et suoy non vogliono rimoversi da dicte domande " (453).
Scrive il Missaglia che il duca si accontentava di lasciare al Medici " Musso e Lecco colle riviere del lago, ed altri luoghi circonvicini di qualche importanza coi suoi titoli, e di fare che gli antichi possessori di quei luoghi cedessero le loro ragioni al marchese, e del suo dar loro la ricompensa, e che egli potesse comandare senza eccezione di maggior magistrato, e insomma potesse nel suo stato tutto quello che può un principe supremo, solo ch'egli riconoscesse il duca per padrone del diretto; ma con espressa condizione che il duca non potesse sotto qualsivoglia pretesto comandare alla persona del marchese, e fosse anco obbligato a dargli certa quantità di grano per uso del suo paese, senza pagare tratta, e certa quantità di sale al prezzo stesso ch'egli lo comperava, e che volendone più, pagasse la tratta e il sale come gli altri sudditi, e che il duca facesse avere rate e ferme tutte le sentenze e grazie fatte per lui e suo consiglio per l'addietro, ancor ne' luoghi non pertinenti al marchese per la nuova capitolazione, che i soldati e officiali del marchese fossero riputati e trattati come soldati del duca. All'incontro il marchese lasciasse Monguzzo con tutto il paese di qua del territorio di Lecco, e di presente pagasse quarantamila scudi, de' quali il duca in certo tempo ne avesse a restituire quindicimila " (454). Soggiunge che questo accordo si teneva per stabilito, quando il Medici, tenuto consiglio co' suoi capitani, non volle per nessun motivo accettare la proposta di pagar denaro, e ciò per il timore che lo Sforza, avuto Monguzzo senza combattere, adoperasse il suo stesso denaro per muovergli guerra. Ma la vera ragione, a quanto pare, per cui il Medeghino non volle firmare l'accordo fu il rifiuto del duca di accordargli il permesso di conquistare Chiavenna e la Valtellina. Il duca, ben conoscendo di quali gravi conseguenze per lo Stato potesse riuscire il suo consenso di muover guerra ai Grigioni, alle insistenze del Medeghino rispose sempre negativamente.
I capitoli (455), rimasti adunque sospesi, furono mandati all'imperatore (456), e intanto si combinò tra le parti una tregua di tre mesi, la quale se era utile al Medici per tenere il duca neutrale nella guerra che stava per intraprendere, peraltro serviva allo Sforza per vedere come sarebbe andata a finire l'arrischiata impresa del suo nemico, e quindi agire in conformità de' suoi interessi. Il 3 febbraio da Musso il Medeghino sollecitava dallo Stampa il salvacondotto e vi si univa un modulo del come doveva essere redatto, e cioè in ampia forma da valere tre mesi per sé, suoi fratelli, e servitori così da poter andare e venire attraverso lo Stato e di poter passare anche all'estero presso qualunque principe. Voleva inoltre che si avessero a nominare in detto salvacondotto altri quattro de' suoi da poterli mandare a negoziare le cose sue, e cioè il rev. fra David Bosso prevosto di Domaso (457), messer Gio. Pietro Calvasina, Filippo Ardizzoni, e Francesco Pusterla (458). Tuttavia per potere più comodamente trattare l'accordo, il Medici, per mezzo del vescovo di Vercelli, ottenne dal duca di prolungare di altri tre mesi la tregua, ma ebbe ancora un reciso rifiuto per la guerra di Valtellina (459).
Intanto lo Sforza, sborsata la prima rata di quattrocento mila ducati, riebbe il 15 febbraio il castello di Milano. Ma non poté entrare in possesso di Como e del suo castello che il 26 marzo per difficoltà suscitate dalla caparbietà di quel castellano.
I fanti spagnoli, ch'erano di presidio in Milano, alcuni giorni dopo il loro licenziamento, passando per Niguarda, Seregno, Mariano vennero a porre i loro alloggiamenti in Cantù, col divisamento di unirsi ai loro commilitoni di Como, e insieme uscire dal ducato di Milano.
Durante la loro permanenza in Cantù commisero gravi vessazioni agli abitanti del luogo e di altri paesi vicini.
Lo Sforza ne fu assai dispiacente, e pure non concedendo a quelle popolazioni di difendersi con le armi, come avevano chiesto da Vigevano, scrisse al Bentivoglio di lasciarvi quelle truppe non più di quindici giorni e di provvederle di viveri, e quindi allontanarle dal ducato.
Ma, nonostante il parere contrario degli agenti del duca, quei soldati passarono al servizio del Medeghino, come altrettanto fecero quelli del presidio di Como, benché tentasse di opporvisi Mons. Caracciolo in nome di sua Maestà. Per la via di Monguzzo se ne vennero a Lecco per essere inviati in Valtellina: in tutto novecento fanti circa (460).
I Grigioni, impensieriti dalla voce che il Medeghino nei suoi maneggi e preparativi operasse di concerto col duca, mandarono a Milano Martino Bovellini perché vedesse chiaro come stessero le cose. Se ne ritornava il Bovellini, latore ai suoi delle buone intenzioni del duca a loro riguardo, quando il Medici, al quale premeva far credere il contrario, sulla strada di Como, alla distanza di sette miglia da Milano, lo faceva sorprendere, tradurre fuori mano, e assassinare col figlio, che l'accompagnava, da quattro soldati di Monguzzo (461). Il duca, edotto dell'assassinio e fatta compiere un'inchiesta, con lettera del 4 marzo 1531 da Vigevano ingiunse a Rocco Quadrio di portarsi tosto presso i Grigioni e loro notificare, oltre il dispiacer suo per tale misfatto, quanto aveva detto all'oratore grigione (462). Risposero i Grigioni di credere allo Sforza se avrebbero visto il Vistarini, che sapevano entrato in Como con numerose truppe, o un altro qualsiasi invadere i possessi del Medici, e costringerlo a desistere dal fare la guerra in Valtellina (463). I Grigioni lasciarono comprendere come non fossero alieni dal combinare un'alleanza contro il comune nemico, ma lo Sforza prima di romperla apertamente con Gian Giacomo volle prudentemente vedere quale piega prendessero gli avvenimenti.
Compiuto quell'assassinio, il Medeghino alle calende di marzo entrava improvvisamente in Valtellina e faceva di sorpresa occupare Morbegno dal fratello Gabrio: le forze del Medici erano di circa settencento uomini (464). Gian Giacomo il 14 marzo mandava a dire ai cinque cantoni confederati, coi quali era in relazione di amicizia, di aver invaso la Valtellina perché provocato dai Grigioni, ai quali aveva chiesto cordialità di vicinanza e, dopo ottenutane promessa, si erano invece armati contro di lui; domandava pertanto che si avesse ad impedir loro il passaggio sul territorio dei cinque Cantoni (465). I Grigioni non tardarono a prendere le armi e ad assediare il borgo, ma il 23 marzo subirono una piena disfatta (466). Il Medeghino menò grande scalpore per quella vittoria, e volle che nei suoi dominii si rendessero grazie a Dio con processioni, e se ne desse notizia a tutte le corti.
Battista Medici da Monguzzo si portò subito a Milano ad informare lo Speziano. Questi con lettera del 25 informava a sua volta il duca come il fratello del castellano era stato a lui mandato " acciò a la giornata meglio sapesse come prosperavano le cose del s.r Marchese quale gratia de Dio, ch'aiuta sua fede, haveano ottenuto, contra Grisoni secta Lutteriana, Morbegno dove pensava fortificarse et che li havea . 500 . guastatori oltre li soldati che sono . 600 . che non manchano. Fortificato pensava lassarli circa . 200 . homini et con il resto andar prosperando rincontrandose poi con suo Cognato qual anche se dice havea da condurre fanti m/3, al credere del Dugnano non serano che . 800 ., et che al s.r Baptista he parso avisarmi acciò a la giornata sapia quanto fano et pensano di fare, si come quella persona li he quanto che niuna altra amica et patrona ". Soggiungeva che i fratelli Medici non pensavano " ad altro che essere boni servitori di V. Ex.ia ", e che perciò si ritenevano sicuri che il duca non sarebbe venuto meno (467). Allo Sforza non poteva sfuggire, nonostante tutte queste proteste di fedeltà, che al Medeghino importava tenerlo buono e neutrale per poi a impresa riuscita imporgli patti leonini, tanto più che cercava anche di intendersela di nascosto col re di Francia.
Se non che il bel sogno, che il Medeghino riteneva ormai realtà, doveva sfumare ben presto. I Grigioni, esasperati, decisero di farla finita col castellano di Musso: domandarono aiuti ai Cantoni svizzeri, i quali, tranne i cinque che si trovavano in buoni rapporti col Medici, risposero all'appello (468) e con una forza di oltre quattordicimila combattenti alle calende di aprile scesero in campo contro il comune nemico, risoluti a non deporre le armi fino a tanto che non lo avessero annientato (469).
Il Medeghino, alle prese con un nemico così potente, si diede ad invocare aiuti da ogni parte col pretesto ch'egli combatteva in beneficio della fede, ma nessuno si mosse né allora né in seguito per quanto brigasse. Lo Sforza, mentre continuava a mantenersi in buone relazioni cogli Svizzeri e coi Grigioni preparando il terreno ad un'alleanza, sottomano lavorava a indebolire sempre più le forze del Medici. Egli ottenne dal re dei Romani che non gli potessero arrivare dalla Germania i tanto sospirati Lanzichenecchi (470) e il 10 aprile mandava a provare ai Grigioni come ciò fosse avvenuto per opera sua (471). Da Carlo V provocò altresì un decreto da Gand del 22 aprile col quale si intimava al Medici di rilasciare gli Spagnoli assoldati.
Il Medeghino dovette far buon viso a cattiva fortuna, e rilasciò quei veterani. Il 3 maggio si concentrarono a Como, quindi vennero ad Erba, e di là due giorni dopo ad Inverigo. Quivi volevano fermarsi qualche giorno, ma, benché si diportassero bene verso gli abitanti, il duca non vi acconsentì: se ne vennero a Monza e di là passarono nel mantovano (472). In altri modi cercò il duca di danneggiare il suo nemico: il 16 aprile il Bentivoglio vietò ai carpentieri di Como di recarsi al servizio del Medici, e alla domanda del Medeghino di poter trasportare grano dal Piemonte attraverso il ducato, pronto a rilasciargliene la metà, non solo rispose negativamente, ma saputosi ch'egli cercava di provvedersi nel Bergamasco per la via di Chiuso presso Lecco, ottenne dai Veneziani che avessero ad impedirlo (473).
Il duca, che fin dal 7 aprile scriveva da Vigevano al Bentivoglio di essere più che mai contento che si andasse finalmente preparando l'occasione di " levarsi davanti agli occhi il castellano di " Musso ", di fronte alle vittorie degli Svizzeri e dei Grigioni che ormai assalivano il Medeghino nel cuore del suo dominio (474), stimò giunto il momento di gettare la maschera e di combatterlo apertamente. Il 17 aprile avvertiva il Bentivoglio di aver spedito " il Panizono con una Instruttione a quelli Capitanei Elvetij et Grisoni facendoli intendere il mio bono animo, et con ringratiarli de le bone demonstratione loro verso nui, et per vedere in quello si vogliono risolvere circa il stabilire una intelligentia et bona conclusione tra mi e loro alla ruina del Castellano di Musso " (475). Le pratiche per giungere ad un'alleanza cogli Svizzeri e coi Grigioni procedevano bene. Importava, per altro, di essere sicuri della Signoria Veneta. Il duca aveva domandato aiuto ai Veneziani, ma questi si scusarono di non poterlo fare. I Grigioni mandarono allora verso la fine di aprile a Venezia dei loro messi a dire che avevano stabilito di annientare il Medici per avere ucciso il loro oratore, occupato Morbegno, e per altre offese, e domandare se si intendeva soccorrere il castellano di Musso. Tutti questi movimenti non sfuggirono al Medeghino, e mentre a Milano mandava il fratello Battista per indurre il duca a concludere l'accordo rimasto sospeso, rimettendovi parecchio in quello che aveva domandato, dall'altro spediva a Venezia perché la Signoria volesse interporsi presso il duca per concludere l'accordo e non si alleasse coi Grigioni. Risposero i Veneti che avrebbero fatto ogni buon officio, ma non furono che parole, poiché il 6 maggio notificarono ai Grigioni di esser contenti dei loro progressi, e che al Medici avrebbero impedito sul loro Stato qualsiasi rifornimento di viveri e di soldati (476).
Similmente Battista Medici non ebbe dal duca che dubbiose risposte. Il Medeghino mandò allora a Vercelli il fratello Angelo, il quale il 2 maggio così scriveva allo Sforza: " Da poi che v. Ex.a ne ha fatto dare quelle dubiose risposte, e che anchora se sentiva da lei qualchi movimenti contra di noi, è parso a noi fratelli di mandarmi in qua acciò mi retrovassi in Loco più libero. Del che ne ho voluto subito avisare v. Ex.a et pregarla una altra volta che la vogli considerare al bene et utile et honore suo circa questa cosa. Et se più è suo interesse senza suo danno et spesa di haver et s.r Marchese mio fratello sempre a suo servitio et così tutti li suoi fratelli et contra ogni persona del mondo etiam con sicurezza chel non habbi a manchare a v. Ex.a che il volerlo disperare et darli causa di fare quanto potrà per accostarsi a altri, la prego a darme a me sua fede che io possi venire da lei et tornare securo che spero certo che ogni cosa si assettarà et si adestrerà al volere et utile di v. Ex.a purché lei si metti a cose honeste, come speriamo farà. Et io da lei veneria in publico o in secreto come meglio li paresse, solo mi dubito che v. Ex.a pensi di haverne il cortello alla gola, et che siamo per questo astretti a tore da Lei ogni conditione, ma la sappia che le nostre cose non sono anchora in termine che se ne debbi fare così poco conto, ne che ne manchi parti o per una via o per una altra, solo havemo uno avantagio noi fratelli per le presenti occasioni che potremo disponere del Marchese nostro fratello, cosa che mai, non havemo potuto sino a questa ora. Però prego l'Ex.a v. a sapere tore l'occasione sin che la gli è. Noi non possemo anchora credere che v. Ex.a si debbi movere per aiutare l'inimici suoi et nostri, et facendolo la guerra durerà poi anchora anni et anni ne so che fine haverà. La si pensa forse che il Marchese sij assediato in Musso, ma la troverà che lui ha fortificao el porto, et si tene et tenerà contro tutto il mondo, et tenendosi non si po' assediare el Castello che non vadi ogni di dentro et uscischi ciò che si vole. L'ho voluta avisare al longo d'ogni cosa. La prego mo a fare quello che è più utile et honore suo che po' volere v. Ex.a di meglio che potere senza sua spesa cacciare l'inimici suoi de Italia o travagliargli et tenerli sempre con tale freno che non haverano ardire di uscire a servitio di alcuno potentato contro di quella. Non nego che il Marchese non sij stato troppo licentioso contro di quella, ma essendo lei quello prudente principe che la è non ha da postponere l'utilità sua all'apetito del vendicarsi, tanto più recognoscendosi el p.to Marchese et volendogli servire lui e i suoi fratelli de quella maniera che possi o debba alcuno homo del mondo. Ne altro mi occorre che basciargli la mano et recomandarmegli humilmente, pregando Dio che gli dij longa vita et felice ". Al vescovo di Vercelli, assente, scriveva due giorni dopo:
" Già tri dì sono gionto qua, et sperando di passar più oltra non gli ho scritto; hora che qua me intertengo aspettando Commissione del s.r Marchese' mio fratello quel che ho da fare, la saluterò con questa in nomine del s.r Marchese ettutti noi. Et circa le nostre cose benché adesso habiamo uno gran foco ale spalle, dico più XIIIJ.m tra Elvetij et Grixoni, però se nessuno altro non se ne impaza ne riportaremo presto indubitata victoria. Vero è che il s.r Duca de Milano fa certi movimenti quali però sina a questa hora non hano passato le parolle et pensamo lo facci per farme condescendere ale sue voluntà, non con animo di aiutare questi luterani che no nè suo caso, quali movimenti non ne dano se non gran dubio et disfavore. Ma la guerra si intertenerà longamente et fra tanto qualche cosa nascerà o se gli troverà qualche rimedio o per una via o per un altra. Et se la Ex.a del Duca vorrà fare il suo utile la cercarà che gli sijno servitori como da noi non mancarà. Altro non mi occorre che basare la mano a V. S. R.ma pregandola a mandar l'inclusa al R.mo Car.le nostro s.re et recomendarmi a lei humilmente " (477). Fatiche sprecate: lo Sforza, cogliendo l'occasione propizia pensava ormai a disfarsi del suo nemico. Chiarita, come sopra abbiam detto, la politica di Venezia in questo affare, il duca, che giorni prima aveva mandato a chiamare i maggiorenti dell'esercito elvetico-grigione, il 2 maggio firmò con questi un trattato di alleanza senza aspettare che finisse la tregua, alla quale non credette di ritenersi vincolato, trattandosi di riavere il fatto suo (478). Battista Medici aveva tentato fino all'ultimo di impedire quell'alleanza, ma non vi riuscì. Il Medeghino, per questa mancanza di fede, si lamentò presso le corti, e a memoria del triste fatto fece coniare monete nella zecca di Musso con la F rotta (fracta fides) (479).
Nel trattato si convenne, per dirla in breve, che il Medici e i suoi fratelli fossero dichiarati ribelli, e chi avesse osato portargli soccorso sarebbe stato di comune accordo combattuto; che le terre occupate dal castellano di Musso sarebbero ritornate al duca, tranne Chiavenna e la Valtellina, purché entro tre anni si pagassero trentamila renensi per le spese di guerra fino allora sostenute; che il duca avrebbe preparate forze convenienti per terra e per acqua con tutto il necessario per condurre a termine la guerra; che gli Svizzeri e i Grigioni avrebbero concorso con duemila fanti sotto i rispettivi capitani dei quali milleduecento da pagarsi dal duca; che il castello di Musso con la torre del lago sarebbero stati distrutti dalle fondamenta né mai più riedificati (480).
Il Medeghino si preparò a sostenere l'urto decisivo con tenacia e ardimento mirabile, pur non tralasciando di brigare da una parte presso l'imperatore perché inducesse il duca a venire ad un accordo di pace, e dall'altra presso il re di Francia incitandolo a calare in Italia alla conquista del ducato (481).
Il duca, in base al trattato aperse tosto la guerra contro il Medeghino. Il giorno seguente ordinò il sequestro dei beni del Medici e dei suoi seguaci, devolvendoli alla camera ducale, e incaricando a sopraintendervi Giorgio Maggiolino uno dei maestri delle entrate. Due giorni dopo emanava una taglia sul Medeghino, e su tutti quelli ch'erano con lui, ma che nessuno ebbe mai il coraggio di eseguire (482). L'8 maggio aveva inoltre eletto il Maggiolino quale commissario a ricevere il giuramento di fedeltà dalle terre già del Medici coll'incarico di riscuotere nello stesso mese dai territori occupati o che si dovevano occupare, la somma di cinquemila scudi d'oro del sole, e ciò per concorrere alle spese di guerra e per il bene di liberarli da quel tiranno. Purtroppo da quei luoghi, come il Maggiolino notificava da Como l'11 maggio, non si poteva riscuotere nulla essendo gli abitanti fuggiti, e poi perché dove " sono stati et se ritrovino li soldati Grisoni et Svyceri hanno quasi consumpto ogni cosa ". A questo riguardo già dal 4 maggio il Vistarini aveva reso noto che i paesi del lago erano tutti pelati e abbandonati. Si dovette pertanto pensare altrimenti (483).
Rioccupata Domodossola si decise per prima cosa di togliere al Medici il castello di Monguzzo coi possessi in Brianza nella persuasione che più facile sarebbe poi stata la conquista di Lecco e del lago (484). Saputosi che in Monguzzo non vi erano che pochi soldati, per essere stati tolti nella maggior parte dal Medici per contrastare l'avanzata degli Svizzeri e dei Grigioni, lo Speziano da Como mandò cinque coorti ad occupare il castello. Se non che il Medeghino, vi aveva mandato nel frattempo il Pellizzoni con buon numero di soldati coll'ordine di ben fortificarsi e di resistere fino all'ultimo, in modo di dar tempo di porre Lecco in stato di miglior difesa e specialmente di poter raccogliere in Brianza il grano appena fosse giunto a maturanza, giacchè vi era grande penuria per la carestia. Giunti i ducali a due miglia da Monguzzo, e saputolo di nuovo ben presidiato e fortificato, sostarono aspettando i necessari rinforzi (485).
Il 21 maggio il duca elesse comandante dell'impresa di Monguzzo il colonnello Alessandro Gonzaga, e, due giorni dopo, Gio. Battista Carcano come commissario ducale. Al Vistarini il 30 maggio fu imposto di attendere esclusivamente a Como e al lago (486).
Lo Sforza non si trovava preparato: aveva domandato aiuto (soldati, polveri, ecc.) ai Veneziani, ma questi, come pure al Medici che invocava soccorso, non diedero che buone parole: Venezia volle rimanere strettamente neutrale (487).
La formazione del corpo di operazione, al quale dovevano partecipare due coorti di Grigioni, fu infatti lunga e laboriosa. Le compagnie dei soldati giungevano in ritardo e senza il numero debito, mancavano le paghe, i viveri, l'artiglieria, le munizioni; ora mancava una cosa ora l'altra: deficienze che, più o meno, durarono per tutto il tempo dell'assedio. Il colonnello e il commissario sollecitavano continuamente l'arrivo di quanto era necessario per potersi muovere, particolarmente dei soldati dei quali il Gonzaga ne domandava almeno settecento per l'assalto e cinquecento per premunirsi alle spalle. Da notizie avute da un prigioniero, fatto in una scaramuccia sotto Monguzzo, e da disertori, si sapeva che il presidio era di circa duecento uomini, parte paesani e parte lucchesi e sienesi, che il Pellizzoni incoraggiava facendo correre la voce che da Lecco sarebbero arrivati in soccorso duecento Lanzichenecchi. Mentre in Anzano si veniva operando il concentramento delle forze ducali, una gentildonna del paese, con licenza del Gonzaga, ottenne di potere recarsi a Lecco ad intercedere dal Medeghino la liberazione di suo marito prigioniero in Monguzzo per la sua fedeltà al duca. Vi andò ma non poté parlare con Gian Giacomo né coi fratelli: dal Dugnani seppe solo che suo marito non si trovava in quel castello. Già prima e per mezzo dello Speziano, aveva ricorso al Pellizzoni ma invano.
Arrivati i Grigioni, i quali benché in numero minore del convenuto pretesero paga completa (488), il primo di giugno si era deciso di trasportare il campo sotto Monguzzo, ma giunta la nuova della camiciata compiuta dal Medeghino sopra Musso e della sua partenza colla flotta verso Lecco, lo Speziano, dubitando che fosse per soccorrere Monguzzo, diede ordine di non muoversi fino a tanto che si fossero conosciute le intenzioni del nemico. Finalmente il 6 giugno, stante le insistenti lamentele degli alleati per tante lungaggini (489), e benché non fossero ancor giunte tutte le truppe richieste, l'esercito ducale mosse verso Monguzzo e pose il campo a Cavogno. Quivi si fortificò e, fatte le spianate, vi piazzò l'artiglieria in diverse riprese per battere le mura. Il 9 venne a Monguzzo il Bentivoglio con lo Speziano, seco conducendo i cavalli della guardia ducale essendo stato sollecitato l'invio di una compagnia di cavalleggeri per il servizio di esplorazione al di qua e al di là del Lambro, e si domandò la resa del castello.
Il Pellizzoni rispose negativamente. Non rimaneva che prendere il forte a viva forza. Nella notte con circa duecentotrenta guastatori, sotto la guida di Benedetto da Omate a ciò delegato dallo Speziano, si iniziarono i lavori di trincea per avvicinarsi alle difese nemiche e atterrarle; ma, essendone rimasti morti e feriti parecchi, molti vinti dalla paura fuggirono. Tre giorni dopo il Bentivoglio era di nuovo a Monguzzo e poté constatare come si erano già abbattute certe difese della torre e della muraglia, ma poiché i nemici si difendevano con tenacia e valore sorretti dalla fiducia che il Medeghino non avrebbe mancato di soccorrerli, trovò urgente l'invio di altre truppe e di polvere, avendone i cannonieri già consumata più di ottomila libbre, con cento palle " de canoni de 50 ".
Il colle sul quale si ergeva il castello si può dire che quasi da tre lati scende ripido sul piano, e talora a picco come verso Lurago. La parte che si prestava ad un attacco, e dove al tempo del Medici si faceva la guardia di notte, era quella che prospettava Erba e che declina dolcemente verso l'attuale cascina Enrichetta, dove passa la strada che da Nobile conduce ad Anzano. La porta che anticamente serviva di ingresso al castello si apriva verso Pusiano, ma il Medici trovò più conveniente aprirne un'altra con ponte elevatoio dalla parte opposta. Da questo lato correva la fossa, e il Pellizzoni rafforzò le difese elevando un bastione largo 13 piedi e tanto alto da coprire le mura dai colpi dell'artiglieria, una casamatta ed altre fortificazioni ben coneatenate.
La notte del 14 i guastatori coperti da gabbioni si avvicinarono alla casamatta per zappare il bastione, ma dovettero ritirarsi, feriti la maggior parte per i sassi che precipitavano dall'alto gli assediati. Si trovò il bastione più forte di quello che si pensava e la fossa molta larga. Francesco Bernardino Pietrasanta, gentiluomo milanese banderale del conte Gerolamo Crivelli, il quale temerariamente aveva voluto arrampicarsi sul bastione sventolando la bandiera verso i nemici, rimase colpito a morte da un'archibugiata. Era costui un prepotente. Giorni prima era venuto a contesa con un soldato; tutto pareva finito, quando poco dopo, a tradimento, colpiva mortalmente alla testa con un colpo di spada il suo avversario che stava giocando. Tal fatto irritò talmente i soldati, tanto più che il Pietrasanta era dalla parte del torto, che il Gonzaga aveva cercato di farlo allontanare dall'esercito (490).
Ma benché il Gonzaga scrivesse al duca il 17 che si andavano " cavando li bastioni de li inimici per intrare in la fossa per toni certi fianchi con li quali si defensano ", tuttavia il lavoro dei guastatori si faceva sempre più pericoloso, e non pochi rimanevano uccisi, man mano che si veniva avvicinando le difese vitali del castello (491).
Perciò non pochi si davano alla fuga. In una relazione del giorno 14 si dice ch'era fuggita la maggior parte dei 51 guastatoni varesini, ed il 18 si erano allontanati quelli della pieve di Vimercate, riparando non già alle loro case, ma al di là dell'Adda per non essere ripresi e puniti (492).
Si pensò di rimediarvi coll'aggiungere ai rimasti un certo qual numero di Grigioni, dando loro la paga di dieci soldi al giorno. Vi si lavorava di notte divisi in squadre, dandosi il cambio ogni otto ore, ma il lavoro rendeva meno quando c'era il chiaro di luna.
D'altra parte gli assediati si difendevano con grande vigore. Il 21 in una sortita avevano ucciso, fra gli altri, " M.ro Maphio bombardero et ingignero ". Un disertore, fuggito dal castello il giorno seguente, dava notizia che nel forte vi erano una quarantina di feriti, che la razione era stata ridotta da tre pani a due, che il Pellizzoni incoraggiava i suoi promettendo che non sarebbero mancati dei soccorsi, e che vi si era inoltre costruita con legnami una seconda casamatta nella quale non si poteva entrare " se non venghano fora del portello et adreto la muraglia, et in quella non vi possono stare più di quattro homini con la fossa larga un brazo, et hanno piantato certi travi a una colombera con intentione de reparare et fortificare, dubitando che da quello canto non si batesse con artigliaria ".
Dell'arrivo di aiuti agli assediati erano giunti parecchie volte avvisi ai ducali. Il 10 giugno da Olginate il Villantenio aveva avvertito, come di cosa certa, di una camiciata da parte del Medici: si stette in armi tutta la notte, ma non ne fu niente. I ducali riuscirono invece il 14 all'una di notte a far prigioniero Bernardino da Tabiago " famero di stalla del Medeghino ", che era partito da Lecco con una lettera e con medicine per il Pellizzoni, accompagnato da un certo Stefano, detto " marrano ", servitore del Medici. Il Bernandino fu impiccato il 25, e Stefano riservato per uno scambio di prigionieri col Medeghino (493). I ducali, onde premunirsi da qualsiasi colpo del Medici e comunque impedire l'arrivo agli assediati di qualsiasi soccorso, fortificarono meglio il loro campo, inviarono soldati ad Olginate aumentando il presidio di quella torre, e collocarono in Nobile la compagnia del capitano Bastiano Picenardi di fresco giunta. Lo Speziano aveva insistito presso il duca di presidiare altresì Civate, luogo rimasto indifeso dopo che il Gonzaga il 2 giugno aveva richiamato al campo il conte Crivelli co' suoi fanti e co' suoi cavalli, ma non se ne fece niente perché al colonnello premeva di non indebolire troppo le sue forze. Lo Speziano, tra l'altro, informava che il Medeghino sulle grosse navi armate " li homini ha preso nel monte de Brianza e tutti gli incatena ". Che il Medici, nonostante tutte le precauzioni dei ducali, tralasciasse di far pervenire dei soccorsi ai suoi non era nemmeno da pensare. Il 28 infatti si riuscì a sorprendere ad Olginate una spia la quale veniva a notificare al Pellizzoni come in quella notte il Medeghino avrebbe mandato sedici some di farina, una di polvere, un barile di polverino, ed una corda con nodi distanti l'uno dall'altro un mezzo braccio per " songhiarsi con tutti li compagni di fora per lo ultimo remedio " alla volta di Lecco. Si vegliò tutta la notte, scrive il Gonzaga, " expectando chi decta farina et polvere et polverino et songhia dovesse essere portato per chi per deta spia era facto intendere venire dentro così accompagnato da centocinquanta soldati con uno capitano qual veniva per loro governo ". Il Carcano invece informava trattarsi di un carico di venti cavalli con cinquanta archibugieri. Tanto il colonnello quanto il commissario ebbero ad affermare che, per quanto vigilassero, non si verificò nulla. In realtà quando i ducali penetrarono nel castello si constatò che quel soccorso, se non in tutto, almeno in parte era riuscito.
La presa di Monguzzo andava troppo per le lunghe: l'onore delle armi ducali ne soffriva, giacché gli Svizzeri e i Grigioni ne movevano continui lamenti (494). Ma ormai si era agli sgoccioli, e i soldati da una parte e dall'altra non tralasciavano di insultarsi a vicenda appena lo potevano. Il Bentivoglio, che di tanto in tanto non mancava di venire a Monguzzo per sollecitare le operazioni, spinto anche da un certo amor proprio di spuntarla con onore contro il Medici il quale gli aveva tolto quel castello, venne il 28 a vedere se non era il caso di tentare con successo l'assalto, giacché si era bombardata la casamatta e la muraglia. Col Gonzaga e gli altri capitani, unitamente al " Tantio, Mastro Bono et Ant.o spagnuolo ingigneri " e ai cannonieri, fece un sopralluogo, ma si trovò necessario, essendo l'erta da salire alta diciotto braccia circa, di continuare ad intervalli il bombardamento con piccoli pezzi, e intanto entrare di notte nella fossa e zappare dal bastione tanto di materiale che facesse scala al salire. Finalmente il primo di luglio il Carcano poteva scrivere al duca che, padroni della fossa e ruinate le due casematte " di modo che da quello canto niuna cosa ne po offender se non sassi ali quali se li remendia senza dilacione de tempo in far ponti de assi per andarchi coperto ", non restava che zappare il bastione e che se i guastatori fossero in numero sufficiente non passerebbe domattina che si sarebbe padroni di Monguzzo. Tuttavia nella notte si lavorò tanto che la mattina seguente si decise l'assalto. Le compagnie dei capitani Picenardi e Guasto coi cavalli della guardia ducale vennero collocati in Nobile pronte ad impedire, durante l'assalto, la fuga del nemico o l'arrivo di qualsiasi soccorso, e ai Grigioni si diede l'incarico di custodire l'artiglieria. Il rimanente delle truppe fu schierato su tre file. Nella prima stavano le compagnie del Ruschino, Cellano, e Mantegazza; nella seconda quelle del Favagrossa, Campagna, e Ioseph; nella terza le altre del Crivelli, Lampugnani, Gallarati, e Taverna. Le schiere dovevano soccorrersi a vicenda secondo il bisogno. Il Pellizzoni, che non aveva ormai viveri e munizioni che per qualche giorno, per mezzo del Picenardi domandò di arrendersi salve però le persone e gli effetti, e di poter andare a Lecco. Tenutosi consiglio, il Bentivoglio intimò la resa a discrezione. Rispose il Pellizzoni che tal resa implicava il diritto di fare impiccare tutti i difensori, e che dovendo morire lo era meglio coll'armi alla mano. Si venne all'assalto. I capitani, banderali, luogotenenti, e gli uomini d'onore salirono valorosamente, ma non essendo prontamente seguiti dai soldati furono respinti con parecchi morti e molti feriti. Fatte riposare le truppe circa un quarto d'ora si tentò con maggior vigore un secondo assalto. Già venticinque uomini con due bandiere erano montati sulle mura e gli altri seguivano, ma il nemico, il quale aveva innalzato al di dentro un parapetto, si difese con tale energia con gli " archibusi, sassi, fochi artificiali, rotte d'artiglieria, cerchij di ferro, travi, et mille altri instrumenti ", che l'uno non potendo soccorrere l'altro furono di nuovo ributtati colla morte del Campana, del banderale del Gallarati colla perdita dell'insegna, e di altri molti. Assai di più furono i feriti, tra i quali gravemente il Favagrossa (495), il Lampugnani, e, leggermente ad una mano, il Crivelli. Si voleva dal Gonzaga tentare un terzo assalto, approfittando della stanchezza del nemico, ma il Bentivoglio, considerando che tra morti e feriti si erano perduti circa centocinquanta uomini (496) e ne sarebbero potuto mancare degli altri, e che qualora venisse in soccorso il Medeghino ricevere maggior danno, deliberò di soprassedere e fare invece buona guardia intorno al castello con intenzione di rinforzare le truppe e di facilitare l'espugnazione con l'opera dei guastatori, sperando con minor danno di farsene padrone fra pochi giorni (497).
L'assalto non sarebbe riuscito, secondo la relazione del collaterale Giovanni Grasso, per mancanza di scale; se ne adoperarono due sole, sulle quali non potevano montare alla pari che due uomini a stento, di maniera che " a colpi de archibusate, fochi artificiali et sassate furono morti li primi et cascavano adosso ali altri. Tali effecti invilirono le nostre gente et se perse et p.o et 2° assalto ".
In realtà gli assediati si erano difesi con disperato valore. Tra questi si distinse l'alfiere del Pelizzoni, Antonio Criminale, il quale, mentre combattendo esortava i suoi, si vide cadere morto il fratello, colpito da un'archibugiata in fronte. I soldati impressionati incominciarono a cedere; l'alfiere li riprese e preso il cadavere del fratello per una gamba lo precipitò dalle mura (498).
Comunque, la situazione degli assediati si era fatta quanto mai difficile, e dagli ultimi contrassegni avuti dal monte di Civate non c'era più speranza di soccorso.
Il Pellizzoni non si perdette d'animo: calmo e audace, nonostante la sorveglianza del nemico, la notte del 2 luglio 1531, approfittando di un momento opportuno, uscì silenziosamente dal castello coi suoi valorosi e velocemente si incamminò verso Lecco, non lasciandovi che gli ammalati ed i feriti (499).
Più tardi i ducali si accorsero della fuga del nemico: lo inseguirono, ma inutilmente. Si riuscì soltanto a far prigionieri alcuni che si erano sbandati durante la fuga.
Da un rapporto del 3 luglio si ha che i nemici " havevano pur anchora vitualia per qualche dì, et da . 6 . dì in qua le è intrata vitualia et monitione che se li è trovato dentro li cavali da soma. Ne son morti et feriti assai de loro. Tutto quello che se li è trovato intro subito è stato sachegiato, però questi soldati si dano al diavolo che costoro se ne sono andati così senza loro danno " (500).
Il Medeghino non dimenticò i suoi valorosi caduti in mano dei nemici. Mandò un suo tamburino al Gonzaga colla proposta che restituendo il capitano di bandiera del Pellizzoni Francesco d'Orsenigo, il Caravacca e gli altri feriti lasciati nel castello, egli avrebbe rimessi altrettanti dei ducali a scelta. Le pratiche per lo scambio dei prigionieri durarono parecchio, perché il duca non intendeva cedere il Caravacca. Ma il Medeghino rispose che senza quello non concedeva nulla, e allora il duca cedette (501).
La presa di Monguzzo segnò la fine del dominio del Medici in Brianza, ma, se crediamo all'Angelo Medici (502), costò al duca la spesa di ben cinquantamila scudi, tanto che dovette imporre un'altra volta in Milano il dazio della macina di uno scudo al moggio (503).
L'esercito ducale, da rassegna fatta il giorno seguente, era di 1248 uomini computati 180 feriti. Alcuni giorni dopo si trasportò a Civate, fortificandovisi, per operare il concentramento delle truppe, dovendosi completare le compagnie, e di tutto il necessario per la conquista di Lecco (504).
* * *
Il castello di Monguzzo non fu lasciato in abbandono, ma si pensò a presidiarlo e a ripararlo. Il 6 luglio fu comandato a Giovanni Savana di recarvisi con cento soldati, e di porsi agli ordini del conte Gerolamo Crivelli: l'8 era già sul posto, dopo essersi fermato il giorno prima a Giussano per far riposare i soldati stanchi e spossati. Il Savana si diede tosto a riparare il castello. Il 22 agosto informava che era " rimesso al pristino stato salvo le ca matte ": egli aveva allora 30 paghe con 25 soldati. I lavori non dovevano tuttavia essere tanto innanzi, come lascerebbero supporre quelle parole. Infatti il 28 settembre, dopo aver detto ch'egli faceva raccogliere vino sui fondi di messer Franchino da Mandello, beni devoluti alla camera ducale perché serviva il Medeghino e al tempo della raccolta aveva trasportato a Lecco il grano e le bestie, scriveva al Bentivoglio che si lavorava a far restaurare il castello " per la cui fabrica la plebe de Ayate di qua e di là dal Lambro si è componita come per diverse mie ho advisato v. Ill. s. eccepto chel loco de Giusano per el quale quella mi commise ch'io supersedesse in dargli alcuna molestia per giorni sey, et così non solo ho sopraseduto per li sey giorni, ma per più di quaranta, ne mai hano perhò voluto darne una sola opera, il che oltra che poco me stimano, pare anche alli altri loci dessa plebe che gli sij fatto un poco de carico ". Domandava perciò come dovesse comportarsi, e che qualora non si volesse che quei di Giussano avessero a pagare denari, almeno gli mandassero operai come aiutanti ai maestri di muro. Il presidio mancava del necessario. Il Savana insisteva perciò nelle sue lettere perché si avessero a provvedere letti, coperte, ecc., e l'ultimo di settembre domandava di essere pagato, perché né lui né i suoi soldati avevano fino allora ricevuta paga alcuna. Di necessità egli e i soldati dovevano arrangiarsi come meglio potevano: accusati di rubacchiare in paese e nei dintorni rispondevano, e si capisce, che non era vero (505).
Il castello ebbe ancora un momento d'importanza negli avvenimenti guerreschi di quei giorni. Il 5 dicembre il Medeghino riprese Lecco al Gonzaga, e le forze ducali furono concentrate parte a Como e parte a Monguzzo " per maior securtà de quelli lochi " (506).
Il Meroni scrisse che i terrieri dei dintorni di Monguzzo ottennero dal duca (non dice quando) mediante lo sborso di dodici mila lire, di poter demolire il castello (507). Ciò non ho trovato. Il Gianetti affermò invece che nel 1672 il castello esisteva ancora abbastanza agguerrito e fortificato: nel documento citato dall'autore non si fa che riportare lo stato del castello quando venne a morire l'ultimo dei Dal Verme (508).
Il castello di Monguzzo, dopo la pace del 1532, ritornò in possesso dei Bentivoglio: demolizioni e trasformazioni avvennero via via lungo i secoli, a seconda dei gusti dei diversi proprietari, così che oggi ben poco è rimasto dell'antico castello (509).
DOCUMENTO
(Pioltello marzo 1528) (510)
Capituli quali promette lo Illustrissimo Signor Antonio de Leyva Capitaneo del Stato de Milano per la Cesarea Mayestà al Signor Io: Iacobo di Medici Castellano et Signor di Musso.
1° Promette Io preditto Illustrissimo Signor Antonio confirmare al predicto Signor Castellano il castello di Musso et la torre de Ologna et tutto il Paese, quale di presente possede per se et soi successori et detti Paesi non si habbino ad reconoscere dal Stato de Milano in alchuna cosa salvo nella superioritate del Imperatore, el Paese et laco di Como, intendendo che la detta jurisdictione non si exstenda apresso di Como a dece millia, valle Dinteler, Hosteno, Valle Solta, el Contado de Prolezza, Menasio et la Valle Arzonicha, le tre plebe, el laco di Sopra la Rivera, Valle Sassina, Valle Magrera, Monguzo, la plebe de Inzino, la corte de Casal et Vallassina con titulo de Marchese, et che lo predicto Signor Castellano possa lassare tutte le jurisdictione, terre et altre cose dette a chi a lui parità tanto suo quanto extraneo, et tanto per ultima voluntate, quanto per contracto intra vivi, et che non possa disponete come di cosa propria, alienandoli et impegnandoli senza che habbia ad richiedere la voluntate de alchuni Superiori ne anchora de la Cesarea Mayestà, purché non ne dispone in inimici de essa prelibata Cesarea Mayestà, et che possa disponete de detti loci et jurisdictione anchora in uno extraneo.
2° Promette il preditto Signor Antonio pagare al preditto Signor Castellano fanti cento ogni mese in tempo di pace per guardia del castello de Musso, in ogni tempo et siando guerra per conservatione de detto Castello et Paesi tanto de più quanto serà il bisogno et beneficio de sua Mayestad Cesarea, così venendo alli danni Soi alchuni de li Signori de la liga, che Soa Majestà lo adiuterà o vero li darà il modo de defenderse.
3° Promette il preditto Illustrissimo Signor Antonio fare bono al preditto Signor Castellano scuti vintimillia per tanto che doveva havere dal Duca Francesco Sforza. S.tà dil nuestro Signor, et Signoria de Venetia, et li quali dinari fumo spesi contra Francesi et Grisoni la maggiore parte per beneficio de la Cesarea Majestà, et non dando al predicto Signor Castellano la detta somma assignarla sopra li datii di Como, o vero in altro loco de la ratta parte che importa la intrata de detti dinari sino che sia satisfacto, o vero dargli in Alamagna altra ricompensa.
4° Che li scuti doe mille quale lo preditto Signor Castellano dee havere ogni anno da la Santità de nuestro Signor travaglierà tutto il possibile per fare che li habbia.
5° Promette lo preditto Signor Antonio al predicto Signor Castellano che per li scuti doe mille, quali li ha de dare la illustrissima Signoria di Venezia ogni anno, che possa fare tanta ripresaglia sul paese de detta Signoria che sia pagato, et in caso che prendesse il preditto Signor Castellano qualche loco o terra che li preditti Signori Veneti, dove si potesse cavare danari, che in quello caso possa scodere tanto quanto importa la intrata de li detti doe mille scuti che seriano scuti quaranta millia, ma essendo preso loco, terra, castello o vero Città del preditto Signor Illustrissimo de quelli de li detti Signori Veneti, non vole essere obligato dargli più de li scuti doe mille l'anno.
6° Promette il preditto Signor Antonio dare al preditto Signor Castellano di presente la terra di Lecho et soa jurisdictione et il ponte libero in dono et senza altro obstaculo.
7° Che darà al predicto Signor Castellano per esso et suoi figlioli venendo al servitio de la Cesarea Majestà una pensione honesta tanta che se contentarà.
8° Chel predicto Signor Castellano, soi fratelli, Gentilhomini et Soldati, che sono appresso di soa Signoria serano liberati da ogni bando et altre condemnatione potesseno havere sino al dì de oggi et che li serano restituiti li soi beni liberamente, et che li possano goldere così, stando apresso di lui, come se si ritrovasseno in altra patria, con questo che li habbia ad nominare in termino de giorni octo.
9° Che harà un loco nei Senato per un suo Fratello.
10° Che li concederà ampio Privilegio di potere battere denari nel castello de Musso.
11° Promette lo preditto Illustrissimo Signor Antonio al predicto Signor Castellano che non li serà sminuito alchuno datio così di mercantia et di sale come di altro di quello ha nel paese di presente.
12° Che alchuno non se harà impazare de li soi subditi ne in soi beni de detto Paese.
13° Che venendo esto preditto Signor Castellano in guerra con Grisoni, per essere al servizio di soa Majestà o per altro, che el Paese che pigliasse alla spesa sua sia suo libero, et pigliandosi alla spesa de soa Majestà che il Contado de Chiavena et Valle sia suo.
14° Che darà al Signor Fortunato Cusano una pensione scuti ducento l'anno.
15° Che se alcuno o sia subdito di presente o venesse alla servitù di soa Majestà Cesarea et che si pretendesse habere ragione in alcuna cosa o castello o terra o valle de le preditte di sopra, promette lo preditto Signor Antonio al preditto Signor Castellano che la Cesaera Majestà darà alli prefati o a qualunche dessi pretendenti habere ragione sopra essi loci, castelli, Terre et Valle altra ricompensa in loco dessi, et che al preditto Signor Castellano per tal cosa non serà dato molestia.
16° Promette dare una honesta pensione alli Capitanei del preditto Signor Castellano et maximamente ali Capitanei Io: Mella et Nicola.
17° Che lo preditto Signor Castellano non serà astrecto condure soldati senza che siano pagati.
18° Che occorrendo alla prelibata Majestà per qualchi besogni soi iassare el Stato de Milano, o per pace o per altro, al Duca Francisco Sforza, o al Rey Christianissimo o ad altra persona, che soa Majestà reserverà lo predicto Signor Castellano con li soprascripti capituli.
19° Promette lo predicto Illustrissimo Signor Antonio al predicto Signor Castellano de fare dare da la Majestà Cesarea uno cambio al Signor Hieronimo Morono in loco di Lecho.
20° Che di presente lo illustrissimo Signor Antonio confirmarà el tutto come di sopra et più li dà lo squadron, lo medemo farà il Signor Gaspar Frontzperg Colonello de Alamani, et anche promette che il serenissimo Rey de Ungaria et lo regimento de Hispruch conferirà tutto lo soprascripto in tempo honesto, et che soa Majestà mandarà la confirmatione del tutto per soi privilegi in tempo honesto.
1° Promette lo predicto Signor Castellano, venendo alli servitù de la prelibata Cesarea Majestà, che in termino de sei di proximi pigliarà licentia da Francia et Venetiani et da qualunque altro ad chi fosse obligato, et serà amico de li amici et inimico de li inimici de soa Majestà et servirà lealmente et non mancherà del debito suo.
2° Promette il preditto Signor Castellano di dare il passo aperto per la via de Alamagna, venendo il soccorso di Soa Majestà, et farlo passare liberamente et dargli victualie per soi denari, et condurlo dove lo illustrissimo Signor Antonio vorrà.
3° Item promette de dare tre mille sacchi di frumento, sichale, et millio per condurlo dove vorrà la excellentia del predicto Signor Antonio qual li sia poi pagato honestamente.
4° Item promette somme doe mille di sale et mandarle come di sopra, qual li siano pagate come di sopra.
5° Promette de tenire il passo aperto acciò che li Mercadanti possano andare liberamente a comprare de ogni sorte Victualie et Grassi et condurli ad Milano, a Como et in ogni lochi sottoposti alla cesarea Majestà.
6° Item che serva di presente alla Cesarea Majestà con fanti mille et cavalli cinquanta a soe spese dove serà bisogno.
7° Item promette come di sopra essere leale et fidele al Imperatore et al predicto Illustrissimo signor Antonio et fare quanto li serà comandato per servitio di soa Majestà.
8° Item promette el predicto Signor Castellano che per osservatione et adimpimento de le predicte cose consignarà, per obstagio al predicto Signor Antonio, Domino Gabriel suo fratello, quale andarà dove il predicto signor Antonio vorrà, et che il Signor Io: Baptista tambene suo fratello starà apresso di soa Excellentia servendo al modo li serà ordinato da soa ilustrissima Signoria, et pro fide de le predicte cose lo preditto illustrissimo Signor Antonio et lo Signor Io: Baptista di Medici, come mandatario del Signor Io: Iacobo suo fratello et per lo quale ha promesso de ratto, si sono sottoscripti di soa mane propria a dì ultimo marzo 1528 in Pioltello. Superscriptum Antonius de Leyva et Io: Baptista De Medici et sigillata utriusque infra erat. Quoniam convenire cum originali comperii in fidem manu propria scripsi signatum Politianus.
Conforme à la copie
WYNANTS, 1787.
|
 |
|
|
|
|
|
|
|

